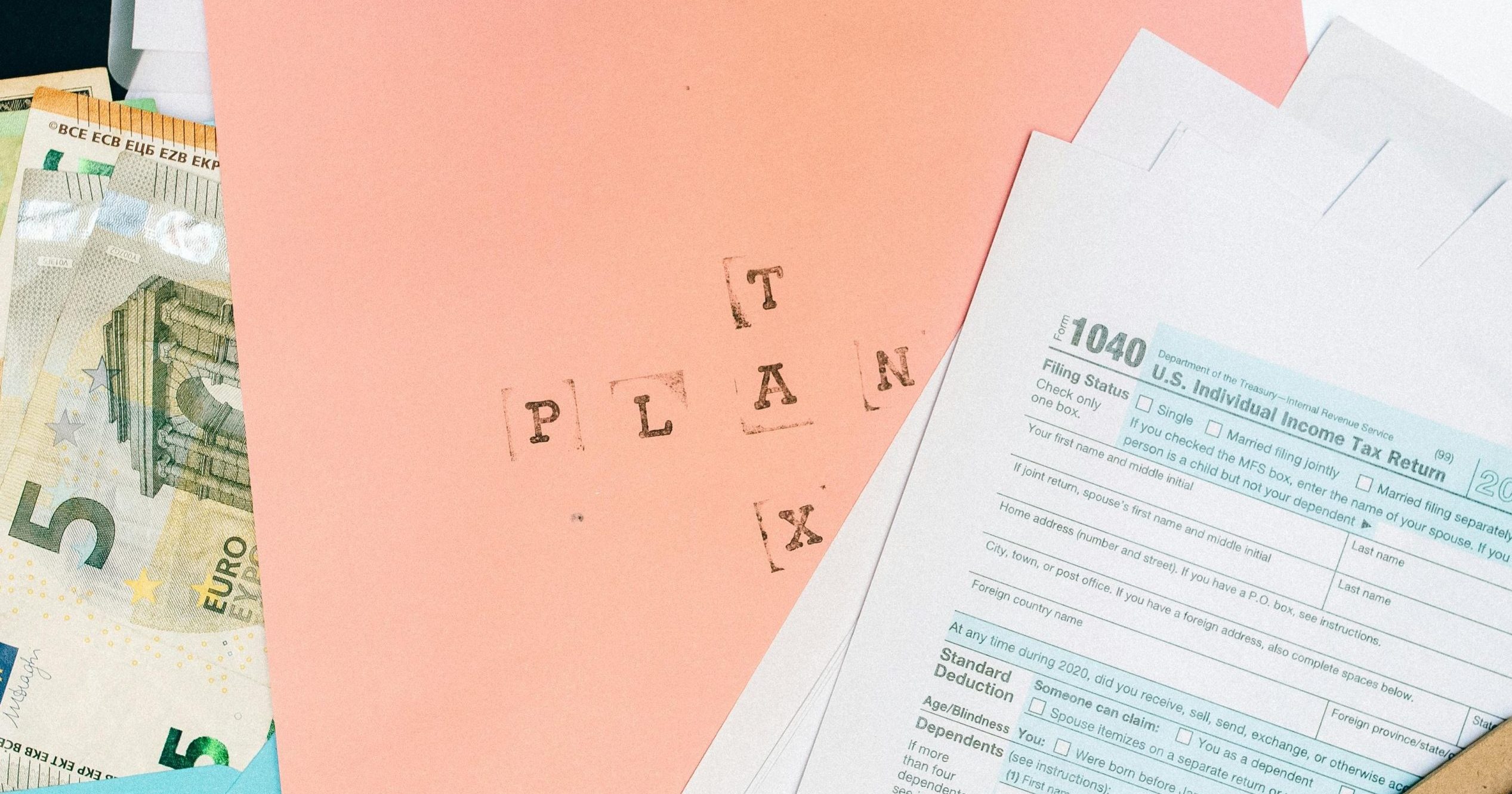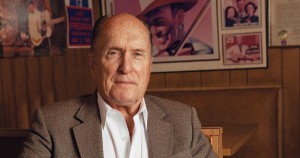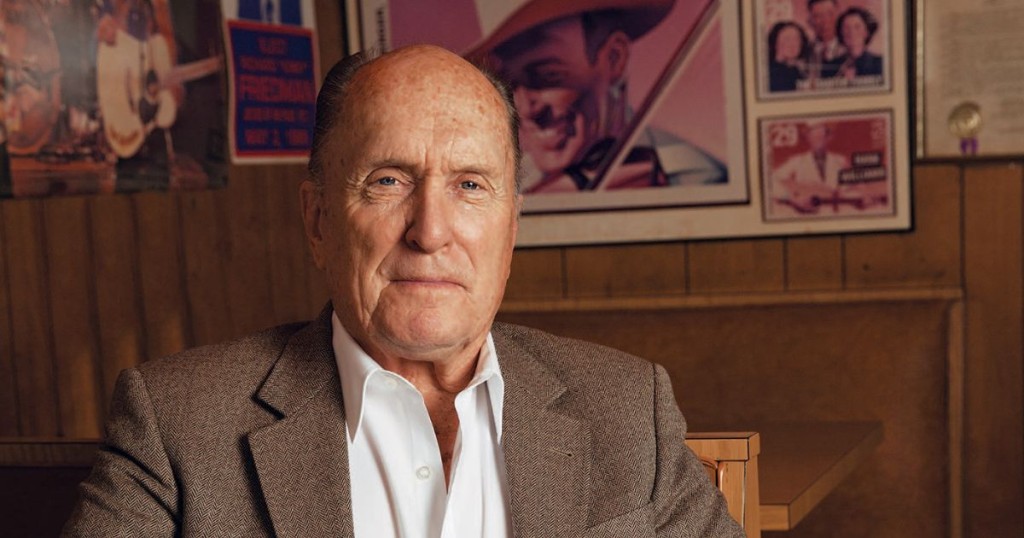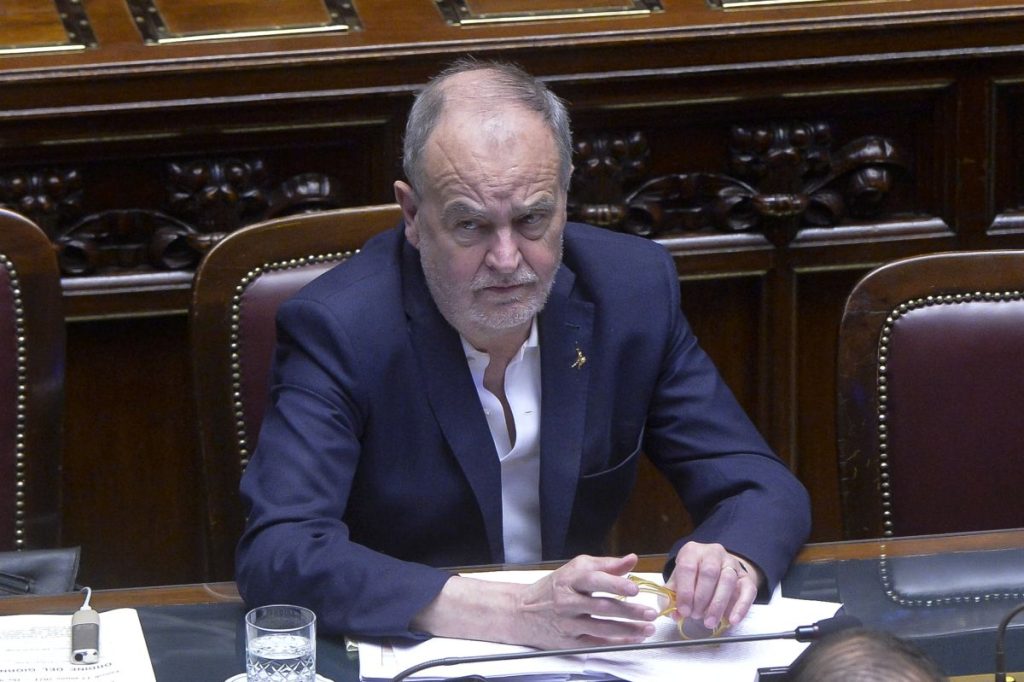La Direttiva Ue potrebbe favorire le categorie più svantaggiate, attenuando per esempio la differenza fra uomini e donne
Entro giugno 2026 stipendi e salari dovranno essere trasparenti e accessibili, sia nel settore pubblico che in quello privato. E’ la nuova direttiva europea – la 2023/970 – destinata a fare molto rumore, o almeno ad indurre grande sbigottimento. La decisione dell’Unione europea mira a colmare il gender gap, ossia quel differenziale che persiste tenacemente nei trattamenti economici di donne e uomini. A parità di attività e funzione, ci dicono i dati, le dipendenti hanno infatti una retribuzione inferiore ai loro colleghi maschi.
In particolare, le aziende saranno tenute a indicare l’entità degli stipendi già negli annunci di lavoro, mentre non potranno più chiedere ai candidati quanto guadagnavano precedentemente. Le imprese con almeno 100 dipendenti, inoltre, saranno tenute a rendere pubbliche le differenze retributive superiori al 5%, a pena di obblighi correttivi e possibili sanzioni.
I lavoratori, oltre a non avere più il divieto di divulgare la propria retribuzione, potranno chiedere di sapere l’ammontare della retribuzione del collega o della collega che svolge le stesse mansioni; il datore di lavoro è obbligato a rispondere entro e non oltre due mesi, in modo preciso e completo.
La pubblicizzazione delle buste paga dovrebbe ridurre gradualmente le differenze retributive per genere, portando a un’equiparazione fra i due sessi. Ma soprattutto nei paesi mediterranei – Francia, Spagna, e Italia – le differenze retributive separano anche i lavoratori maschi fra di loro. Con la trasparenza infatti emergerebbe un sottobosco di clausole, privilegi, attribuzioni di varia natura e discutibile giustificazione che moltiplicano le differenze anche fra chi svolge funzioni analoghe.
Avremo dunque un’inevitabile fase di rivendicazione pulviscolare in cui ogni lavoratore, usando il caso del collega meglio retribuito solleciterà un’equiparazione al livello superiore. E avremo anche una tendenza intersettoriale, in cui questa equiparazione diverrà inevitabile fra aziende e territori diversi. Non siamo più alle gabbie salariali, dove erano codificate differenze rilevantissime fra regioni e città del Sud rispetto a quelle del Nord. Ma sicuramente le ricerche sia previdenziali che di origine sindacali ci parlano di profonde differenze fra aziende private e pubbliche, oppure, nel campo privato, di regioni diverse, dove sono riscontrabili istituti contrattuali, o indennità informali che rendono poi la retribuzione netta molto diversa fra lavoratori con mansioni analoghe.
Tanti più che oggi la norma europea, che metterà in sommovimento le sollecitazioni che abbiamo descritto, arriva nel pieno di una rivisitazione complessiva della stessa concezione di lavoro e produttività.
L’intervento di risorse di intelligenza artificiale, e più in generale di spinte all’automatizzazione produttiva sta re-ingegnerizzando i comparti sia industriali che dei servizi, spostando il baricentro produttivo dalle semplici attività umane a un’inedita combinazione di pratiche dirette dei lavoratori e di scie digitali che gli stessi lavoratori inducono con la tracciabilità dei dati che depositano nei data server aziendali e delle soluzioni e accorgimenti che applicano al processo di digitalizzazione.
Lo stipendio, per richiamare un concetto di antica memoria, simbolo del lavoro garantito, ormai sarà sempre più il risultato di un valore aggiunto generale, più che di un risultato individuale che ogni singolo lavoratore genererà.
In questo gorgo in cui l’abbattimento delle discriminazioni di genere e il disboscamento della giungla di personalismo porterà ad una maggiore trasparenza e semplicità nel calcolo delle retribuzioni dovremo anche interrogarci sul destino della rappresentanza sindacale. Stiamo imboccando una strada che ci conduce ad un’individualizzazione esasperata delle relazioni sul posto di lavoro, oppure la trasparenza e affinità dei trattamenti retributivi valorizzerà la dimensione di comunità dell’unità produttiva?
E’ un quesito fondamentale sia ai fini delle trasformazioni tecnologiche che anche dell’evoluzione democratica. La nostra Costituzione lega strettamente proprio la natura della democrazia alla dinamica degli interessi e alla rappresentatività delle forze sociali. Un buco in questa rete relazionale che abbassi ancora di più il protagonismo delle componenti economiche inevitabilmente ci costringerà a mettere mano all’impianto costituzionale, sostituendo il lavoro nella sua proiezione di fattore democratico con il sapere come funzione primaria delle relazioni sociali. Un passaggio che per certi versi era persino stato già previsto dallo stesso Carlo Marx che in quell’intricatissimo testo che sono i Grundrisse, scritto per altro prima del noto Capitale, aveva annunciato che nella progressione tecnologica “il lavoro sarebbe stata ben misera cosa nella valorizzazione delle merci”.
Un’affermazione che viene oggi ancora rimossa dalle culture della sinistra e che potrebbe invece aprire una proficua discussione su come riproporre nella società digitale una vitale dialettica che rimetta in piedi la democrazia rappresentativa oggi cosi prostrata sotto gli attacchi del plebiscitarismo sovranista.
Ci pare dunque che la norma europea nella sua apparente limitatezza possa aprire un percorso quanto mai ricco e vitale per l’intera cultura democratica del nostro continente. E forse non solo di quello.