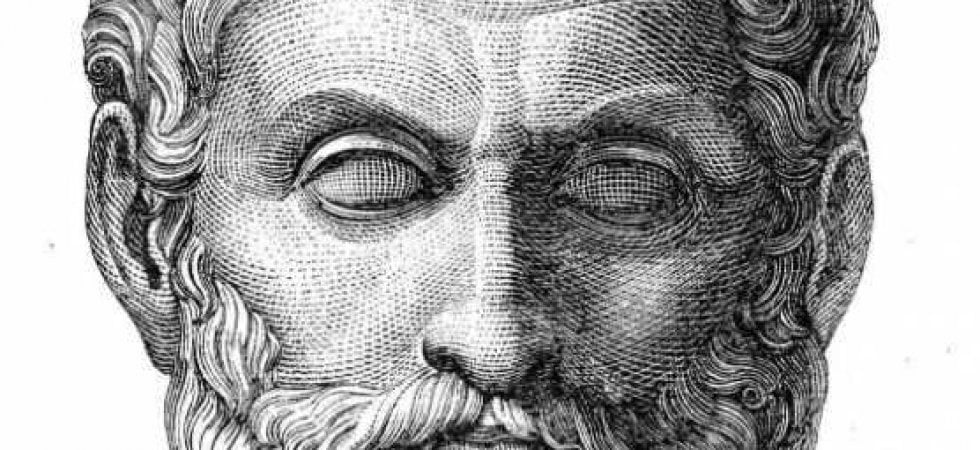Quattro secoli prima di Cristo, un filosofo siciliano teorizzò l’importanza delle parole
Dalla metà del V secolo a.C., Atene diventa il cuore pulsante del mondo greco. Sotto la guida di Pericle, la democrazia si afferma come governo del discorso, e la parola diventa lo strumento principe della vita pubblica. La città brulica di voci, gesti, confronti: nelle piazze si disputa, nei simposi si argomenta. La parola è ovunque. Non è solo mezzo di comunicazione: è azione politica, seduzione, sapere, potere. Parlare bene significa convincere, decidere, governare. In questa città che ha fatto del discorso il perno della vita pubblica, compare una figura nuova: il sofista. Non il filosofo che cerca la verità, ma l’esperto che insegna a usare il linguaggio. Un maestro del possibile, più che del vero. Un uomo del tempo, non dell’eterno.
Dopo la musica delle sfere di Pitagora, il fuoco di Eraclito, la danza degli elementi di Empedocle e il canto segreto dell’acqua di Talete, Gorgia rappresenta una svolta radicale, anche rispetto a Protagora. Là dove quest’ultimo faceva dell’uomo la misura di tutte le cose, Gorgia mostra che è il linguaggio a plasmare l’uomo e il suo mondo. Il suo pensiero non guarda all’origine, ma al limite: alla soglia in cui il linguaggio non pretende più di dire la verità dell’essere, ma espone se stesso come forza, come artificio, come potere di persuasione. Pochi hanno saputo mostrare quanto la parola possa essere potente e insieme vuota. Nato a Leontini (oggi Lentini, in provincia di Siracusa) attorno al 485 a.C., Gorgia fu ambasciatore, retore, pensatore. Arrivò ad Atene portando con sé uno stile inedito: spezzato, simmetrico, allitterante; un linguaggio ritmico, scolpito come un’incisione in miniatura, capace di incantare e disorientare, sedurre e ferire. Il suo insegnamento non si fonda sui contenuti, ma sulle forme. E proprio nella forma si cela una riflessione filosofica radicale: la verità non è un contenuto stabile, ma un effetto prodotto dalla forma del discorso. Di lui ci restano frammenti di alcuni suoi discorsi – Elogio di Elena e Difesa di Palamede – e un breve trattato filosofico, Sul non essere o sulla natura, di cui Sesto Empirico ha conservato un lungo e articolato passaggio. Le sue tesi fondamentali sono tre: “Nulla c’è. Se anche qualcosa c’è, non è conoscibile dall’uomo. Se anche è conoscibile, è incomunicabile agli altri”. È la formulazione estrema di una crisi: quella del linguaggio come veicolo della verità. L’essere non è accessibile, il pensiero non lo coglie, la parola non lo trasmette. Si rompe così il triangolo classico: essere, pensiero, linguaggio. Gorgia non nega il mondo: ne denuncia l’inattingibilità. La parola, come un phármakon, cura o avvelena. Non rappresenta: trasforma. La verità cede all’efficacia. Ma non per cinismo. La sua retorica è tragica, consapevole della distanza tra ciò che è e ciò che appare. Nell’Elogio di Elena, non si limita a negare la colpa dell’eroina: la dissolve. Elena fu travolta da forze che eccedono la volontà; fu sedotta dalla parola, dalla bellezza, dal fato. Come darle torto? La retorica non impone: dischiude possibilità. È un’arte della visione molteplice, che accetta il disordine del mondo senza cedere al disincanto. Gorgia non è un nichilista: è un artista del linguaggio. La verità si sottrae, ma la parola sopravvive. Parlare significa far sorgere mondi che durano lo spazio di un discorso, eppure capaci di persuadere. Ogni parola detta è già una scelta, una responsabilità. Ma cos’è un sofista? Il termine, in origine, indicava il sapiente.
Con Platone e Aristotele, diventa polemico: il sofista è colui che manipola, che vende sapere, che confonde le apparenze con la verità. Eppure, i sofisti furono i primi a portare la riflessione sul linguaggio, sul valore delle norme, sull’educazione come trasformazione. Il sofista, in questo contesto, non è semplicemente un oratore: è colui che mette in discussione l’idea tradizionale di sapere. Insegna a dubitare, a guardare il mondo da più punti di vista, a costruire discorsi efficaci anche in assenza di verità assolute. Per questo è figura ambigua: genio del linguaggio o corruttore della gioventù? Gli stessi ateniesi oscillano tra fascino e sospetto.
Sarà Platone, con forza polemica e rigore speculativo, a delinearne il ritratto più potente e controverso. Nel dialogo Gorgia, Platone mette in scena uno scontro frontale tra due modi di intendere la parola. Da un lato Gorgia, sostenitore della retorica come arte della persuasione; dall’altro Socrate, che cerca un logos veritativo, capace di guidare l’anima verso il bene. Gorgia ammette che la retorica può produrre convinzione anche in assenza di sapere. Socrate obietta: se non distingue tra vero e falso, non è arte, ma simulacro. Ma il dialogo non si ferma lì. Intervengono anche Polo, giovane discepolo entusiasta, e soprattutto Callicle, figura inquieta e potente. Callicle afferma che la legge naturale è il dominio del più forte, che la giustizia è una convenzione dei deboli. Socrate resiste. Ma il lettore resta sospeso. Non c’è confutazione definitiva. Platone lascia aperta la ferita: la parola può costruire mondi oppure distruggerli. Proprio questo confronto rivela l’ambivalenza più profonda: la parola può condurre alla giustizia o all’inganno. Può curare o corrompere. Nel corso del dialogo, Socrate smaschera i limiti della retorica, ma al tempo stesso ne riconosce l’enorme potere. L’accusa implicita non è solo contro Gorgia, ma contro una stagione del pensiero in cui l’efficacia del dire ha oscurato la ricerca del vero. La polemica di Platone è severa, ma Gorgia resta un interlocutore necessario. Senza il sofista, non si capirebbe il filosofo. Senza il seduttore del discorso, non si potrebbe fondare il dialogo. E forse proprio questa tensione tra l’arte del convincere e la ricerca del vero costituisce l’essenza stessa del pensiero occidentale. A questa tensione tra forma e verità ha dedicato pagine esemplari Giorgio Colli in Gorgia e Parmenide (Adelphi 2003), raccolta di lezioni magistrali, filologicamente impeccabili e filosoficamente acuminate. Colli non legge in Gorgia un distruttore irresponsabile, ma un pensatore che svela la natura formalistica del logos: ogni discorso è costruzione, ogni verità è già figura retorica. Con finezza analitica, mostra come Gorgia metta a nudo la fragilità strutturale della parola, senza per questo abbandonarsi alla dissoluzione.
Anzi, proprio questa consapevolezza permette di riflettere con rigore sul rapporto tra apparenza e pensiero, senza illudersi su fondamenti assoluti. Gorgia, per Colli, non è l’ombra della filosofia: è la sua soglia critica, il suo contrappunto necessario. Questa lettura consente di sottrarre Gorgia al luogo comune del sofista vuoto e superficiale. In realtà, la sua retorica è una forma di pensiero sulla parola, una ricerca sulle sue potenzialità e i suoi limiti. Gorgia non distrugge la verità: ne denuncia il carattere retorico, storico, situato. Oggi più che mai, nella civiltà dell’algoritmo e dei social network, la lezione di Gorgia si fa urgente. In un mondo saturo di parole, dove tutto è comunicazione ma sempre meno è comprensione, il sofista ci obbliga a tornare alla domanda fondamentale: che cosa accade quando parliamo? Ogni slogan, ogni discorso, ogni gesto linguistico produce effetti. Seduce, semplifica, orienta. Ma chi educa al linguaggio? Chi insegna la responsabilità del dire? Chi ha ancora il coraggio di porre la questione del significato, del valore, del peso delle parole? Lontano dal nichilismo e dalla manipolazione, Gorgia ci insegna ad abitare l’incertezza del discorso. Non per rinunciare alla verità, ma per cercarla sapendo che essa è fragile, contestata, situata.
Perché — come scrive Paul Valéry — “la parola è una pericolosa padrona”, e solo chi ne conosce l’ambivalenza può sperare di non diventarne schiavo. Pensare Gorgia oggi significa interrogarsi sul senso stesso del discorso pubblico, sull’uso della parola nella politica, nell’educazione, nei media. Significa domandarsi se sia ancora possibile distinguere tra verità e persuasione, o se sia più onesto riconoscere la loro intima complicità.
Gorgia non ci insegna a rinunciare alla verità, ma a diffidare di ogni suo possesso definitivo. Non ci offre una dottrina della verità, ma una lezione sulla parola: sul suo potere di costruire il mondo, di orientare il pensiero, di piegare l’evidenza. Nell’epoca della post-verità, dove l’opinione si scambia per fatto e la manipolazione per libertà, il pensiero di Gorgia si fa passaggio, varco, eco. Forse il pensiero più profondo non ruggisce, ma sussurra: leggero, eppure ineludibile.