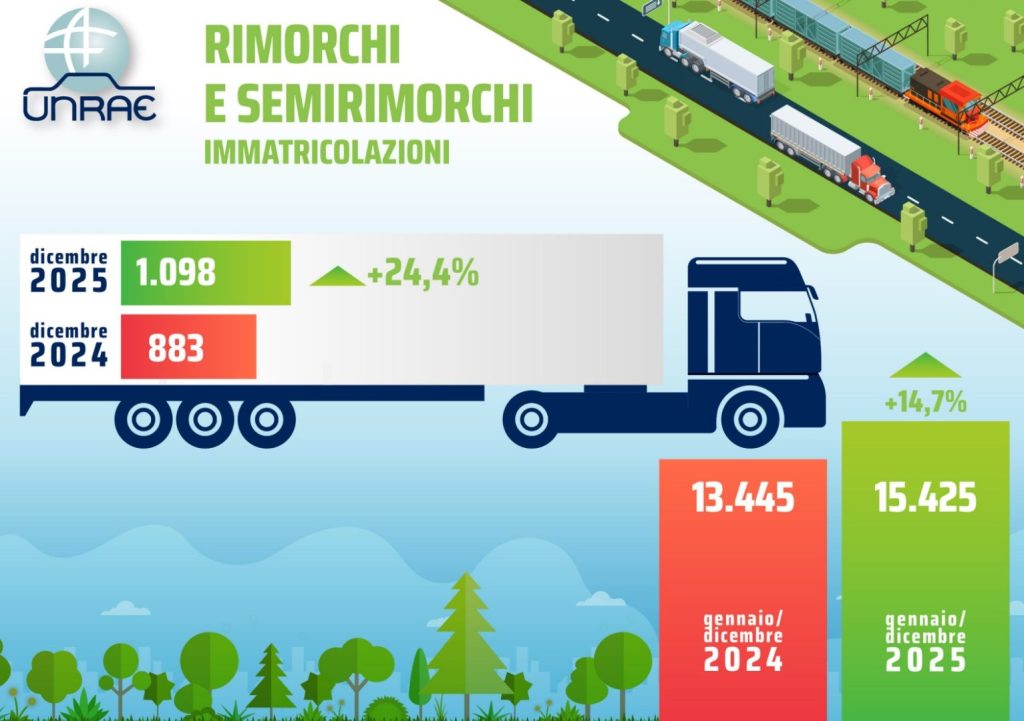Anche nell’era di quelle virtuali, continuano ad essere un centro di gravità emotiva e sociale dove la comunità si riconosce e si racconta
Bambini che giocano, anziani che chiacchierano, turisti che fotografano e studenti che leggono seduti al tavolino di un bar. Semplici istantanee di vita quotidiana raccontate e vissute da un’unica voce narrante: la piazza.
Luoghi simbolici e identitari di una collettività, ambienti di mercato e spazi di intensa vita sociale dove si scambiano le merci e circolano le notizie. Le piazze sono da sempre i canali privilegiati dove la storia si intreccia con il presente, raccontando e nutrendosi del volto e dello sguardo di chi le vive, anche solo per un istante. In un’epoca in cui la vita urbana sembra sempre più frenetica, virtuale e individualista, dove appaiono dominare incontrastati i luoghi virtuali, le piazze continuano ad essere centro di gravità emotiva e sociale dove la comunità si riconosce e si racconta, in cui si incarnano le più significative memorie storiche, e dove l’imprevisto è ancora possibile.
La storia delle piazze è un concentrato di stratificazioni materiali e umane, di progetti urbani e architettonici, di rappresentazioni iconografiche, perché le persone non si limitano a “usare” le piazze: le abitano, le attraversano, le trasformano. Le stagioni fondamentali delle piazze italiane sono il Medioevo, il Rinascimento e il Barocco. L’epoca Barocca e quella ottocentesca percorrono la strada aperta dalle iniziative rinascimentali. Ci sono le piazze del potere politico, che ospitano le istituzioni pubbliche, come a Firenze quella della Signoria; le piazze della Chiesa e delle ritualità religiosa e le piazze del mercato, laiche e mercantili, di incontro e scambio, come Piazza Venceslao a Praga, costituita nel 1348 come mercato dei cavalli, e Alexanderplatz a Berlino, nata come mercato di buoi. Non meno importanti sono quelle piazze che raccontano le storie dei roghi dei condannati all’Inquisizione e quelli dei libri proibiti. È questa la lunga e drammatica storia di Piazza Campo de Fiori a Roma.
Se la piazza nasce come luogo di relazione e di scambio assumendo le caratteristiche di primo spazio aperto di tipo collettivo, cresce e si sviluppa anche come uno spazio denso di regole e armonia derivanti dalla storicità della sua formazione. Tutto questo accade perché le piazze sono un prodotto umano e come tale si adattano alle necessità e ai bisogni dell’uomo, modificandosi con le sue idee e la sua visione del mondo.
I greci le chiamavano “agorà” e per loro erano il fulcro del potere religioso, del commercio e degli scambi. L’agorà descriveva bene il ruolo essenziale di questo spazio urbano nel rapporto tra cittadini e vita pubblica. Era il microcosmo della polis, di cui Aristotele, scindendo le due realtà, sembra rimpiangere la perdita, perché snaturata e ridotta, ai suoi tempi, in puro spazio destinato a scambi commerciali. Un luogo accessibile a tutti: qui si tenevano le assemblee, venivano prese le decisioni politiche ed emesse le sentenze, si svolgevano i mercati e le contrattazioni. È il luogo dove Socrate filosofeggiava e dove la democrazia è nata.
Nell’Antica Roma, la piazza principale era il foro romano, che aveva il ruolo di monumento della civiltà, centro della vita della comunità stessa, uno spazio maestoso e pulito in cui affacciavano i palazzi più importanti. Vi erano la curia dove si riuniva il senato, i templi, i tribunali, le sale di consiglio e piazzali circondati da monumentali porticati, dove gli oratori arringavano le folle. Il foro romano anticipa tendenze medievali: la piazza, luogo chiuso e distinto, accosta i palazzi del potere e i luoghi di culto.
Accade così che nella città di Todi, il potere religioso e civile si spartiscano la stessa piazza sorta sulle ceneri dell’antico foro: da una parte c’è il monumentale complesso degli edifici laici, tra cui i Palazzi del Podestà e del Capitano del Popolo, dall’altra il duomo.
Dopo la parentesi buia delle invasioni barbariche, la rinascita delle piazze è collegata alla riapertura delle vie commerciali tra Occidente e Oriente, favorita dalle crociate. Come già era avvenuto nel foro romano, anche la piazza medievale si caratterizzava in molti casi come centro privilegiato per le attività commerciali. A ricordare questa particolare destinazione d’uso restano tracce architettoniche di antiche botteghe, o toponimi sopravvissuti ai mutamenti urbanistici. È il caso dei due comunissimi nomi di Piazza delle Erbe e Piazza del Mercato, presenti un po’ ovunque nelle città medievali d’Italia. La piazza dentro le mura e le mura intorno alla piazza: sono questi i due elementi urbanistici che rappresentavano la piazza comunale nel medioevo, nella sua interezza e nella sua autonomia, in netta contrapposizione al contado e al territorio extramoenia. Inoltre, sotto il magistero criminale del feudatario, le esecuzioni punitive venivano attuate sotto l’occhio vigile dell’intera popolazione, attraverso la loro spettacolarizzazione, e il luogo deputato a tutto questo era la pizza.
Si trattava di punizioni simboliche, che dovevano servire da monito per il pubblico, atteso che in tal modo la stretta connessione illecito-pena rimaneva ferma nella memoria collettiva, inibendo l’individuo dal delinquere.
Ma, nel medioevo, la piazza, da sempre luogo d’incontro religioso con la sua cattedrale, fulcro politico e commerciale con i suoi palazzi pubblici, non era non soltanto un baricentro urbano e un punto di riferimento per la vita della collettività, ma anche un monumento a sé, un luogo simbolo che vive di vita propria.
Lo testimonia il fatto che le piazze furono il luogo privilegiato dell’azione di San Francesco d’Assisi, spazi in cui il suo messaggio prese forma concreta e pubblica. Dalla spogliazione dinnanzi al vescovo Guido I, che sancì la rottura con il mondo materiale, alla predicazione. Le piazze divennero in tal modo il crocevia della parola di San Francesco, testimoniando il legame tra la religiosità francescana e la comunità.
Tra Ottocento e Novecento, la piazza assume nuove valenze e anche nuovi connotati. Sono le piazze del tempo libero e della socializzazione, con giardini e caffè, ispirate agli esempi provenienti dalle capitali europee. Per poi adottare caratteri assai diversi nel corso del Novecento con un’evoluzione scandita da salti e da rotture. Esemplare è l’appropriazione dei luoghi pubblici messo in atto dalle folle in rivolta contro il caroviveri nel corso dei tumulti annonari del 1919.
Nelle piazze della storia, uomini e donne hanno da sempre celebrato il potere o hanno preso la parola per contestarlo; hanno chiesto pane, diritti, giustizia. Perché la piazza, come spazio libero e aperto, ha permesso di superare alcune interdizioni legate a particolari visioni dell’essere umano e del suo rapporto con la parola, in ragione delle limitate possibilità di accesso all’istruzione, che ad esempio scoraggiavano fortemente l’esposizione delle donne. Luoghi di tensioni e di rivendicazioni, a volte purtroppo destinate a deflagrare in maniera inaspettata e dannosa per l’intera collettività. Era questo il volto di Piazza Fontana, collocata in quello slargo arioso nel cuore di Milano, alle spalle del Duomo, prima di diventare il simbolo tragico nella storia d’Italia, quel pomeriggio del 12 dicembre 1969.
È così che le piazze, luoghi di celebrazione e di protesta, di commercio e di scambio di idee, sono da sempre il teatro di tensioni sociali e di grandi trasformazioni.
Perché la storia insegna che le piazze sono anche un termometro politico. Luoghi per eccellenza per le strategie di consenso della propaganda politica. Emblematiche, in quest’ultimo senso, sono le piazze del fascismo, un simbolo della capacità del regime di mobilitare il popolo italiano. Ma anche spazi del dissenso e della partecipazione democratica: dalle manifestazioni antifasciste alla Resistenza, dalle rivolte operaie agli scioperi studenteschi, dalle proteste femministe ai movimenti contemporanei per il clima. Non meno importanti, le immagini dei comizi degli anni Settanta e Ottanta in Italia che raccontano le lotte per il divorzio, gli asili nido, la parità sul lavoro, il nuovo diritto di famiglia e la tutela della salute. Immagini che sono anche una testimonianza visiva delle battaglie portate avanti dalle donne che hanno contribuito a trasformare il loro ruolo nella società italiana. È così che la piazza è sempre stata uno spazio di parola pubblica.
Eppure, guardando alla nascita e allo sviluppo del movimento delle madri dei detenuti e degli scomparsi in Argentina durante la dittatura militare guidata dal presidente Isabel Martínez de Perón, ecco che la piazza assume un alto valore simbolico, diventando la Plaza de Mayo lo scenario per denunciare i crimini della giunta militare, assurgendo a simbolo di opposizione al potere militare in atto. Ne sono altri esempi storici anche Piazza Tienanmen a Pechino, simbolo della lotta per la democrazia; così come Piazza di San Francisco in Cile espressione viva della protesta contro il regime di Pinochet, diventando un luogo di raccolta per la resistenza.
Ultime, ma solo in ordine di tempo, sono le immagini delle piazze israeliane sostenute dal coinvolgimento attivo dei cittadini delle realtà locali sparse in tutto il mondo. Così, l’agorà quale spazio originariamente neutro, via via si istituzionalizza, fino a diventare piazza civica.
Oggi, le nuove piazze sono i social network, dove ci s’incontra, si parla, si gioca, ma senza incontrarsi, senza parlarsi, senza giocare davvero. Sono i centri commerciali, diventati i luoghi nei quali restituire fisicità alle relazioni. Ma né gli uni, né gli altri hanno di fatto sostituito le piazze, piuttosto ne hanno surrogato le funzioni. Perché, se sappiamo metterci in ascolto, le piazze possono ancora parlare e dirci un sacco di cose: svelarci segreti, raccontarci storie eccezionali, fatti tragici, episodi festivi, esistenze uniche, narrazioni nate dalla fantasia di grandi scrittori o più semplicemente la vita di una comunità che giorno dopo giorno ha lasciato qui la propria impronta. Diamo quindi la parola a questi luoghi, perché ci mostrino la loro identità.