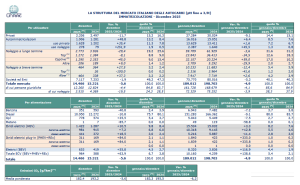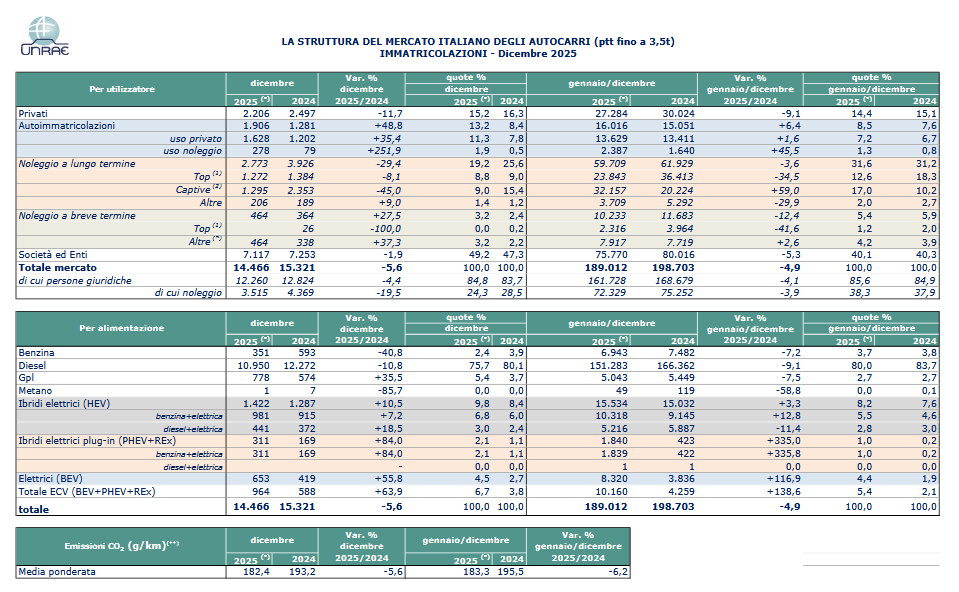Negli ultimi anni i rapporti tra l’Europa – e in particolare alcune sue istituzioni e agenzie italiane – e i paesi del Sud Asia (India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Afghanistan) si sono trasformati in una rete complessa di cooperazione sanitaria, ricerca e interventi umanitari. Non si tratta soltanto di trasferimenti di risorse: si delineano intrecci tra interessi industriali, priorità di salute pubblica e aspettative di sviluppo locale che richiedono approcci nuovi e più bilanciati.
Sul piano della ricerca, le collaborazioni con l’India rappresentano oggi uno dei nodi strategici: accordi bilaterali e iniziative congiunte puntano a rafforzare innovazione vaccinale, studi sulle malattie infettive e monitoraggio della resistenza antimicrobica.
Queste attività valorizzano competenze complementari, ma mostrano anche il rischio che la leadership scientifica resti sbilanciata a favore dei partner europei se non accompagnata da clausole chiare su proprietà dei dati, accesso ai risultati e trasferimento tecnologico. Le catene globali di produzione farmaceutica, emerse con forza durante la pandemia, hanno rivelato la dipendenza europea da forniture asiatiche per principi attivi e antibiotici, mettendo in luce la necessità di politiche che rendano le filiere resilienti senza spezzare rapporti commerciali strategici.
La cooperazione italiana si manifesta su più livelli: dai progetti umanitari e di emergenza (come l’assistenza ai rifugiati in Bangladesh) ai programmi di capacity building e formazione professionale in Pakistan e Nepal, fino agli interventi di supporto sanitario mediato da agenzie internazionali in Afghanistan. L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e altri enti pubblici hanno finanziato interventi che vanno dalla salute materno-infantile alla ricostruzione di servizi sanitari, spesso in partnership con Ong locali e istituti di ricerca. Tuttavia, la persistenza di finanziamenti a breve termine e la frammentazione progettuale limitano la sostenibilità degli esiti.Analizzando i singoli contesti emergono scenari diversi ma interconnessi.
L’India ha fatto progressi importanti in indicatori chiave come aspettativa di vita e mortalità infantile, ma la variabilità territoriale e il peso simultaneo di malattie trasmissibili e cosiddette NCD (malattie non trasmissibili) rimangono sfide di fondo. Il sistema è un mosaico pubblico-privato con recenti riforme volte a estendere la copertura assicurativa e digitalizzare i servizi; resta però il problema della disomogeneità qualitativa e dell’accesso nelle aree rurali.
In Pakistan, i servizi sanitari subiscono l’effetto della forte frammentazione amministrativa: dopo processi di devoluzione, la qualità e l’equità delle prestazioni variano sensibilmente fra province. Il settore pubblico è sottofinanziato, la spesa out-of-pocket grava sulle famiglie, e benché esistano programmi innovativi (ad esempio schemi di assicurazione sociale locale e una rete di operatori sanitari comunitari), la sfida è scalarli e uniformarli.
Bangladesh e Nepal testimoniano progressi significativi in termini di mortalità materno-infantile e coperture vaccinali, pur affrontando il “doppio carico” epidemiologico: le NCD aumentano mentre fardelli infettivi permangono. Il Bangladesh si confronta con l’altissima densità e le crisi umanitarie (tra cui l’accoglienza dei rifugiati), che mettono sotto pressione infrastrutture e servizi; la risposta è spesso affidata a Ong molto strutturate e reti comunitarie. Il Nepal deve invece fare i conti con un territorio montano e una popolazione dispersa: la sfida è rendere i servizi accessibili in un contesto geografico complesso, rafforzando al contempo la governance e i percorsi di riferimento sanitario.
L’Afghanistan rappresenta il caso più critico: anni di aiuti esterni, il collasso di parte della cooperazione internazionale e le restrizioni che colpiscono in particolare l’accesso delle donne alle cure hanno lasciato vaste lacune assistenziali. Molti servizi essenziali sopravvivono solo grazie a interventi umanitari temporanei e a poche organizzazioni ancora operative; la stabilità del sistema resta altamente vulnerabile a shock politici e finanziari.
Da questo quadro emergono punti fermi per ripensare la cooperazione. Primo: rafforzare la primary care e i sistemi di sorveglianza epidemiologica per affrontare NCD e malattie infettive in modo integrato. Investire in laboratori, reti diagnostiche e formazione produce ritorni nel medio termine e crea capacità locali autonome. Secondo: lavorare sulla sostenibilità finanziaria con strumenti che riducano la spesa diretta delle famiglie – dunque fondamentalmente assicurazioni sociali adattate ai contesti e investimenti pubblici mirati. Terzo: le collaborazioni di ricerca e industria devono includere clausole di accesso equo ai risultati, trasferimento tecnologico verificabile e meccanismi di governance condivisa per evitare dinamiche estrattive.
Operativamente, la co-progettazione con partner locali è imprescindibile: progetti concepiti e guidati congiuntamente favoriscono trasferimento di competenze, appropriazione istituzionale e adattamento culturale delle soluzioni. Allo stesso tempo, partnership pubblico-private ben regolate possono catalizzare risorse e innovazione, purché siano disciplinate da criteri etici e orientate a obiettivi di salute pubblica misurabili. Infine, la dimensione geopolitica non può essere sottovalutata: la sicurezza sanitaria dell’Europa è legata alla resilienza dei sistemi sanitari nei paesi partner. Per questo la cooperazione internazionale non è solo solidarietà, ma un investimento strategico in sicurezza collettiva.
Il punto cruciale è che sicurezza sanitaria, innovazione e giustizia globale non sono obiettivi separati ma aspetti integrati di politica estera e cooperazione. Per tradurre accordi e progetti in risultati durevoli servono finanziamenti a lungo termine, governance condivisa, trasferimento tecnologico con clausole di accesso equo e programmi di capacity building che mettano al centro le competenze locali. Riequilibrando il rapporto tra donatori e partner locali, intrecciando obiettivi industriali con criteri etici e trasformando interventi umanitari in percorsi di sviluppo sostenibile, l’Italia e l’Europa potranno concorrere realmente a costruire sistemi sanitari resilienti nel Sud Asia. La sfida è passare dalla cooperazione come assistenza alla cooperazione come alleanza paritaria: conveniente per la salute pubblica globale e indispensabile per la sicurezza collettiva.
Queste misure vanno tradotte in strumenti concreti: fondi pluriennali vincolati al rafforzamento della primary care, meccanismi di monitoraggio indipendenti, programmi di scambio e formazione per il personale sanitario e incentivi alla produzione locale di beni essenziali con clausole di accesso a condizioni favorevoli. Promuovere la partecipazione delle comunità e dei governi locali è fondamentale: le soluzioni durature nascono dall’incontro tra conoscenze tecniche e bisogni reali. A livello multilaterale, l’Europa può facilitare l’armonizzazione degli interventi, valorizzando piattaforme regionali di ricerca e produzione. In definitiva, trasformare la cooperazione sanitaria in una leva di sviluppo e sicurezza richiede scelte politiche coraggiose e un impegno che ponga al centro il diritto alla salute. Così concepita, la cooperazione tra Europa e Sud Asia diventa investimento reciproco nella salute e nella dignità delle popolazioni.