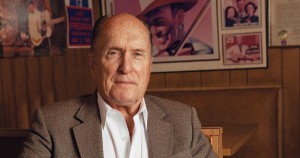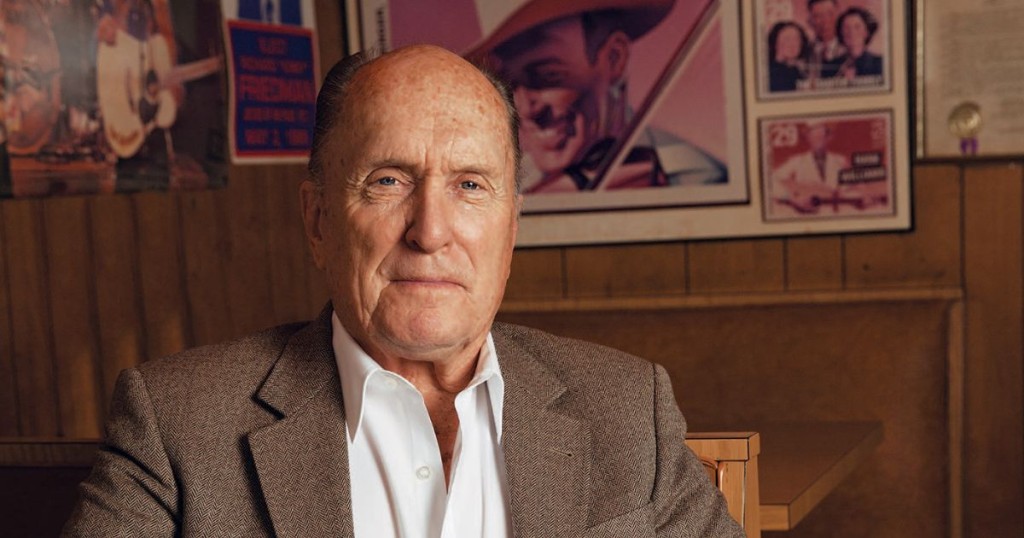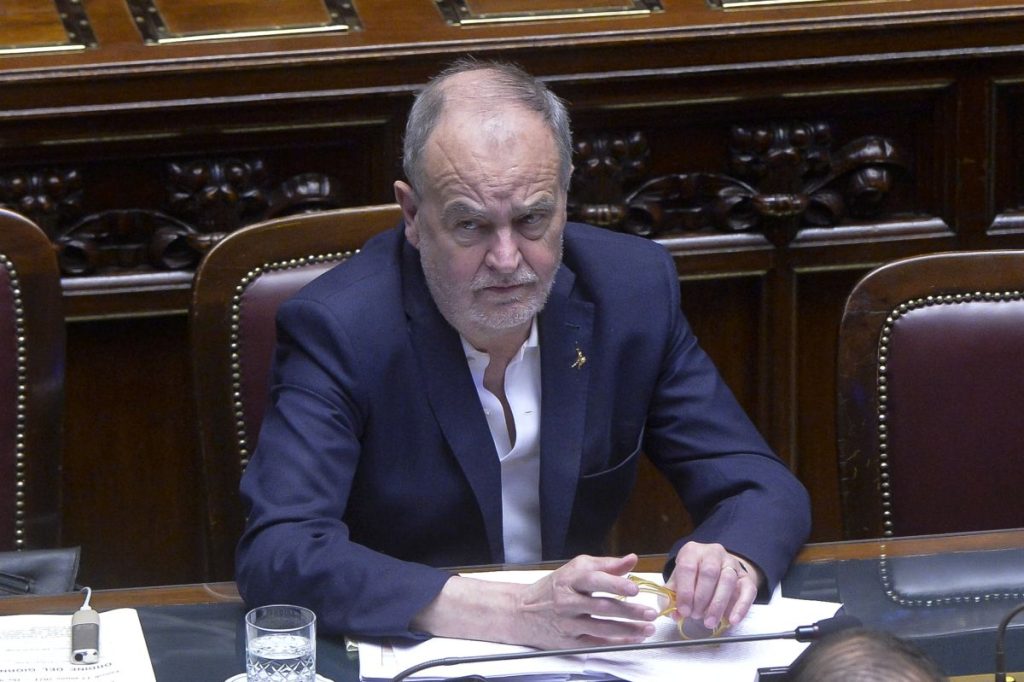Quanto vale la salute? La risposta dipende non solo dalla medicina, ma anche dal sistema che la eroga. Tra l’Italia e i Paesi del Nord America – Stati Uniti e Canada – si snodano tre modelli sanitari differenti, ciascuno con i propri punti di forza, fragilità e visioni sul ruolo dello Stato, del privato e del cittadino. Negli Stati Uniti, il panorama è radicalmente diverso. La sanità si basa su un sistema privato-assicurativo, dove i cittadini stipulano polizze – spesso tramite il datore di lavoro – per coprire spese mediche spesso elevatissime. L’introduzione dell’Affordable Care Act (Obamacare) nel 2010 ha esteso la copertura a milioni di americani, ma ancora oggi circa 26 milioni di persone restano senza assicurazione.
LEGGI ANCHE: Dalle frontiere al firewall
Il peso dei costi sanitari è tale che, secondo la Kaiser Family Foundation, il 41% degli adulti ha rinunciato o posticipato cure per motivi economici nel 2022. Il Canada rappresenta una via intermedia. Il suo sistema, noto come “Medicare”, è pubblico e universale, ma gestito a livello provinciale. Ogni cittadino ha diritto all’assistenza sanitaria di base, finanziata dalla tassazione. Tuttavia, il settore privato è presente ma limitato, soprattutto nei servizi non coperti come odontoiatria, fisioterapia o farmaci prescritti. Le lunghe attese per esami e interventi specialistici sono una delle principali criticità. Il Fraser Institute ha stimato in 27,7 settimane il tempo medio di attesa per cure specialistiche nel 2023, un record storico.
L’Italia si affida dal 1978 a un modello universalistico fondato sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finanziato dalla fiscalità generale, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alle cure, indipendentemente dal reddito. Negli ultimi anni, però, il sistema è sotto pressione: tra tagli, carenze di personale e liste d’attesa, il ricorso al privato sta crescendo. Secondo il Censis, nel 2023 oltre 19 milioni di italiani hanno pagato di tasca propria visite specialistiche per evitare lunghi tempi di attesa.
Pubblico e privato: alleati o concorrenti? Negli USA il privato è protagonista assoluto. Ospedali, cliniche e assicurazioni competono sul mercato, e la qualità delle strutture può essere altissima, ma profondamente ineguale. Basti pensare che il costo medio di un ricovero per un infarto può superare i 100.000 dollari, spesso coperti solo parzialmente dalle assicurazioni.
In Canada, invece, il privato opera principalmente in ambito diagnostico e specialistico. Negli ultimi anni, alcune province – come l’Ontario e il Québec – stanno valutando l’espansione del privato per alleggerire le liste d’attesa, ma la proposta ha suscitato forti dibattiti politici e sociali, per timore che venga compromesso il principio di equità. In Italia, il privato gioca un ruolo integrativo: molte strutture private sono accreditate con il Ssn, cioè, erogano prestazioni rimborsate dal pubblico. Tuttavia, si registra un aumento dell’out-of-pocket, la spesa diretta dei cittadini, che nel 2022 ha superato i 40 miliardi di euro secondo l’Istat. Il Canada si attesta a 82,3 anni, mentre gli Stati Uniti sono distaccati con 76,4 anni, a causa di maggiori disuguaglianze sociali, obesità e accesso disomogeneo alle cure.
Gli indicatori sanitari raccontano una storia interessante. L’Italia vanta una aspettativa di vita di 82,7 anni (dati Eurostat 2023), tra le più alte d’Europa, con buoni risultati nella medicina preventiva. Ma la percezione della sanità è più sfumata. In Italia, la fiducia nel Ssn è calata: secondo il rapporto “Osservasalute”, nel 2023 il 61% dei cittadini ha espresso insoddisfazione per i tempi e l’accessibilità. Negli USA, la qualità delle cure private è spesso considerata eccellente, ma il 70% degli intervistati ritiene che il sistema nel complesso non sia equo. In Canada, la soddisfazione rimane alta sul principio universalistico, ma cresce l’insofferenza per i ritardi.
Nonostante le differenze, i rapporti tra Italia, Canada e Stati Uniti sono vivi. In ambito scientifico, sono attive collaborazioni tra università e ospedali di eccellenza. Il centro di ricerca e cura Giovanni XXIII di Bergamo ha stretto partnership con il Massachusetts general hospital di Boston per studi congiunti su oncologia e intelligenza artificiale applicata alla diagnostica. La telemedicina, esplosa con la pandemia, è terreno fertile per cooperazioni internazionali. L’ospedale Meyer di Firenze, ad esempio, partecipa a progetti di teleradiologia pediatrica con centri canadesi come il SickKids hospital di Toronto.
Un altro ambito riguarda gli italiani residenti all’estero, spesso alle prese con la gestione di polizze private e rimpatri sanitari complessi. Le assicurazioni per italiani in Nord America, come quelle proposte da enti come Inca-Cgil, includono servizi di assistenza, traduzione medica e rientro in Italia per terapie lunghe o cure palliative. L’interesse per l’innovazione organizzativa è reciproco perché non esiste un modello sanitario perfetto ma un sistema sanitario che riflette la visione di società, in un contesto di rapporto tra individuo e Stato, tra libertà e responsabilità collettiva. Alcune regioni italiane, come l’Emilia-Romagna, stanno studiando modelli nordamericani di ospedali “paperless” e gestione dei dati clinici digitali, con particolare attenzione ai modelli interoperabili usati in Ontario e California. Questo perché, se l’Italia può vantare un’idea di sanità come diritto, deve però proteggerla con investimenti e riforme. Quindi, strizza l’occhio al Nord America che, con le sue contraddizioni, può ispirare soluzioni tecnologiche e organizzative.