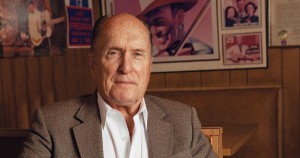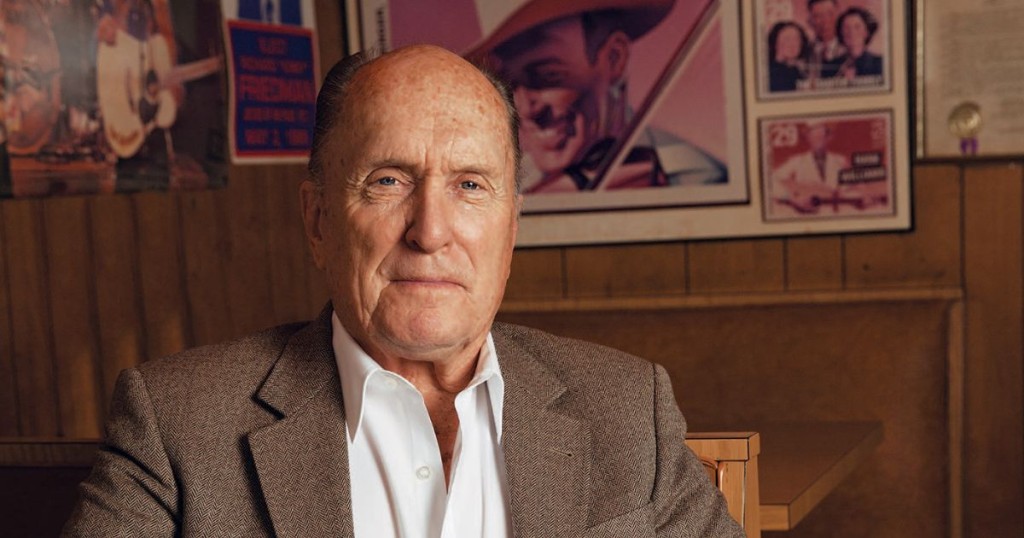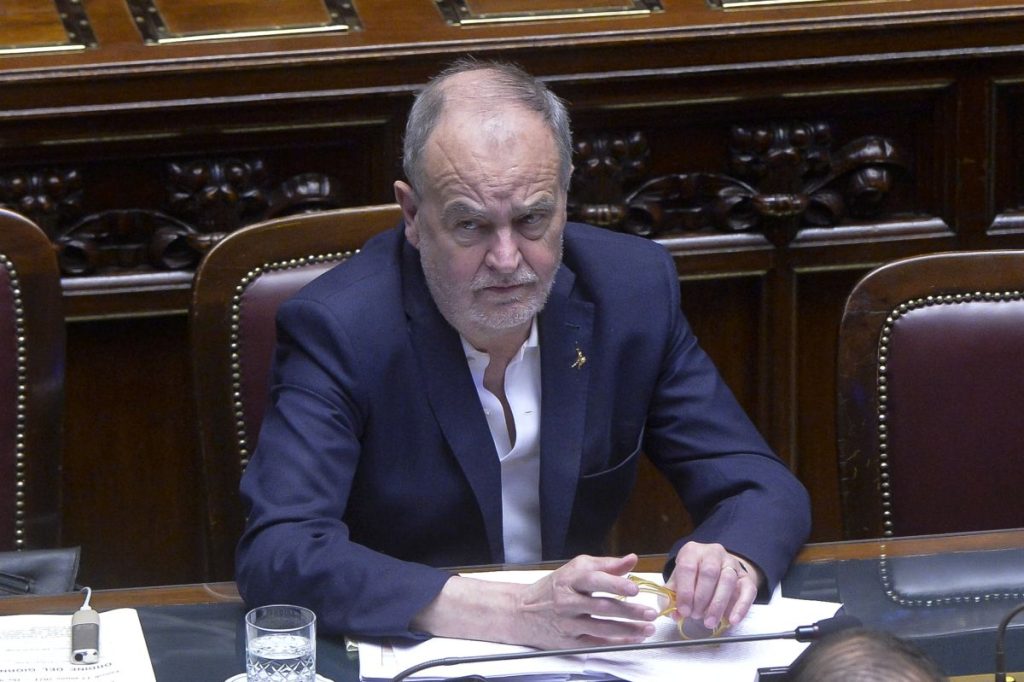Tre parole per fissare, nel flusso di veloci cambiamenti di questo periodo storico, trasformazioni e aspirazioni di Centro e Sud America: asfalto, acqua, pietra. L’asfalto corre sulla Panamericana, l’acqua trascina le canoe dell’Amazzonia, la pietra delle Ande regge il cielo. In mezzo, una cucitura saltata: il Darién Gap, dove non serve realismo magico per credere alla realtà. Nel 2023 l’hanno attraversato oltre mezzo milione di persone; nel 2024 i passaggi sono calati sensibilmente e il nuovo governo panamense ha inasprito controlli e rimpatri con l’aiuto di Washington. Il “muro” del Messico, in verità, comincia qui: protocolli, voli di ritorno, moduli digitali, pattuglie miste. Funziona sui numeri, meno sulle cause: crisi climatiche, economie fragili, violenze che spingono a nord. Ma il Darién Gap non è l’intero racconto: è uno snodo su una rete più vasta che dal Pacifico sale alle fabbriche e scende alle miniere, passa per le foreste e finisce sui mercati globali.
I PARTENARIATI UE-AMERICA LATINA
Asfalto. Lungo la Panamericana, dal fango alle fabbriche. Con l’Usmca, erede del Nafta, il Messico è diventato primo partner commerciale degli Stati Uniti e nel 2024 lo scambio ha sfiorato gli 840 miliardi di dollari. È la stagione del nearshoring: cablaggi per l’auto elettrica, componenti elettronici, logistica integrata. L’Usmca ha portato meccanismi rapidi di tutela sindacale, ma i dividendi si distribuiscono a macchia di leopardo: corridoi produttivi che corrono, hinterland che rincorrono; salari e welfare che non sempre seguono il ritmo delle esportazioni. Sullo stesso asfalto avanza la Cina, che prova a produrre “dal Messico per l’America”, mentre Washington risponde con dazi, regole d’origine e pressioni diplomatiche. È la dottrina Monroe 2.0: sicurezza delle filiere al posto delle cannoniere. Intanto un segnale: il progetto in Messico di un grande impianto automobilistico elettrico del colosso cinese Byd, si è raffreddato proprio per l’incertezza tariffaria. Gli Usa chiedono al Messico di essere due cose insieme, cuscinetto migratorio e piattaforma manifatturiera, e promettono accesso; ma ogni campagna presidenziale a nord del Río Bravo riapre l’oscillazione tra apertura e protezionismo.
Acqua. La rete fluviale dell’Amazzonia. È la più estesa autostrada naturale del pianeta. Qui il Brasile di Lula ha invertito la rotta: la deforestazione E’ scesa rispetto ai picchi recenti. Ma garimpeiros, frontiere agricole e siccità non arretrano. A novembre la COP30 porterà a Belém, nel cuore della foresta, leader, negoziatori, movimenti. La domanda non è solo quante tonnellate di CO2 evitare, ma chi paga la transizione e come la converte in lavoro locale, diritti territoriali, infrastrutture. Senza finanza affidabile e governance sul campo, l’Amazzonia resta una promessa sospesa. È qui che le nuove sinistre latinoamericane si misurano: facile difendere la foresta nei consessi internazionali, più duro farlo quando significa toccare interessi minerari, agroindustriali e reti criminali. Eppure la speranza, scriveva Neruda, “non tace mai”: naviga su battelli lenti, in scuole galleggianti e posti di salute che arrivano dove lo Stato è un’eco.
Pietra. Sulla dorsale andina, economia e geopolitica si fanno materia. Il “triangolo del litio”, costituito da Argentina, Cile e Bolivia. È il cuore delle batterie globali; ma la domanda, oggi, non è quante tonnellate estrarre, bensì dove si crea valore: raffinazione, catodi, celle, riciclo. Poco più a nord il Brasile entra nel gioco delle terre rare con progetti che puntano a una filiera magnetica per turbine e veicoli elettrici, sostenuti dalle coalizioni occidentali sulla sicurezza dei minerali critici. Per la prima volta da decenni la regione può sedersi al tavolo che conta, quello della tecnologia, non solo dell’estrazione. Ma la contesa per il sottosuolo riaccende i conflitti in superficie: in Paraguay comunità indigene denunciano sgomberi e avvelenamenti legati alla soia; in Colombia l’omicidio dei leader sociali resta un macigno; nel Brasile rurale la mappa della violenza agraria non si svuota, con 2.185 episodi tra sgomberi forzati, distruzioni di colture e omicidi. Qui riecheggia il tamburo di Manuel Scorza: «La terra non è un capitolo economico, è una biografia collettiva». La “licenza sociale” non è un vezzo etico: decide la durata degli investimenti.
UN OCCIDENTE LATINO NEL TEMPO PRESENTE
Nel frattempo la politica cambia partiture senza cambiare orchestra. La nuova marea rosa esiste, ma è un mosaico. Lula rilancia il Brasile su clima e inclusione; Gustavo Petro tenta di correggere in Colombia un modello estrattivo che genera ricchezza senza giustizia; Gabriel Boric in Cile lima le promesse iniziali dentro un quadro di sicurezza più severo; Claudia Sheinbaum eredita in Messico l’agenda sociale di Amlo promettendo efficienza. In controtendenza, l’Argentina di Javier Milei ha scelto la terapia d’urto: tagli, liberalizzazioni, un accordo con il Fondo e, per ora, l’archiviazione della dollarizzazione integrale. Non è un’onda lunga: è un mare mosso in cui governi progressisti operano con margini fiscali stretti e le opposizioni promettono ordine “misurabile”.
E la moneta diventa laboratorio. El Salvador ha proclamato il bitcoin moneta legale e poi ha corretto la rotta, riportando tasse e contabilità in dollari e rendendo volontaria l’accettazione della criptovaluta. L’Ecuador, dollarizzato da inizio secolo, dimostra che la stabilità nominale non basta senza Stato: i mercati possono restare calmi e le persone no, quando la violenza esplode. L’Argentina ha flirtato con la dollarizzazione totale, ripiegando su una stabilizzazione graduale del peso. La lezione è meno ideologica di quanto sembri: le scelte monetarie sono strumenti di fiducia; funzionano solo se appoggiate a istituzioni che raccolgono tasse, investono, proteggono.
La convivenza con il Nord America disegna il contorno. Gli Stati Uniti cercano forniture “amiche” di litio, rame e terre rare e chiedono al Messico di fungere da cuscinetto migratorio. Il Canada, più discreto, è ovunque con le sue compagnie minerarie e gli accordi multilaterali che incardinano la regione in orbite nordatlantiche. Il Sud risponde moltiplicando tavoli e opzioni: Brics allargati, cooperazioni Sud-Sud su infrastrutture e standard digitali, Celac, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, che parla con l’Europa di clima e agroalimentare. È tattica e strategia insieme: aumentare il prezzo della propria collocazione in un mondo a blocchi, senza farsi bloccare. Qui, per dirla con Vargas Llosa, “la storia non è mai finita”: cambia solo di scenario.
SUDAMERICA, PAGINE DI UN CONTINENTE
Eppure la bussola morale passa per le periferie. Haiti vive un collasso istituzionale e umanitario: capitale sequestrata dalle bande, missione internazionale sotto organico, uno Stato che fatica a esistere. Lì la democrazia coincide con l’ordine pubblico. Un po’ ovunque, lontano dalle capitali, continua il conflitto per la terra e l’acqua: è qui che si misura la qualità delle istituzioni oltre il Pil: titoli fondiari, tutela dei difensori, giustizia che arrivi prima della violenza. Intanto lo sport-industria racconta il tempo che abitiamo: nel 2030 il Mondiale di calcio celebrerà il centenario con partite inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay, ma si giocherà soprattutto in Europa e Marocco. L’icona resta latinoamericana; il baricentro finanziario e logistico, sempre meno. È un invito a passare dal soft power alla governance delle filiere: impianti, tecnologie, standard.
Torniamo ai tre legami – asfalto, acqua, pietra – e allo snodo del Darién Gap. Su quelle vie si intrecciano la frontiera esternalizzata e l’industria che sale, le foreste che resistono e le miniere che tornano strategiche, i dollari, le cripto e le valute locali, le città che corrono e le campagne che pagano il conto. Il Centro e Sud America, che troppo spesso diamo per scontato, non è più una periferia da sfruttare: è un laboratorio di politiche che, tra sperimentazioni e contraddizioni, sta ridisegnando la prossima globalizzazione. Dal Darién a Belém, dall’Usmca ai Brics, dalla soia ai magneti, il filo è uno solo: la regione chiede di essere pagata non per quello che estrae, ma per quello che sa costruire. Se l’Europa vuole contare in questa parte del mondo, deve parlare questo linguaggio: contratti climatici che arrivino nei municipi, catene del valore trasparenti che paghino salari e tasse in loco, cooperazione su sicurezza e giustizia. Perché tra l’asfalto che accelera, l’acqua che resiste e la pietra che non si sposta, passa il futuro di un emisfero. E la nostra capacità di ascoltarlo.