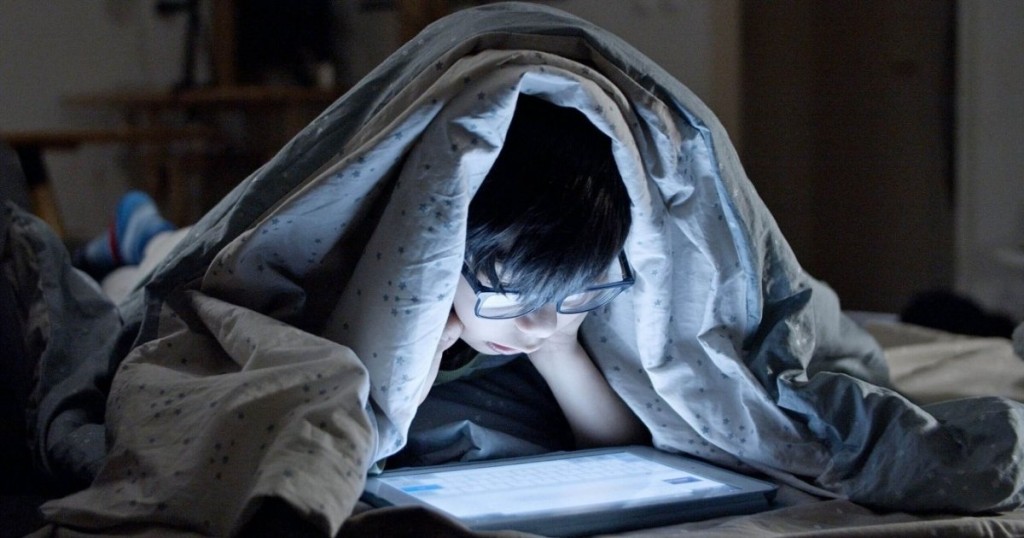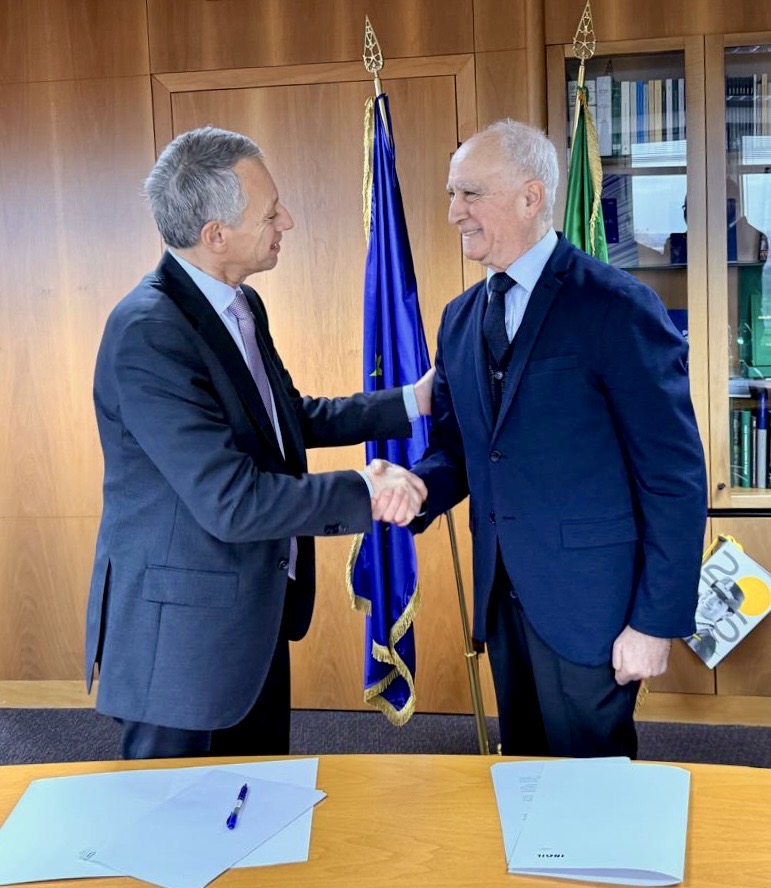Il fatto è storico, un autogol del fronte europeista anche dopo il voto con cui il Parlamento Eu ha confermato la fiducia a von der Leyen
Dopo anni di cause, scandali e richieste da parte dei gruppi per la tutela della trasparenza europea il caso Pfizer torna a scuotere l’Europa. Oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha riottenuto la fiducia dal Parlamento Europeo. Ma a prescindere da come sono andate le cose, il semplice fatto che il chiacchieratissimo “Pfizergate” abbia portato von der Leyen in Parlamento è un fatto molto importante per lo sviluppo politico europeo.
Un fatto forse addirittura destinato a fare storia perché sotto inchiesta, nel caso Pfizer, non c’è solo l’operato di un’alta carica europea, che agiva in un contesto critico di assoluta emergenza, ma anche la visione del rapporto tra le autorità comunitarie e la comunità che rappresentano. L’intera faccenda, ormai ben nota a causa dell’ampia copertura mediatica che ha ottenuto negli anni, ruota attorno ai messaggi scambiati durante la crisi pandemica da Covid-19 tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla, Ceo di Pfizer.
Al tempo del lancio della gigantesca campagna di vaccinazione contro il Covid l’Unione Europea, che aveva fatto della volontà di coordinare gli sforzi comunitari uno dei suoi obiettivi principali, ha tentato di ottenere enormi quantità di vaccini e, almeno inizialmente, si era orientata su quello fornito da AstraZeneca. L’azienda anglo-svedese, però, non ha potuto fornire in tempi contenuti l’intero lotto di vaccini necessari alla vaccinazione di massa e proprio per questo le autorità europee si sono orientate, parallelamente, su un’altra azienda farmaceutica, Pfizer, da cui vennero ordinate più di un milione di unità al prezzo di 35 miliardi di euro.
Fino a qui, nulla di strano: l’Ue, messa in difficoltà dalla portata della crisi in corso è corsa ai ripari sui vaccini affidando la fornitura dei sieri a due diverse aziende, la cui produzione combinata ha permesso, già prima del 2022, di compiere un’opera di vaccinazione su larga scala impressionante sul piano logistico e decisamente molto efficace.
Ciò che ha scatenato il putiferio sulla questione, però, è stato lo scoop lanciato a fine aprile 2021 dal New York Times: il giornale americano sostenne, infatti, di aver avuto notizia che la von der Leyen aveva trattato direttamente, su una app di messaggistica, con Bourla per ottenere le forniture di vaccini aggirando i normali canali negoziali dell’Unione. Un affare privato, in sostanza, concluso in prima persona dalla Presidente della Commissione senza che le sue azioni potessero essere controllate.
A questo scoop la Commissione e la stessa von der Leyen hanno sempre risposto negando che l’accordo fosse stato raggiunto interamente in forma privata, ricordando che procedure di questo tipo sono lunghe e complesse e ben al di là delle capacità di soli due o tre individui. Al massimo, sostennero da Bruxelles, gli scambi con Bourla erano stati avviati per motivazioni pratiche, vale a dire per accelerare alcune dinamiche secondarie. Ma queste dichiarazioni, com’era prevedibile, non hanno convinto appieno e la decisione della von der Leyen di non rendere pubbliche le chat in cui si discuteva della faccenda, che la Presidente ha sempre sostenuto di non aver archiviato perché non rilevanti, ha fatto fiorire per anni teorie complottiste.
Alimentate debitamente da tutta quella parte politica del continente che sposa posizioni più anti-europeiste. Il penultimo atto di questo strano caso europeo è arrivato a metà maggio scorso, quando la Corte di Giustizia europea, a seguito di un caso sottoposto dal New York Times, ha imposto alla Commissione di «eseguire la sentenza e riesaminare la richiesta di accesso ai messaggi di testo di von der Leyen a Bourla», oppure «di presentare ricorso».
La faccenda, ad oggi, resta dunque ancora lacunosa. Per un’Unione che fa della trasparenza un cardine esistenziale, dunque, non una storia particolarmente positiva. Di per sé la trattativa privata con Bourla, vista la situazione in cui versava il continente al tempo, non è particolarmente preoccupante ma la decisione successiva di mantenere “segrete” le chat è un punto critico che stride con i principi fondativi dell’Unione e con il senso stesso dell’Ue.
Anche sul piano prettamente politico, tutta questa faccenda non fa che fornire un assist a tutti quei gruppi che tentano di colpire i cardini strutturali della comunità europea dall’interno e a chi non può che vedere oscuri intrighi anche in gesti assolutamente giustificabili date le circostanze. Un autogol da parte del fronte europeista, in sostanza, a prescindere dalla votazione di oggi.