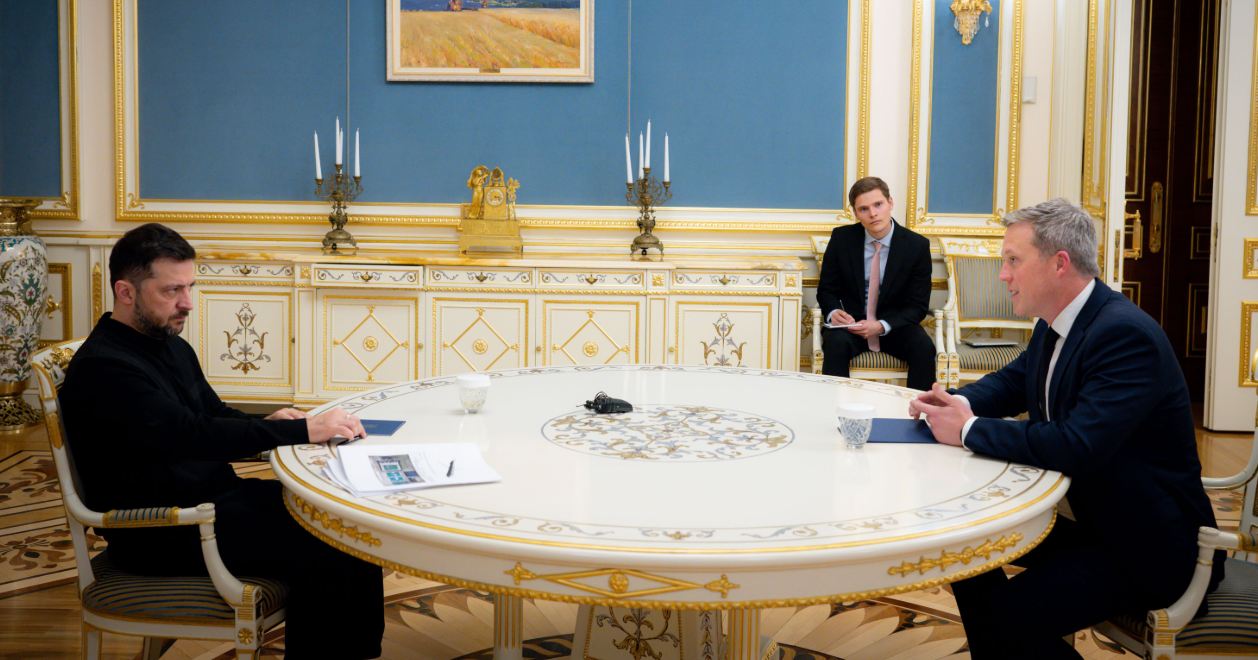Nel Donbass si gioca il destino dell’intera Europa, il silenzio degli intellettuali è assordante
Nei campi di battaglia del Donbass è in gioco non solo il destino dell’Ucraina, ma quello dell’intera Europa. Impossibile per questo prendere anche solo in considerazione da parte degli europei la possibilità che una pace «cartaginese» venga imposta a Kiev da un diktat russo-americano.
Significherebbe ripetere, a quasi novanta anni di distanza, il tragico errore commesso nel 1938 a Monaco dalle democrazie europee, che non solo consegnò al nazifascismo la repubblica cecoslovacca, ma di fatto spianò la strada verso la seconda guerra mondiale:
«Potevate scegliere tra il disonore e la guerra. Avete scelto il disonore, avrete la guerra», commentò lucidamente Winston Churchill.
Il realismo politico dell’Europa
Per questo fermare l’aggressione della Russia non è semplicemente un comandamento morale, ma è una decisione di assoluto realismo politico, nel segno dell’etica della responsabilità: il vero obiettivo di Putin è, infatti, quello di distruggere l’unità dell’Europa e di riportare l’orologio della storia a prima del 9 novembre del 1989, cioè a prima della caduta del Muro di Berlino. Sostenere la resistenza degli ucraini, una resistenza che ha dell’eroico e pone la coscienza europea dinnanzi ad un dilemma tanto inatteso quanto drammatico, è un imperativo strategico, una pietra miliare sul cammino del processo di unificazione del Vecchio continente.
Dalle Comunità europee alla moneta unica
Esattamente come lo furono in passato la nascita della Comunità del carbone e dell’acciaio, che mise fine alla secolare, sanguinosa guerra tra Francia e Germania. E poi la formazione della Comunità europea, la nascita del mercato comune e l’allargamento della vecchia Europa renana ai paesi di quello che Milan Kundera aveva giustamente definito «l’Occidente prigioniero», cioè alle nazioni che la guerra fredda aveva condannato alla cattività sovietica. E, infine, la nascita della moneta unica e gli accordi di Schengen.
Una sfida culturale oltre che geopolitica
Dinnanzi alla portata di tale sfida, che non è solo geopolitica ma culturale e spirituale, le forze politiche in molti paesi, e purtroppo in particolare in Italia, non sembrano avere la consapevolezza necessaria e tanto meno la volontà per indicare un percorso strategico che eviti quello che appare un rischio concreto e potenzialmente esiziale: cioè la spaccatura del vecchio Continente tra i paesi del Nord e dell’Est e quelli del Sud e dell’Ovest.
Un po’ come avvenne negli anni Dieci del secondo millennio: allora tra paesi “frugali” e paesi “indebitati”. E oggi tra quelli, in primis la Germania, la Polonia, i paesi baltici e scandinavi, che di fatto già si sentono in guerra a causa delle minacce portate quotidianamente dalla Russia, e i paesi che si illudono di essere “lontani dal fronte”, quasi che la collocazione geografica garantisse per la loro sicurezza.

Cosa manca all’Unione Europea
Certo, la logica unanimistica, che è stata posta a fondamento del processo di costruzione di quella che chiamiamo Unione Europea, non aiuta. Anzi offre un pretesto a chi vuole rinviare decisioni ormai irrinunciabili. Per questo bene ha fatto Mario Draghi, proprio come fece nell’ormai leggendario discorso londinese del luglio del 2012 col “whatever it takes” che salvò la moneta unica, a indicare la via per aggirare la paralisi che blocca la politica estera dell’Unione.
La “Terza Europa” indicata da Draghi
Un giorno si arriverà ad una federazione europea, ma oggi è il momento dei Volenterosi, cioè dei paesi che si mettono assieme per decidere e per agire. Nel suo discorso di Oviedo (si veda “l’Altravoce” del 25 ottobre scorso) Mario Draghi ha indicato la via sulla quale costruire quella che chiamerei la “Terza Europa”, dopo quella del secondo dopoguerra e quella sorta dopo la caduta del Muro di Berlino. È la via del “federalismo prammatico”, basato sui temi specifici, flessibile e capace di agire fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale dell’Ue.

Su questa stessa lunghezza d’onda si muovono anche recenti affermazioni del Cancelliere tedesco Merz, sulle quali si potrebbe lavorare per dar vita a una collaborazione italo-tedesca, che già in passato ha svolto un ruolo decisivo nei momenti di crisi del cammino europeista.
La minaccia del bi-populismo
Certo in Italia (ma anche in Francia e Germania) si tratta di condurre una battaglia politica e culturale contro quella che assieme all’aggressione russa, anzi in accordo con essa, rappresenta la minaccia più seria per le democrazie europee: il doppio o bi-populismo di destra e di sinistra.
I “Putin-Versteher”, così vengono definiti in Germania, i filo-putiniani e i falsi pacifisti si danno man forte per spingere l’Europa verso quella fine che vorrebbero Putin e Trump.
Il silenzio degli intellettuali
E gli intellettuali europei? Salvo rare e lodevolissime eccezioni, tacciono mentre, come ha affermato lo storico tedesco Karl Schlgel, dovremmo prendere esempio dagli ucraini che «ci stanno insegnando che difendere il proprio paese non ha a che fare con il militarismo. Sono lo specchio in cui ci guardiamo, ricordandoci cosa l’Europa abbia rappresentato e perché vada ancora difesa».