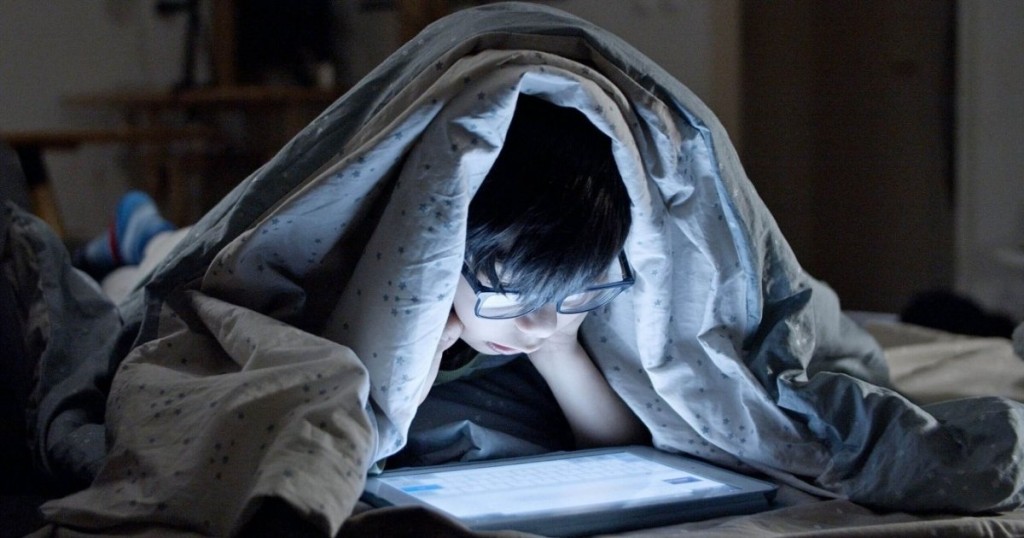«L’Europa sta evolvendo verso forme di collaborazione intergovernativa anche con Paesi che non fanno parte dell’Ue. In questo quadro gli Stati europei – Italia in primis – non devono rinunciare al rapporto con gli Usa». Giampiero Massolo è ambasciatore, già segretario generale della Farnesina e direttore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza. In dialogo con l’Altravoce offre un quadro esaustivo dello scenario internazionale e delle sfide che attendono il Vecchio Continente sul fronte geopolitico.
Ambasciatore, da Draghi è arrivato l’ennesimo stimolo all’Ue. I leader europei al vertice di lunedì scorso a Washington hanno restituito l’immagine di una certa unità. Siamo all’inizio di un nuovo corso?
«Il vertice di Washington ha mostrato un’Europa che ha ritrovato dinamismo e compattezza, per lo meno sul dossier della guerra in Ucraina. Da questa guerra l’Europa sta ricevendo lo stimolo per cercare nuovi mezzi che favoriscano l’integrazione europea. Tra i vari Paesi europei si sta costruendo una piattaforma importante sia per quanto riguarda il dossier ucraino sia per quanto riguarda in generale il futuro. Sono infatti convinto che l’integrazione europea si costituirà sui temi della difesa e della sicurezza, che oggi giocano il ruolo che in passato è stato giocato dal mercato unico come fattore d’integrazione».
Ma l’Europa può davvero avere un ruolo nello scenario internazionale? Proprio per quanto riguarda la sicurezza e la difesa non gode di grande autonomia e resta vincolata alla partnership con gli Usa.
«L’Europa risente dei ritardi che si sono determinati negli anni dell’Ue, che si è cullata per troppo tempo sul terreno merkeliano, quello per cui si acquistano materie prime a basso prezzo dalla Russia, si commercia con la Cina e si appalta la sicurezza agli Usa. Si è adagiata sul dividendo della pace e in questo modo ha accumulato ritardi che si sono tradotti in un eccesso di dipendenza dagli Stati Uniti. Così si è condannata a un ruolo minoritario, determinando un gap che non può essere recuperato in tempi brevi».
Questa condizione di minorità in che cosa si traduce concretamente?
«Nel fatto che l’Europa è ora obbligata a dimostrare compattezza per cercare di ancorarsi agli Usa, sia per evitare che si allontanino troppo e venga così messa a rischio la sicurezza europea, sia per evitare che nella guerra ucraina gli Stati Uniti assumano soltanto un ruolo di mediazione, indebolendo la posizione occidentale. Da questo punto di vista il vertice di Washington è stato un esempio di buona diplomazia. Ora vedremo che frutti darà».
A proposito di diplomazia, il Guardian ha parlato di un possibile passo indietro di Trump per favorire trattative bilaterali tra Putin e Zelensky. Le posizioni dei due sembrano però ancora molto distanti. Ci sono i presupposti per le trattative oppure la diplomazia richiede la presenza di uno spazio di dialogo che ancora non non c’è?
«La diplomazia consiste nel creare le condizioni perché i decisori politici si parlino e negozino in modo concludente. Da questo punto di vista continua ad avere un ruolo necessario, anche se i decisori politici si affidano sempre più al proprio giudizio istintivo piuttosto che al lavoro istruttorio. Sul dossier ucraino in questo momento le parti sono ancora troppo lontane, perché il destino stesso dell’Ucraina è oggetto di interpretazioni divergenti: per Mosca l’Ucraina deve essere disarmata, neutrale e non occidentale. Invece per l’occidente – cioè per l’Europa e auspicabilmente per gli Usa – deve essere parte del mondo occidentale e libera di autodeterminarsi».
Oltre a questo tema di fondo c’è quello della messa in sicurezza della parte di Ucraina non occupata.
«La garanzia di sicurezza è fondamentale perché Zelensky possa dire alla propria opinione pubblica che è sì doloroso dover cedere dei territori, ma che in cambio di queste cessioni ha ottenuto delle garanzie solide sul fatto che la Russia non invaderà mai più l’Ucraina. La difficoltà principale è che l’efficacia delle garanzie di sicurezza dipende dal garante di ultima istanza, cioè dagli Stati Uniti, e non so fino a che punto gli Usa vorranno contrapporsi alla Russia, cosa che faranno se difenderanno l’Ucraina. Poi c’è un altro elemento da considerare…»
Quale?
«Il fatto che in questo momento alla Russia non conviene sedersi attorno a un tavolo. Putin ha la percezione di essere in vantaggio sul terreno. Se anche non dovesse conquistare tutto il Donbass, ritiene che prendere tempo significa esasperare le contraddizioni tra Usa e Europa e mettere in crisi i governi europei, le cui opinioni pubbliche iniziano ad essere affaticate dalla continua tensione determinata da questa guerra».
Alla luce di questo elemento come giudica la decisione di Trump di puntare subito a un accordo complessivo senza prima passare per il cessate il fuoco?
«Questo è l’elemento più indebolente che è uscito prima dal vertice di Anchorage e poi da quello di Washington. In questo modo Trump ha messo nelle mani di Putin il controllo dei tempi del negoziato. Se lo zar prende tempo, come sta facendo, costringe Zelensky a rimanere sotto attacco. Il fattore tempo gioca dalla parte dell’aggressore. In questo quadro si inserisce anche la volontà di Putin di essere parte delle garanzie ucraine, ma far partecipare l’aggressore alle garanzie sull’aggredito significa continuare ad esporre quest’ultimo alla minaccia».
Se sul fronte ucraino l’Europa sembra che stia riuscendo a ritagliarsi un ruolo, nel quadrante mediorientale è invece completamente assente.
«Lo è da tempo, se si esclude qualche presenza francese e italiana per quanto riguarda il Libano. In questo momento l’Europa può solo esercitare delle pressioni, cercare di indurre Trump a moderare Netanyahu e cercare infine di sviluppare una diplomazia attiva con i Paesi arabi moderati affinché intervengano su Hamas in modo più determinato di quanto non abbiano fatto finora. Quindi su questo fronte l’Europa può avere un atteggiamento di fiancheggiamento e di rimessa più che di iniziativa autonoma, che purtroppo manca da tempo».
Ieri sulla Stampa Stefanini scriveva che il riconoscimento dello Stato di Palestina è totalmente inutile e tuttavia necessario, quantomeno come ideale regolativo. È d’accordo?
«Stando ai fatti e a quello che sta succedendo, l’ipotesi dei due Stati non è realistica. Va certo mantenuta quella prospettiva, nel senso che il riconoscimento di una statualità palestinese è un elemento essenziale del negoziato per un futuro assetto del Medio Oriente. Non credo però che questa prospettiva vada salvaguardata attraverso il riconoscimento dello Stato palestinese, perché vorrebbe dire privarsi adesso di una carta negoziale importante che andrà invece giocata al momento opportuno».
Quali sono le ragioni che hanno spinto Israele a intraprendere un’iniziativa per occupare militarmente la Striscia?
«Israele ha deliberatamente preferito l’eliminazione della minaccia alla deterrenza. Mi spiego meglio: dopo il 7 ottobre il governo israeliano ha deciso scientemente di perseguire la sicurezza, preferendola a qualsiasi altra considerazione. Ne sta pagando un prezzo durissimo in termini di isolamento internazionale e di reputazione. Inoltre corre e fa correre un rischio molto rilevante in termini di risorgente terrorismo jihadista, di flussi migratori e di risorgente antisemitismo. Ma dal punto di vista del governo israeliano tutto questo passa in subordine rispetto all’esigenza di garantirsi la difesa. La sicurezza non viene più perseguita lavorando sulla deterrenza, come Israele ha fatto fino al 7 ottobre, ma acquisendo l’egemonia militare nella regione ed eliminando ogni minaccia. Lo ha fatto con Hezbollah, con gli Houthi, con l’Iran e lo sta facendo con Hamas, che non ha più rilevanza militare ma rispetto a cui pesa molto il tema degli ostaggi».
Quello degli ostaggi rimane in effetti un tema dirimente rispetto all’occupazione di Gaza, anche all’interno dell’opinione pubblica israeliana. Tel Aviv persegue la sicurezza anche a prezzo del sacrificio degli ostaggi?
«Netanyahu pensa di doverli liberare con le armi, ritenendo che la via negoziale sia stata finora fallimentare. Hamas usa strumentalmente gli ostaggi come forma di ricatto e sarebbe forse disposto ad accettare un cessate il fuoco, mantenendo però gli ostaggi da usare come elemento di pressione su Israele. Tutto questo ci dice che le parti sono in un conflitto insanabile. È di due giorni fa la notizia che Netanyahu vuole riprendere il negoziato per liberare gli ostaggi pur continuando i preparativi per l’occupazione militare della Striscia».
In questo complesso quadro internazionale secondo lei come si sta comportando il nostro Paese?
«Con coerenza. Già i governi precedenti, almeno a partire dal governo Draghi, avevano fatto molta chiarezza: l’Italia appartiene all’occidente e dunque ha tutto l’interesse a mantenere un occidente forte. Poi appartiene all’Unione Europea e dunque deve lavorare per rafforzarla, affinché l’Ue sia una componente forte di un occidente forte. Per fare questo l’Italia deve agire per rafforzare anche se stessa, eliminando le sue debolezze strutturali. Il governo attuale cerca di non perdere per strada gli Usa e ancorarli in Europa, in questo facilitato anche da un rapporto personale molto scorrevole tra la premier Meloni e Trump. Non possiamo perdere gli Stati Uniti, ma dobbiamo anzitutto essere ben incardinati noi in questa Europa che sta evolvendo verso forme di collaborazione intergovernativa anche con Paesi come il Regno Unito che non fanno più parte dell’Ue. Da questo punto di vista l’iniziativa dei volenterosi è una piattaforma esemplare. Tutto questo l’Italia lo sta facendo, ma anche questo ha un prezzo. Bisogna spiegare all’opinione pubblica perché è necessario pagarlo».