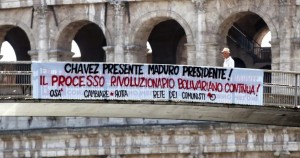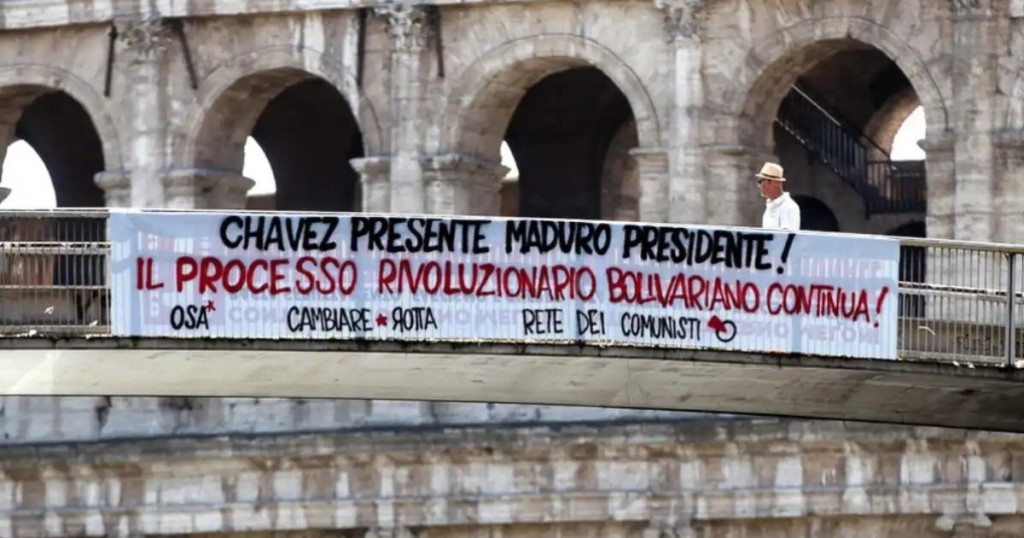Quando in Italia il pomeriggio scivola verso la sera e l’ombra delle insegne si allunga sui marciapiedi, a Sydney il sole è già alto, il tram sfiora i tavolini all’aperto e il profumo del caffè si mescola all’odore metallico dei container in porto. Qui il tempo non è un semplice fuso: è una rotazione diversa. Per una parte del mondo è ancora ieri, qui è già domani. Per secoli questo scarto ha confinato l’Oceania e l’Asia del Pacifico nell’angolo remoto della mappa mentale europea. Oggi, invece, quel margine è un architrave: un arcipelago strategico dove si incrociano rotte marittime, cavi dati, catene del valore, e un unico filo che attraversa ogni banchina, ogni corridoio diplomatico, ogni mercato notturno: la Cina.
Sulle banchine di Melbourne, i lingotti di minerale di ferro brillano come tegole nuove al sole; le gru li adagiano nei container che, poche settimane dopo, saranno scaricati a Tianjin o a Shanghai. Nel 2024 oltre un terzo dell’export australiano ha preso quella rotta: gas naturale liquefatto, carbone, orzo, vino. Un legame redditizio, certo, ma nervoso: quando nel 2020 Canberra chiese un’indagine internazionale sulle origini del Covid-19, Pechino rispose con dazi punitivi che fecero tremare vigne e macelli. Gran parte di quelle misure è stata allentata, ma il promemoria resta: dipendere significa esporsi. Così l’Australia ha stretto i bulloni dell’alleanza con Washington e Londra nel quadro Aukus, il patto di sicurezza trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti: sottomarini a propulsione nucleare, interoperabilità, addestramenti.
La postura strategica guarda a nord, mentre la vita scorre a sud: nei pub si discute di cricket come di questioni costituzionali, nei mercati di Sydney i ravioli cinesi stanno accanto alle spezie indiane, e nelle scuole il mandarino si studia come una lingua di vicinato più che d’esotismo.
Un volo breve e il vento cambia timbro: Wellington è una città che parla a raffiche. La Nuova Zelanda vive di latte, carne, legname, vino; un quarto circa delle sue esportazioni finisce in Cina. Il tono della diplomazia è prudente: parte della rete di intelligence “Five Eyes” (sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) ma con un canale aperto con Pechino per non spaccare la filiera agricola che sostiene fattorie, cooperative, quartieri interi. Nei sobborghi di Auckland, case vittoriane ospitano studenti cinesi e samoani che condividono cucine troppo piccole e sogni troppo grandi; al mercato del sabato i “baozi” fumanti fanno la fila accanto alle salsicce locali. Qui l’equilibrio con la Cina è anche quell’ordinaria convivenza che si riconosce meglio tra scaffali di alimentari che nelle note verbali delle ambasciate.
A nord-ovest la rotta piega verso la caldera commerciale dell’Asean, un mosaico di dieci Paesi, dalla Malesia al Vietnam, con oltre 600 milioni di abitanti e un Pil complessivo di circa 4.000 miliardi di dollari. A Singapore, i portuali di Tuas controllano schermi che brillano come acquari: il nuovo terminal automatizzato trascina container come fossero biglie, 24 ore su 24. Sulle banchine capita di sentire, nella stessa mezz’ora, il dialetto hokkien (il cinese locale), l’inglese d’affari, il malese di mercato. La Cina qui non è un ospite: è uno dei padroni di casa. Banche, logistica, catene di fornitura. Eppure nessuno a Singapore ha voglia di scegliere “per sempre”: il Paese vive di porte scorrevoli, tiene spalancata quella con Pechino e non chiude quella con Washington, Tokyo, Bruxelles.
In Indonesia, l’odore del nasi goreng si sposa con quello di benzina dei motorini all’ora di punta. A Sulawesi, il nichel destinato alle batterie per auto elettriche è un magnete per capitali cinesi: miniere, fonderie, strade nuove. I villaggi contano i posti di lavoro, i pescatori contano i pesci, i sindaci contano i voti. La Cina è una cifra sul bilancio, ma anche un accento in più nei cartelli dei cantieri. E intanto, a Jakarta, il Ramadhan modella tempi, consumi, riunioni di governo: commercio e fede non sono due colonne separate, sono la stessa riga di un foglio vivo.
Poi c’è il Vietnam, che come pochi ha memoria lunga. Ad Hanoi, scolaresche in uniforme si fermano davanti al mausoleo di Ho Chi Minh, e al Museo della Storia Militare il relitto contorto di un B-52 racconta la stagione in cui il generale Võ Nguyên Giáp piegò la Francia a Dien Bien Phu nel 1954 e vent’anni dopo costrinse gli Stati Uniti a lasciare Saigon e a imparare il rispetto per gli ultimi della terra. Adesso le armi sono i contratti: dal 2024 il Vietnam ha superato la Corea del Sud tra i fornitori di abbigliamento agli Usa; l’elettronica cresce in distretti che, al cambio di turno, riversano in strada fiumi di caschi e scooter. La Cina è l’amico che fu compagno di strada e oggi è diventato un vicino ingombrante: primo fornitore di beni intermedi, rivale testardo nel Mar Cinese Meridionale. Nelle acque color piombo si inseguono pescherecci, motovedette, droni di sorveglianza: “commerciare di giorno, vigilare di notte”, è il monito dei venditori di tè dalle giunche della baia di Ha Long, espresso usando il francese imparato dai nonni. È una filosofia politica travestita da proverbio.
Più a est il viaggio diventa una superficie lucida. Il Giappone è un mosaico di contrasti: i treni Shinkansen tagliano la campagna come aghi, ma nei vicoli di Kyoto anziani vendono dolci di riso avvolti in foglie di sakura. Negli anni Ottanta Tokyo dettava la moda tecnologica; oggi guida settori di precisione: robot chirurgici, materiali per semiconduttori, tecnologie idriche. La memoria del pacifismo costituzionale ha retto per decenni, ma nel 2022 il bilancio della difesa ha fatto un salto che sa di svolta, con missili a lungo raggio e cooperazioni strette con Australia e India. Con la Cina, i conti sono di partita doppia: interdipendenza commerciale, rivalità storica. In metropolitana un uomo in giacca scura dorme in piedi, lo smartphone stretto nella mano; alla sera un quartiere intero fiorisce di matsuri: lanterne, tamburi, bambini che rincorrono pesci rossi in vaschette di plastica. A ricordare che un Paese non è mai soltanto il suo Pil, ma le sue feste, tradizioni e cultura.
Sulla penisola coreana la geopolitica è una ferita cucita ogni giorno. A Seul, il fiume Han riflette insegne al neon, taxi, ponti. Nei locali di Hongdae ragazzi con felpe oversize provano passi di K-pop, mentre in un grattacielo di Gangnam, quartiere benestante reso celebre dal rapper Psy, una squadra di ingegneri controlla l’andamento di un wafer di silicio. Samsung, Hyundai, LG: la manifattura coreana è un pezzo di futuro in tempo reale. Ma a cinquanta chilometri, oltre la Zona Demilitarizzata, Pyongyang è un’altra pellicola: viali troppo larghi per poche auto, palazzi monumentali, vetrine senza merce. La Corea del Nord vive di propaganda e di container cinesi. Ogni test missilistico ricorda a Seul che la sicurezza non è un titolo sui giornali, è una riga del bilancio familiare. Per Pechino, il regime è un cuscinetto ruvido ma utile: meglio un vicino scomodo che il vuoto.
Ovunque, in questo arcipelago, la natura è politica. L’innalzamento del mare rosicchia centimetri alle spiagge di Tuvalu e Kiribati: qui “migrazione” non è etichetta ideologica, ma piano urbanistico con la valigia accanto. Il delta del Mekong arretra di anno in anno; tifoni e siccità mettono alla prova reti elettriche e sistemi sanitari di Giappone e Corea. Le risposte sono patchwork: pannelli solari sui tetti delle isole, barriere mobili, riforestazioni che faticano a tener testa ai consorzi agricoli. La Cina finanzia dighe e parchi eolici; l’Australia istituisce aree marine protette: una parte di ecologia e una parte di diplomazia.
Poi c’è la parte che non entra nei comunicati: la vita. In Indonesia il richiamo del muezzin si mescola ai clacson dei gojek, in Cambogia i monaci Theravada scivolano all’alba con ciotole per le offerte; in Thailandia il capodanno Songkran trasforma le strade in torrenti festosi. In Giappone lo shinto convive con il buddismo e con la caffeina delle sale giochi; in Corea del Sud lo sciamanesimo sopravvive sotto pelle, mentre al nord è bandito. In Australia e Nuova Zelanda le culture aborigene e maori hanno ottenuto riconoscimenti formali, ma la preservazione è una fatica quotidiana: lingue insegnate a scuola, cartelli bilingui, Welcome to Country prima dei convegni, haka prima delle partite. Ogni rito è un micro-trattato: dice chi siamo, con chi parliamo, fin dove vogliamo cambiare.
La lingua è il filo più delicato. In Papua Nuova Guinea si parlano oltre ottocento idiomi, molti senza scrittura. Nelle isole minori del Pacifico bastano due matrimoni e un contratto per decidere se una lingua sopravviverà. Le Ong portano alfabetizzazioni, i governi portano programmi, gli investitori portano esattamente ciò che serve ai loro cantieri: l’inglese, il mandarino, il software gestionale. A volte salvano, a volte schiacciano. L’arte prova a rimettere in pari: il manga giapponese racconta il pescatore di Hokkaido con la stessa dignità del samurai; i K-drama coreani smontano l’ordine sociale con melodrammi chirurgici; la poesia orale samoana tiene insieme genealogie e mappe di mare; il cinema vietnamita rilegge la resistenza come educazione sentimentale di un Paese che non vuole più odiare.
E poi c’è la musica, emoglobina culturale. Il rock australiano, dai Bee Gees ai Midnight Oil, passando per gli Inxs e gli AC/DC ha lasciato un’eco che ancora si propaga nella vecchia Europa e non solo, tracciando ponti da molto prima che la fibra ottica fosse stesa. Il K-pop è una macchina perfetta, amata e insultata: un’industria che insegna al pianeta che anche un ritornello in una lingua straniera può diventare lingua franca. Il city pop giapponese, rispuntato dalle “cassette” degli anni Ottanta, suona oggi negli studi di graphic designer berlinesi. Una canzone non firma trattati, ma abitua l’orecchio: dopo averla canticchiata non guardi più quel Paese come una sagoma lontana.
In tutto questo, la Cina è un’ombra che illumina. Le comunità cinesi radicate da generazioni in Malaysia, Singapore, Thailandia, Filippine sono ponte e specchio: fanno da cerniera tra capitale e cultura, tra genealogie e fatture. Nei porti, la presenza di banche e conglomerati cinesi non è soltanto investimento: è alfabeto urbano. Ma ogni governo decide il proprio filtro: l’Australia distingue il ferro dalla sicurezza; la Nuova Zelanda separa latte e intelligence; l’Indonesia accetta fonderie ma non cede parlamenti; il Vietnam compra componenti e presidia scogli; il Giappone amplia basi ma non rinuncia a vendere sul mercato cinese; la Corea del Sud pesa ogni parola perché vende schermi e compra pace; la Corea del Nord non decide quasi nulla, subisce.
Vent’anni fa questo mare era “periferia con potenziale”. Poi la crescita cinese ha tirato catene globali fino a Singapore e oltre; il “Pivot to Asia”, il riequilibrio strategico di Obama verso l’Asia orientale, ha steso ombre di portaerei; il Giappone ha rialzato la guardia; l’Australia ha trasformato l’alleanza in architettura militare; l’Asean ha imparato a danzare con entrambi, trattando Pechino come partner inevitabile e Washington come assicurazione sulla vita. Nel frattempo, sotto la superficie, sono passati cavi che portano la maggior parte del traffico dati del pianeta; sopra, rotte che muovono oltre metà del commercio mondiale. Ogni porto, Tuas, Laem Chabang, Yokohama diventa nodo di un modello di rete di trasporto dove un guasto può significare una crisi.
Alla fine, la domanda non è se questa regione sia vicina o lontana: è quanto siamo disposti a capirla senza incasellarla. L’arcipelago strategico non è una scenografia per la sfida Usa-Cina: è casa di popoli che tengono insieme apertura e identità, crescita e riti, tecnologia e maree, memoria e progetto. Il Vietnam di Ho Chi Minh e di Giáp non è una cartolina di resistenza: è la radice di un presente che commercia con chi un tempo combatteva e negozia con chi un tempo chiamava compagno. L’Australia non è solo ferro: è un esperimento quotidiano di convivenza tra storie diverse. Il Giappone non è solo treni: è una disciplina che cerca ancora un perché. La Corea non è solo neon: è il peso di un confine che non dorme. E la Cina non è solo minaccia o salvatore: è la condizione di possibilità di quasi tutto ciò che accade qui, il vicino con cui si firma un contratto al mattino e si prepara un piano B alla sera.
La distanza, alla fine, resta. Ma non separa: misura il tempo che ci resta per decidere se l’arcipelago sarà un ponte o una linea di frattura. E ascoltando bene, nel rumore dei porti, dei mercati e dei festival, si sente già la risposta che viene da queste latitudini: aprirsi senza perdersi. Innovare restando fortemente radicati alla tradizione. È il loro modo di stare al mondo. È la lezione che ci offrono. E, mentre in Europa chiudiamo i bar e le piazze si fanno silenziose, da questa parte del globo il giorno è già a metà: il Pacifico non aspetta; indica semplicemente la rotta.