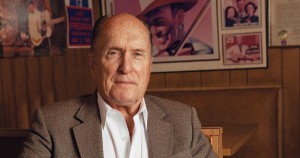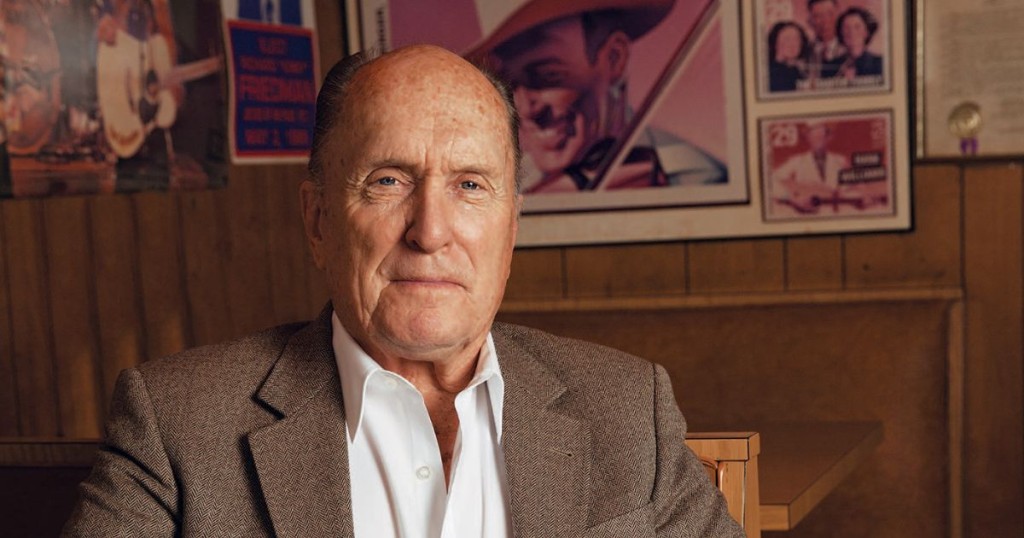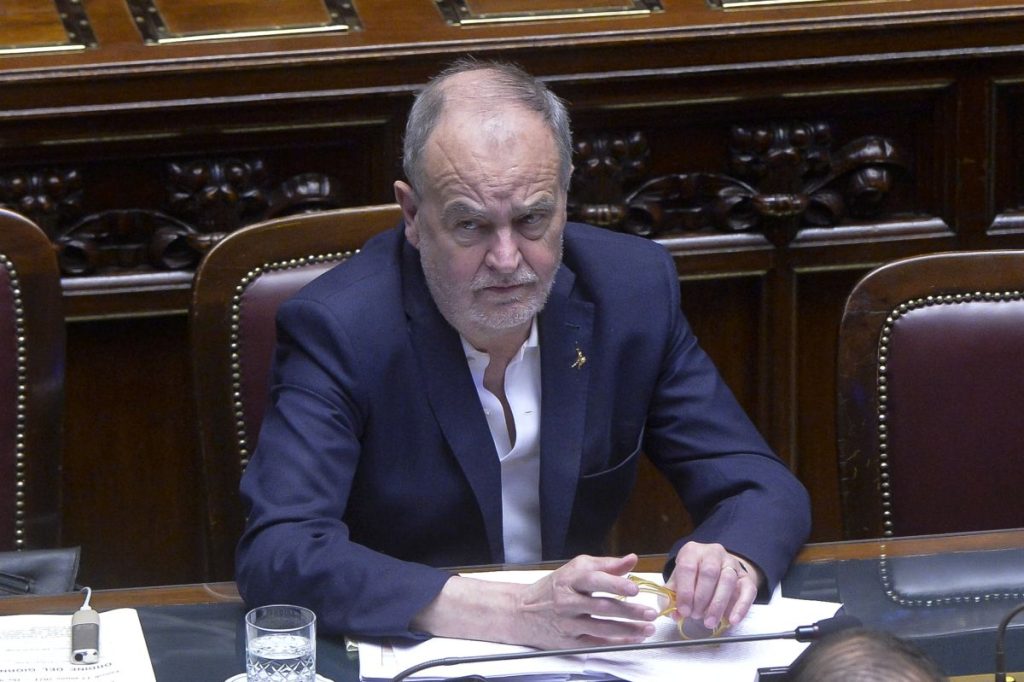Se vi piace uscire con gli amici, cenare insieme, chiacchierare, ci sono molti argomenti che potete continuare a ignorare senza rimanere per forza tagliati fuori dalla conversazione: il rock britannico, Guerre Stellari, persino il festival di Sanremo, persino il calcio. Ma chi non ha mai visto “Squid Game” rischia di trovarsi tagliato fuori: solo nei suoi primi tre mesi di programmazione, le persone che hanno visto o perlomeno cominciato a vedere Squid Game sono state, nel mondo, circa 265 milioni; nel primo mese le ore viste sono state, complessivamente, un miliardo e 650 milioni.
Facciamo conto che non sappiate di che stiamo parlando: è una serie televisiva prodotta e realizzata in Corea del Sud nella quale, per farla breve, s’immagina una gara all’ultimo sangue fra 455 persone finanziariamente nei guai; a chi vince andrà una somma equivalente a circa 30 milioni di euro, tutti gli altri, via via, muoiono attraversando una serie di prove con esito appunto letale: ah, il più delle volte la morte è piuttosto cruenta.
Che è successo nel mondo? Perché un prodotto il cui contenuto, così descritto, che sembra puerile e anche poco adatto alle famiglie è riuscito a sbaragliare l’entertainment di Paramount e Disney conquistando il pubblico di ogni età, dappertutto? È che, fra le altre cose, da una decina d’anni il mondo si è innamorato della Corea del Sud: tutto quel che viene da lì continua a destare una crescita di attenzione globale che va dalla musica all’arte, dalla lingua al cibo. Cinema e prodotti audiovisivi sono, a detta di molti, un elemento centrale e traente di questa K-wawe, l’ondata coreana, che al momento non sembra conoscere limiti di età, appartenenza sociale e appartenenza geografica. K-pop, K-music, K-movie, la K di Korea (in inglese Corea si scrive con la K) è diventata una specie di marchio di garanzia del successo globale.
Sarà bene impadronirsi almeno di un termine fondamentale per capire: la K-wave, viene chiamata anche “hallyu”, neologismo che unisce la prima sillaba del nome locale della Corea (Hanguk) al termine “lyu” che da quelle parti significa appunto “onda”: la parola fu coniata dalla stampa cinese verso la fine degli anni Novanta, quando a Pechino ci si cominciò a rendere conto di un fenomeno che investiva con forza tutto l’estremo oriente. Come avviene per le onde, insomma, l’origine era locale: in Cina e Giappone si cominciava a percepire la crescita mediatica di una piccola nazione, in precedenza negletta se non dominata, che improvvisamente stava esportando musica e film cominciando a contaminare e a concorrere seriamente con l’industria dell’intrattenimento locale (e parliamo di vere e proprie potenze mondiali).
Per chi vuole approfondire, l’argomento è interessante: la K-story, permettiamoci di chiamarla così, va però riassunta per grandi linee. Nel secondo dopoguerra, il paese liberato dall’impero giapponese piomba quasi subito nella prima grande guerra esportata dagli Stati Uniti: la Guerra di Corea sarà il conflitto più sanguinoso di tutta la guerra fredda. Il paese ne esce devastato, diviso in due, con la Corea del Sud che nel 1954 è uno dei territori più poveri di tutto il mondo. Segue un avvicendarsi di dittature militari e una generale soggezione all’economia industriale giapponese. Solo nel 1993 arriva un governo civile, con Kim Young Sam: al ridimensionamento delle spese militari si accompagna l’attenzione per l’economia globale, intesa anche come sviluppo tecnologico e, fin d’allora, una generale enfasi per l’industria della cultura e dell’intrattenimento, che pur a fasi alterne orienterà gli investimenti dei governi anche successivi. Fra parentesi, fin da allora gli investimenti in connettività sono al centro della politica finanziaria locale: alla fine degli anni Novanta quasi ogni coreano disponeva di internet ad alta velocità, nel 2010 la banda larga era in ogni appartamento, e attualmente la rete 5G coreana è una delle migliori, più veloci e più vaste di tutto il mondo.
Il popolo coreano comincia a sviluppare una cultura pop destinata a prosperare, inizialmente nel mercato interno, grazie anche ad alcuni relitti legislativi delle dittature precedenti, che tendevano a limitare l’importazione di musica, film, arte e letteratura. Nei cinema permaneva ad esempio, anche negli anni Novanta, l’obbligo di proiezione di film nazionali per almeno il 40 percento della programmazione (una quota che provocherebbe nei gestori italiani di ieri e oggi una rivolta armata). Il mondo del cinema coreano avrebbe avuto la prontezza di riflessi di gestire con creatività e un forte investimento tecnico quella situazione favorevole: a tutt’oggi si può dire che gran parte del successo, a livello di esportazione, del cinema di quelle parti si debba anche a prodotti tecnicamente impegnativi e costosi come per esempio l’horror, genere cui lo stesso Squid Game e il film premio Oscar “Parasite” sono ampiamente debitori.
All’inizio degli anni Duemila il pop e il cinema coreano si trovano insomma in una posizione privilegiata, sia sul mercato interno che sui mercati adiacenti. È proprio allora che i prodotti di quelle parti cominciano a sconfinare e aggredire anche il mercato occidentale. L’elenco comincia a nutrirsi e nell’arco di dieci anni la Corea del Sud è pronta a sfornare dei successi, inattesi e virali, in tutti i campi dell’intrattenimento: Psy e il Gangnam Style, nel 2012, difficile scordarsene, e subito dopo i Bts, tanto per parlare di musica.
Quanto ai film, il riscontro in termini di diffusione si accompagna a un’attenzione critica e del mondo produttivo testimoniata anche dai tanti remake realizzati a Hollywood, da Oldboy (2003, Park Chan-wook) a Train to Busan (2016, Yeon Sang-ho). E dal tentativo, non sempre andato in porto, di attrarre nell’orbita Usa autori coreani, come lo stesso Bong Joon-ho, regista di quel “Parasite” che nel 2020, dopo aver vinto il festival di Cannes, è stato il primo film della storia non di lingua inglese a prendersi l’Oscar per il miglior film. Dopo i suoi primi successi il regista era stato convinto a lavorare a Hollywood, con “Snowpiercer” (2017) ma dopo un paio di film si decide a rilavorare nella sua terra e nella sua lingua per realizzare Parasite. Più libertà di movimento e di trama, una visione del racconto più innovativa e moderna, meno impicci, mentre il cinema popolare negli Stati Uniti comincia ad annegare nello sviluppo di franchising e remake, intrappolato da Batman, Uomo ragno e Star Wars, con una propensione scarsa a investire tanti soldi sulla produzione di storie originali.
E risiamo a “Squid Game”. Il prodotto è distribuito da Netflix, è vero: ma la Corea si sta attrezzando per una sua autonomia distributiva. Qual è la forza dirompente che ha reso così popolari i prodotti di fantasia coreani? C’è senz’altro la capacità e la volontà di rappresentare, come succede in Parasite e Squid Game, anche il forte conflitto di classe e le contraddizioni di un paese (ma forse di un mondo) in cui il contrasto fra ricchezza e povertà genera storie e personaggi che, non solo ai coreani, interessano più delle faccende di Thor e Iron Man.
Anche in casa nostra: ce lo conferma Daniele Cesarano, direttore dei prodotti di fiction Mediaset: «Negli ultimi anni, la Corea è diventata uno dei principali poli di innovazione nel mondo dell’audiovisivo. L’industria coreana ha saputo coniugare una drammaturgia universale con una straordinaria capacità di raccontare la complessità della società coreana, un aspetto che, negli ultimi anni, sembra essere andato perduto nel panorama europeo e americano».
Batman ci sta già facendo i conti, presto toccherà anche a Don Matteo e ai Cesaroni pensare a qualche ritocco.