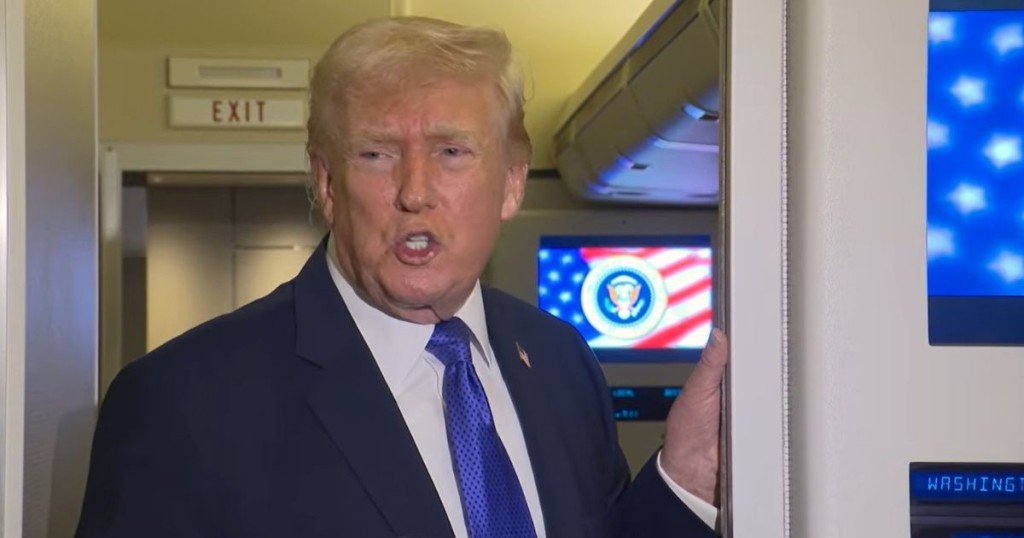Il vicepresidente Vance indica un nuovo approccio che modellerà la politica estera americana del futuro
L’operazione “Martello di mezzanotte” con cui Donald Trump domenica scorsa ha stupito il mondo colpendo di sorpresa i tre principali siti di ricerca e produzione nucleari iraniani (con dubbi risultati) potrebbe presto diventare una prassi consolidata. Al punto da fare scuola e diventare ufficialmente la dottrina di politica estera degli Stati Uniti.
A esserne convinto più di tutti è il vicepresidente americano J.D. Vance, che nelle ultime settimane ha giocato un ruolo politico importante come pontiere tra le bellicose esigenze dell’amministrazione del tycoon e una base poco propensa a farsi coinvolgere in una nuova avventura militare in Medio Oriente.
«Stiamo assistendo allo sviluppo di una dottrina di politica estera che cambierà in meglio il Paese (e il mondo): 1) definire chiaramente un interesse americano; 2) negoziare aggressivamente per raggiungere quell’interesse; 3) utilizzare una forza soverchiante se necessario», aveva twittato il vicepresidente americano martedì scorso rispondendo a un post di Trump che rivendicava a lettere cubitali la distruzione del programma nucleare iraniano (in realtà ancora tutta da confermare).
Poche ore più tardi, durante una cena organizzata dal Partito Repubblicano dell’Ohio, Vance è tornato sull’argomento sottolineando il successo dell’azione statunitense contro l’Iran e come questo potesse fungere da modello per la futura strategia della Casa Bianca. «Ciò che io chiamo Dottrina Trump», ha dichiarato il vicepresidente «è molto semplice: numero uno, definisci un chiaro interesse americano, in questo caso che l’Iran non possa avere l’arma nucleare; numero due, tenti di risolvere quel problema attraverso una diplomazia aggressiva; numero tre, quando non puoi risolverlo diplomaticamente, ricorri al soverchiante potere militare per risolverlo per poi ritirarti prima che questo si trasformi in un conflitto prolungato».
Appare tuttavia evidente come – a un’analisi critica – la “Dottrina Trump” presenti svariate falle di merito. Innanzitutto, sdogana un metodo delle relazioni internazionali che nei fatti si traduce nel principio del potere del più forte. Il teorema è semplice, proprio come dice Vance: in presenza di un interesse americano, gli Stati Uniti si ritengono autorizzati a impiegare la forza militare in maniera schiacciante per conseguirlo, qualora l’interlocutore in questione si mostri reticente a collaborare.
Si tratta, come si può facilmente intuire, di un approccio semplicistico e a tratti coloniale dei rapporti con gli altri Stati. In realtà, è chiaro che nei fatti non sia possibile intraprendere tale strada, innanzitutto proprio per la questione tanto cara ai suoi sostenitori, vale a dire i rapporti di forza. Se invece dell’Iran ci fosse stata la Russia oppure uno Stato legato a un’alleanza militare con la Cina come la Corea del Nord, gli Stati Uniti avrebbero davvero pensato di poter risolvere la questione inviando impunemente una mezza dozzina di bombardieri ad attaccare i propri avversari per poi dichiarare chiusa la partita? Evidentemente no, il che già presuppone la divisione del mondo in Paesi di serie A e di serie B.
La dissoluzione dell’ordine internazionale basato sulle regole sembra essere del resto tra gli obiettivi primari di questa amministrazione, un finis legis che punta a rendere la norma uno “stato di eccezione” delle relazioni internazionali. Come diceva Carl Schmitt, chi detiene davvero il potere in un sistema politico è chi comanda durante lo stato di eccezione e in questo frangente Donald Trump sembra convinto che gli Stati Uniti saranno quel qualcuno.
Certo, si potrebbe obiettare che questo approccio non abbia nulla di nuovo nella lunga storia di avventure militari statunitensi in giro per il mondo. Tuttavia, ciò che appare davvero innovativo – rispetto alla lunga epopea Neocon dell’era Bush – è l’attenzione rivolta a far sì che l’azione militare non si traduca in un coinvolgimento militare duraturo. Un “tira il sasso e nascondi la mano” geopolitico, insomma, che però potrebbe rivelarsi alla lunga insostenibile.
Pensare di poter intervenire in maniera tanto occasionale quanto dirompente, senza costruire un assetto locale capace di poter conservare una qualche stabilità, è un’idea destinata a rivelarsi illusoria. Lo stesso esempio mediorientale lo dimostra: lasciando nei fatti mano libera a Israele perché colpisse a suo piacimento l’Iran (eliminazione di Khamenei a parte) e colpendo apertamente il programma nucleare iraniano, Trump ha messo in moto in Medio Oriente dei processi politici imprevedibili ma che senza dubbio non si limiteranno alla blanda rappresaglia concordata inscenata dagli iraniani come risposta.
I report gravidi di dubbi che circolano sull’effettività dei raid americani potrebbero significare, nel prossimo futuro, la ripartenza del programma nucleare di Teheran e la riapertura del dossier iraniano. Teddy Roosevelt diceva che la miglior politica fosse parlare a bassa voce e portare con sé un grosso bastone. Incapace evidentemente di fare la prima, al tycoon non resta che agitare il secondo sperando che non sia già spuntato, ma è difficile vedere in questo una dottrina. Tanto meno una strategia.