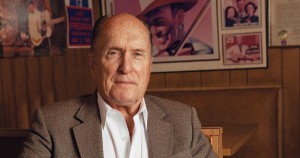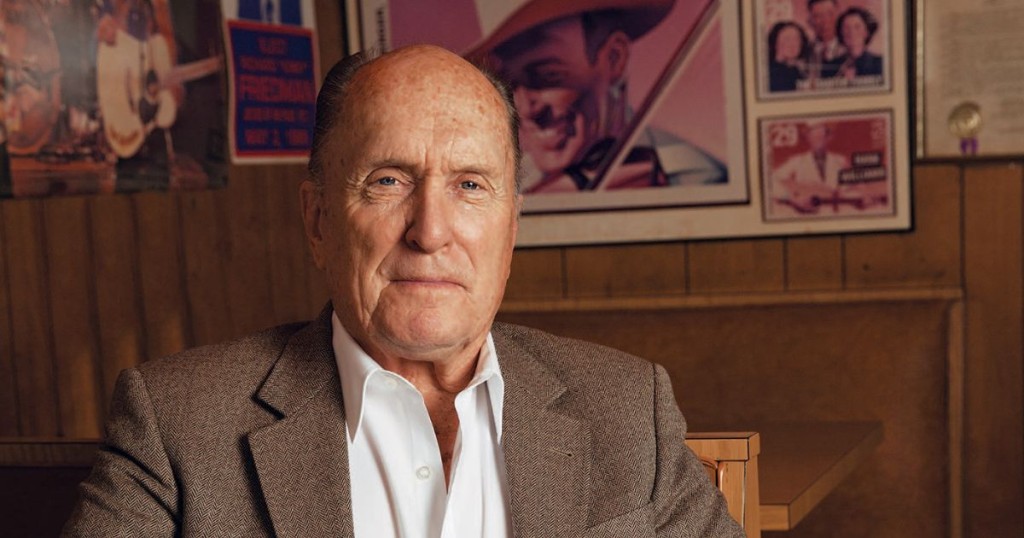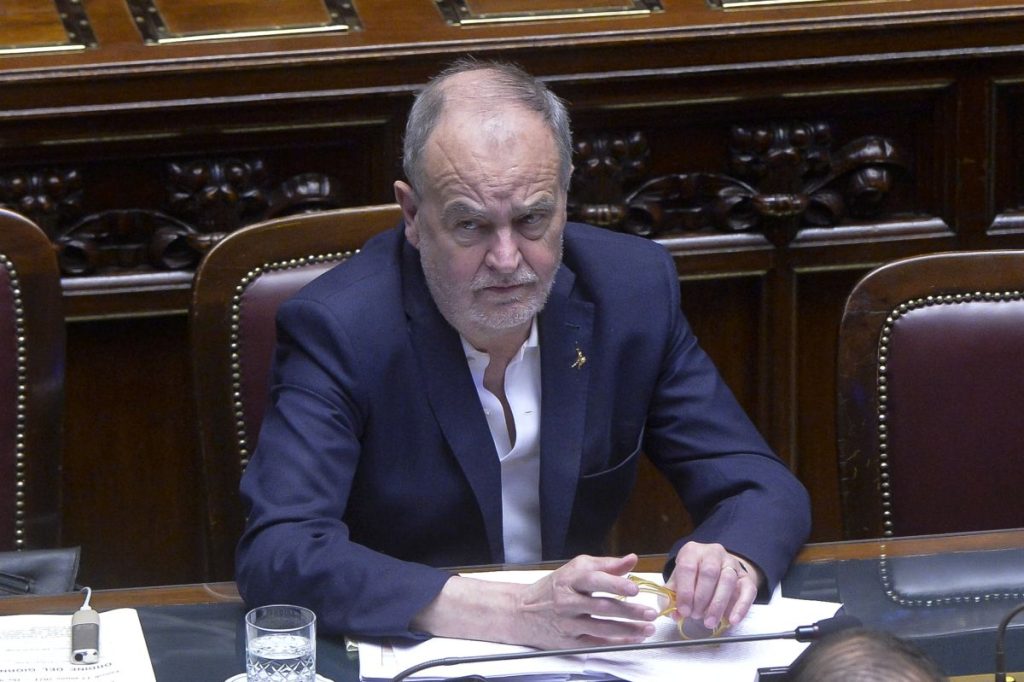La Banca d’Italia critica il taglio Irpef: riduce poco le diseguaglianze. Tassare la ricchezza o rilanciare servizi e concorrenza?
La Banca d’Italia, nel suo ultimo giudizio sulla manovra, ha osservato che il taglio dell’Irpef concentrato sul ceto medio ha un effetto redistributivo molto limitato. Non perché la misura sia sbagliata in sé, ma perché non incide in maniera rilevante sui redditi più bassi, che l’Irpef quasi non la pagano. Il problema, insomma, è che si interviene dove c’è il prelievo, ma non dove c’è il bisogno.
Se l’obiettivo è ridurre le diseguaglianze, non basta ridurre l’Irpef sul lavoro, anche perché la diseguaglianza oggi non nasce soprattutto dal reddito da lavoro, ma dalla ricchezza accumulata: case, azioni, fondi, rendite e posizioni di mercato che si rafforzano nel tempo.
È per questo che, nelle democrazie occidentali, dove negli ultimi anni la quota di ricchezza posseduta dall’1 per cento più ricco della popolazione è cresciuta in modo continuo, avanza un’altra proposta: tassare la ricchezza invece del reddito.
LEGGI ANCHE:
In Francia l’economista Gabriel Zucman ha proposto una patrimoniale annuale del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. A New York il nuovo sindaco Zohran Mamdani vorrebbe applicare una tassa analoga ai grandi patrimoni cittadini per finanziare case popolari, sanità territoriale, trasporti pubblici.
LEGGI Zohran Mamdani, il nuovo ‘santino’ global della sinistra italiana
In Italia la tassazione della ricchezza è da sempre una bandiera della sinistra dura e pura, ma ora se ne inizia a parlare anche in ambienti più moderati. Non a caso l’argomento sarà al centro giovedì prossimo di un seminario all’Università Cattolica di Milano, intitolato «Per una migliore imposizione fiscale sul patrimonio».
La logica di molte proposte di intervento sulla ricchezza è apparentemente semplice: chi ha di più contribuisca di più. Soprattutto quando la ricchezza è frutto di oligopoli e concentrazioni ereditarie, che la rendono meno giustificabile sul piano morale. Ma la realtà economica è più complessa.
Tassare la ricchezza riduce il rendimento del capitale e quindi modifica gli incentivi a investire.
In molti Paesi una patrimoniale significativa ha prodotto effetti indesiderati, come la fuga di capitali verso giurisdizioni più favorevoli, l’elusione e l’evasione fiscale, la riduzione degli investimenti a più alto rendimento (quelli più innovativi).
In Svizzera, in Danimarca e in Svezia, l’aumento della patrimoniale ha portato in pochi anni a un calo drastico della ricchezza dichiarata, senza che la ricchezza reale sparisse: si è semplicemente spostata altrove. Per questo alcuni economisti sostengono che la “Zucman tax” potrebbe ottenere un gettito molto inferiore a quello previsto e avere un impatto negativo sulla crescita. Il punto non è negare la necessità di ridurre la diseguaglianza, che è reale. Ma è come farlo in modo efficace.
La redistribuzione non si ottiene agendo solo sul prelievo fiscale, ma anche sulla qualità e l’onerosità dei servizi. Significa abbassare il costo della casa, rendere la scuola un ascensore sociale e non una conferma dello status, accorciare le liste d’attesa della sanità pubblica, rompere le rendite nei settori non concorrenziali, sostenere salari e produttività dove si crea valore.
Perché la redistribuzione efficace non è togliere a qualcuno, ma mettere i molti in condizione di avanzare.
La patrimoniale è una bandiera. Il taglio dell’Irpef è una misura. La redistribuzione, quella vera, è una politica: riguarda la casa, la scuola, la salute, il lavoro, cioè la vita quotidiana. È qui che la diseguaglianza va snidata. Ma è proprio questa la parte difficile. Perché non si cambiano queste policy senza rilanciare la concorrenza e modificare la spesa pubblica, il totem delle politiche economiche degli ultimi decenni, davanti al quale ogni migliore intenzione del premier di turno ha finito per arretrare. Il riformismo zoppo del Paese sta nella rinuncia a sfidare minoranze organizzate, categorie, corporazioni, blocchi di interesse che si presentano come rappresentanze sociali, e che invece sono spesso forze di resistenza alla trasformazione.
Sono gruppi piccoli, ma spesso percepiti politicamente più decisivi di quanto siano nella realtà. Nessuna politica, e neanche quella in carica, ha fin qui osato deluderli. Anzi più spesso li ha compiaciuti con misure, incentivi, sconti e rottamazioni sartorialmente ritagliate sui loro egoismi.
Per averne prova basta constatare che cosa è cambiato di sostanziale negli ultimi dieci anni nel braccio di ferro tra i governi e i tassisti, i balneari, i medici di base, concessionari esclusivi di servizi pubblici altamente inefficienti e inutilmente chiamati a condividere policy trasformative. Nessuna forza politica ha fin qui disarmato la loro trincea con una pedagogia della crescita, convincendoli a rinunciare a qualcosa oggi in ragione di un vantaggio collettivo futuro, e di fare breccia nell’opinione pubblica.
Questo per dire che redistribuzione e giustizia sociale non si fanno a colpi d’accetta sulla ricchezza, con il rischio di farla scappare. E non si fanno senza corpi intermedi capaci di condividere responsabilità, piuttosto che difendere rendite.