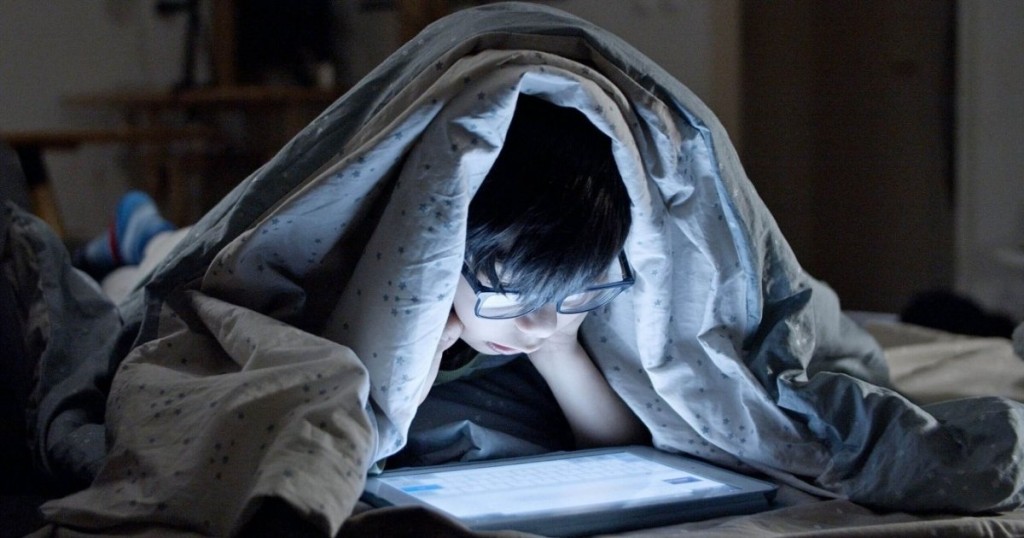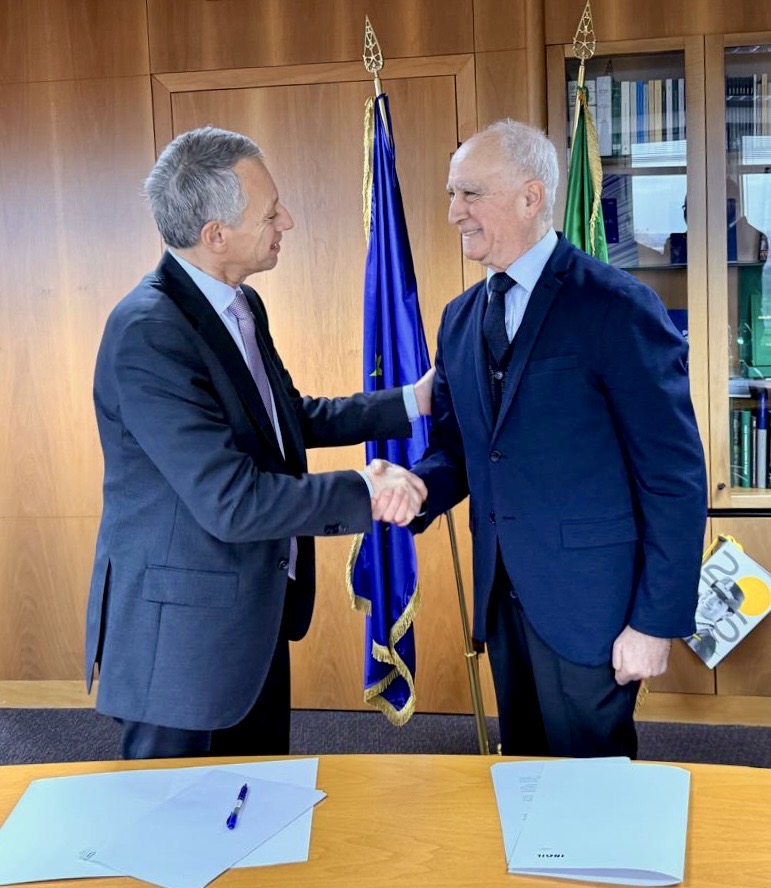Nel suo discorso al Meeting di Rimini la presidente del Consiglio si è rivolta al ceto medio, individuandolo come riferimento della sua politica sociale ed economica. La premier vuole farsi portavoce di un settore messo ai margini del dibattito pubblico e di cui spesso si è faticato perfino a riconoscere l’esistenza. Giuseppe De Rita, presidente del Censis, ha riflettuto a lungo sul tema. Del 2004 è il libro, scritto insieme ad Aldo Bonomi e Massimo Cacciari, Che fine ha fatto la borghesia? (Einaudi).
Presidente, storicamente da chi è rappresentato il ceto medio?
«Il fenomeno di quella che io e altri chiamammo “cetomedizzazione” d’Italia è cominciato negli anni Settanta. Il ceto medio derivava, in parte, dalla piccola classe burocratica, in parte da contadini, artigiani, industriali milanesi che diventavano piccoli imprenditori e in parte ancora derivava dallo sviluppo della burocrazia locale».
Nel mondo della cultura che reazioni incontrò quando iniziò a mettere al centro delle sue ricerche il tema del ceto medio?
«Sylos Labini scrisse un libro sulla fine delle classi sociali. Poi andammo insieme da Pasolini, che ci disse: “ma che cos’è questo ceto medio? È la piccola borghesia ignobile, parassita, che non ha responsabilità, che non sarà mai un gruppo sociale strutturato”. Da quell’epoca, tutto sommato, nell’opinione pubblica ha vinto l’ipotesi pasoliniana, quella per cui il ceto medio è formato da piccoli borghesi egoisti senza alcun senso della collettività. Io sostenevo invece la tesi di un ceto medio che accoglieva come una betoniera una grande quantità di materia informe che si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di più serio, in una neoborghesia, quasi una nuova classe. Ha prevalso però l’idea che il ceto medio sia qualcosa da anni Settanta e che non è una categoria utile per interpretare la società dopo quell’epoca».
Oggi che cosa sta succedendo? Il ceto medio svolge una nuova funzione?
«La dimensione intermedia diventa importante nel momento in cui si verticalizza il potere. Se si verticalizza il potere, sotto non c’è più un assetto di classe, di etnie ecc, rimane un vuoto. Quello di creare un ceto medio americano credo sia l’intento di Trump. Lui lo fa alimentando la paura dei migranti e attraverso lo statalismo economico. Lo fa come lo farebbe un democristiano degli anni ’50. Ma la sua idea è che per fare politica serva una sponda di ceto medio. Mi viene in mente un paragone forse un po’ avventato…»
Prego.
«Pensiamo al caso di Milano. Milano è la verticalizzazione, in una città, di una cultura di avanzamento e di ricchezza, che non tiene conto che l’avanzamento di tutto il sistema c’è se c’è l’avanzamento del ceto medio, come è stato in Italia durante il miracolo economico. Se non c’è il ceto medio non si può fare politica».
Torniamo al discorso della premier. La ragione per cui Meloni si è rivolta al ceto medio è perché ha capito la sua funzione vitale nelle democrazie di oggi?
«La Meloni è una leader astuta. Ha capito che nel vuoto della dimensione intermedia di oggi, dove i sindacati e tutti gli enti intermedi come regioni e province non contano più nulla, rivolgersi al ceto medio significa agitare un problema che è sconosciuto ai più ma che ha al proprio interno un’enorme potenzialità».
La premier ha fatto riferimento a un piano casa volto ad aiutare le giovani coppie. Il tema della casa era stato già fortemente identitario negli anni di Berlusconi. Oggi che senso può avere rilanciarlo per un governo di destra?
«Il ceto medio italiano dagli anni ’50 agli anni ’80 ha avuto un incredibile bisogno di casa. E in fondo è riuscito ad appagare questo bisogno. Le prime leggi sull’edilizia erano tutte un incentivo che andava in questa direzione, perché la casa era un fatto determinante e identitario. Ma ritengo che oggi non lo sia più, il ceto medio italiano ormai la casa ce l’ha. Tanto è vero che si parla sempre più di studentati universitari o di case per gli immigrati. Cioè non di casa vera e propria, ma di servizi di assistenza ai singoli o a singoli gruppi sociali. Non siamo più negli anni ’50, quando c’erano milioni di persone che aspettavano solo di farsi la casa. Certo, la parola “casa” colpisce tutti, ma dire di dare soldi a dei giovanotti che si stanno sposando mi sembra poco serio. Ci sono già possibilità di fare mutui, oltre al fatto che intere fasce di popolazione giovanile ereditano la casa dai genitori o dai nonni. Per queste ragioni il tema della casa non mi pare un tema su cui innestare una proposta politica».
E su quali temi sarebbe opportuno innestarla?
«Ad esempio sul fisco e sulle pensioni. Buona parte del ceto medio di oggi è fatto da pensionati o da gente che sta per andare in pensione».
La premier ha fatto riferimento anche al lavoro come luogo di dignità e collaborazione e non di conflitto. È convinto che si tratti anche in questo caso di retorica politica oppure c’è in gioco una presa di distanza da un modello neoliberista tutto incentrato sulla competizione e la concorrenza?
«Molti dei temi sollevati da Meloni sono temi caratteristici della “prateria moderata” in cui intende muoversi: il lavoro, la sussidiarietà, l’eredità cattolica sono tutte cose che fanno parte di una tentazione moderata, oppure della furbizia e della capacità di inserirsi in quel campo. La premier ha fatto un discorso ai moderati italiani, un mondo sensibile a queste questioni e che inoltre è molto cattolico. Meloni intende captare la dimensione cattolica del Pd che si sente prigioniera della segreteria attuale».
In effetti la premier ha fatto più di un richiamo a pensatori cattolici, complice anche il contesto in cui si trovava. Ha fatto riferimento a un primato della persona rispetto all’ideologia, dell’individuo rispetto alle idee. Tutto però non in un’ottica relativista ma comunitaria. Ha citato il filosofo cattolico Guitton, “mille miliardi di idee non valgono una sola persona”.
«Sono citazioni che noi facevamo negli anni ’50 e ’60, è il personalismo di Maritain, non c’è bisogno di arrivare a Guitton. Tutta la cultura cattolica e democristiana è stata una cultura moderata, e lei è in cerca quell’eredità».
La Meloni però ha un’eredità culturale molto diversa, che contempla sì una certa idea di comunità, di lavoro e di famiglia, ma che non è un’eredità cattolica. Quanto è credibile questo tentativo di agganciarsi alla tradizione cattolica?
«Quando fai politica e cerchi di occupare uno spazio devi anche cercare di prenderti la filosofia di quello spazio. È una partita che la premier può giocare e che sta giocando con abilità. Dall’esterno però si capisce che, come dicevo, gioca su una prateria moderata, con citazioni moderate e con ascendenze democristiane».
Non sono poi mancate le sferzate a chi ritiene la genitorialità il retaggio di una cultura patriarcale. La destra di Meloni che idea di famiglia incarna? Solo quella di famiglia tradizionale oppure può adeguare questa prospettiva al tempo attuale?
«Nell’area moderata la famiglia classica è ancora quella che tira di più. Tutto sommato, viviamo quasi tutti in una famiglia “normale”. Il problema di cosa è “non normale” a Meloni non interessa. Perché mai dovrebbe interessarsi alla galassia Lgbt se già se ne occupa la Schlein? Certo, se ne interessa anche il Papa. Ma il Papa è su un altro piano: da una prospettiva pastorale non si possono lasciare le pecore ai margini. Ma per chi fa politica oggi in un’area moderata, la lotta fondamentale è la protezione della famiglia tradizionale. Tutto questo sarà anche reazionario, ma fa parte di quel disegno politico».
Il discorso della premier è stato tutto giocato sulla tensione tra tradizione e innovazione e i punti che ha toccato sembravano punti programmatici di una nuova destra, ancorata al proprio passato ma anche capace di guardare al futuro. Lei come la vede?
«L’italiano medio gestiva la sua tradizione, che era una tradizione contadina, paesana, localistica. Sapeva che l’innovazione veniva da fuori, dalla ricerca operativa, dall’automazione. Detto brutalmente: veniva dall’America. Questo anche sul piano morale. È dagli Usa che è arrivata l’idea del divorzio. Eravamo tutti consapevoli di questa ascendenza. Oggi non c’è bisogno di rivendicare l’identità di una tradizione: sappiamo qual è la tradizione italiana e la premier si rivolge a una parte di popolazione che è consapevole di questo. Quindi lei fa qualche citazione, ma fa citazioni di autori cattolici e non per esempio di Carl Schmitt. Tutto questo testimonia però anche la povertà della cultura italiana attuale. Nessuno di noi cattolici ha avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto un David Maria Turoldo, un Camillo De Piaz o un don Primo Mazzolari. Non ci sono coloro che ispirano autonomamente la dimensione della pianura moderata, che difetta di eroi endogeni. E per questo può essere interpretata da tutti. Chi come Meloni naviga in quelle acque può stare tranquillo, perché non c’è nessuno che sappia esprimere la situazione sociale italiana in termini diversi rispetto al continuo richiamo al passato».
Intende dire che la cultura italiana è segnata da una forma di nostalgismo strutturale?
«Tutta la cultura del ceto medio è una cultura di nostalgia del passato. Qualche giorno fa ho letto un lungo articolo su un quotidiano italiano dedicato alla trasmissione televisiva Bim Bum Bam. Attori e registi ne ricordavano la meravigliosa era. Per molto tempo quella trasmissione è stata scritta da mia moglie, che non credo si riconoscerebbe nella ricostruzione che ne è stata fatta. Il problema è che oggi è tutto un rimestare l’esistente. Questo è il pericolo dell’attuale pianura moderata, ma non del ceto medio, che è molto più realista e se ne frega di rimestare l’esistente».