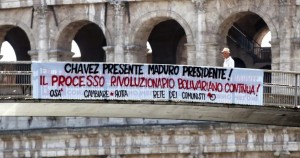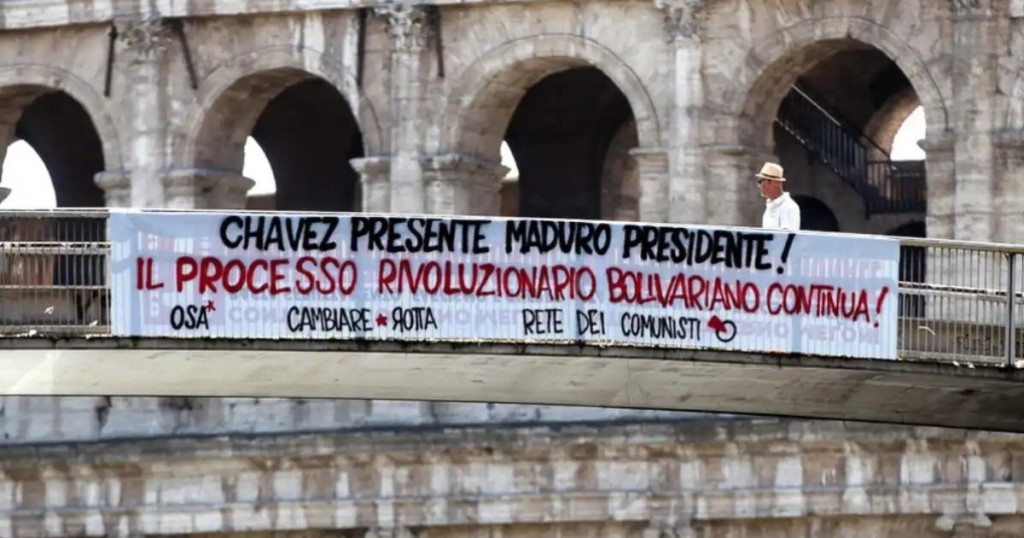Sulla morte di Pippo Baudo e sul suo ruolo di uomo di spettacolo sono stati scritti molti articoli, ricordi, testimonianze. Meno discusso, invece, è il contesto politico-culturale in cui Baudo ha operato, in particolare il legame con la Democrazia Cristiana, il suo rapporto con il servizio pubblico e il modo in cui quel partito ha accompagnato o frenato la transizione italiana dalla politica dei partiti alla “democrazia del pubblico”. Ne abbiamo parlato con Gaetano Quagliariello, professore di Storia contemporanea alla Luiss “Guido Carli”, già senatore e ministro per le Riforme costituzionali, studioso dei partiti e dei sistemi politici.
Professore, si dice che oggi tendiamo a rimpiangere la stagione della Dc e del servizio pubblico dell’epoca. È solo nostalgia o c’è qualcosa di più profondo?
«Rispetto alla Dc e al rapporto tra servizio pubblico e maggioranze di governo, il discorso è più complesso. La stagione democristiana in politica è finita prima (e più traumaticamente) che in altri ambiti della società. In politica quella stagione era legata a due cose. Da una parte, al tempo del suo trionfo, non poteva fare a meno di un ruolo preminente della Chiesa: aveva bisogno che il fenomeno di secolarizzazione del Paese fosse quanto meno controllato. Sciascia intuisce la fine di quella stagione già nel 1974, in contemporanea con il referendum sul divorzio. L’altro fattore decisivo è stato la Guerra fredda. Quando è venuto meno il cosiddetto fattore K, quella stagione è finita del tutto. Questo vale per quanto concerne prima l’egemonia e poi la persistenza della “democristianità” in politica. In altri ambiti della società, invece, quella cultura ha avuto la possibilità di farsi apprezzare anche oltre quelle stagioni, perché non dipendeva così profondamente da elementi esogeni. Il fenomeno democristiano è stato un mondo, molto più che un partito. La Dc era un universo in cui hanno convissuto e imparato a stare insieme cose molto diverse. Questa arte, al di fuori della politica, è stata possibile apprezzarla e valutarla anche per un tempo più lungo».
Lei lega questa riflessione subito alla televisione e a Baudo, perché?
«Quando parliamo di Pippo Baudo, parliamo della televisione. E la televisione è stata la grande protagonista della stagione che in Italia è succeduta a quella dei partiti. Quando è venuta meno la centralità del partito, si è affermata la cosiddetta “democrazia del pubblico”, e lo strumento che in qualche modo ha inverato questa nuova stagione è stata la televisione. Ora, il partito non è stato mai fino in fondo il terreno della Dc, perché questa era un mondo, non un semplice partito e il modello di riferimento per il partito di massa è stato piuttosto quello del Pci. Pippo Baudo come incarnazione della democristianità, invece, nell’universo televisivo ha avuto un ruolo centrale. Ha rappresentato l’icona della capacità di intuire la novità, di integrarla, di renderla compatibile, di non esasperarne i contenuti. Lo ha fatto anche con una certa energia, perché la mediazione che ha effettuato Baudo non è stata una mediazione al ribasso. Fondamentalmente, quando questa mediazione è entrata in crisi, al tempo dei talk show, ad essere spiazzate sono state innanzitutto le culture antagoniste alla Dc. Il talk show, tranne che per sue rare versioni, ha rappresentato un superamento dell’antagonismo comunista e uno stravolgimento di alcuni valori di moderazione e conservazione sociale che quel partito incarnava».
Baudo raccontava di un rapporto diretto ma anche protettivo della Dc con la Rai. Quanto ha contato questo legame?
«Ha contato molto, perché gli ha consentito di interpretare alcune esigenze che erano iscritte nella società e che per un certo tempo la politica italiana aveva bloccato sull’uscio. Bisogna tenere conto di una cosa: la democrazia del pubblico in Italia arriva con 15-20 anni di ritardo rispetto alle altre democrazie avanzate. Una delle anomalie italiane è che i partiti di integrazione sociale hanno mantenuto quel ruolo per molti più anni rispetto ad altri Paesi. Pensi alla Francia: già negli anni Sessanta, con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, cambia tutto e quel tipo di partito finisce. Pensi anche all’Inghilterra: c’è una trasformazione evidente dei partiti. In Italia tutto questo resta bloccato e, in quei frangenti, figure come Baudo, che hanno interpretato con una certa libertà il loro ruolo nel servizio pubblico, hanno anticipato alcuni tratti che poi sarebbero stati propri della tv commerciale. La mediazione non si è trasferita alla politica perché qui la transizione è stata cruenta. A tal proposito, si è molto enfatizzato il presunto vantaggio competitivo di Berlusconi, proprietario di tre reti televisive, e messo poco in evidenza il fatto che egli era un uomo di televisione e che la sua azienda fosse un’azienda televisiva. Ed è questo che gli ha dato un osservatorio privilegiato per comprendere meglio i cambiamenti sociali, che altri hanno faticato a cogliere. Non a caso il 1994 e l’epifania del Cavaliere sono stati una rivoluzione complessiva che ha coinvolto tutti i partiti. È come se l’effetto fosse stato amplificato perché a lungo si era cercato di evitarlo o di affidare la rappresentazione del cambiamento sociale a figure che non avessero un ritorno immediatamente politico. A un certo punto, questo schema non ha retto».
Che rapporto c’era tra Baudo, la secolarizzazione e il servizio pubblico?
«Negli anni in cui siamo cresciuti noi, il cattolicesimo non era solo una religione praticata dalle persone, ma qualcosa che ha inciso profondamente sulla politica e anche sui contenuti televisivi. Baudo, per questo, ha avuto un ruolo particolare. Ha introdotto spiragli di secolarizzazione in forme che definirei “omeopatiche”. Ha compreso che non era possibile resistere chiudendosi nel fortino e che nemmeno spettava alla Rai fare quel lavoro di resistenza integrale. C’è stato un momento in cui quei principi e quei valori che erano propri della principale agenzia di riferimento della Dc, la Chiesa, non potevano più essere mantenuti in maniera totalizzante. Il problema, a quel punto, diveniva la necessità di una rigenerazione della stessa Chiesa. Tanto è vero che si è passati dalla Chiesa trionfante, portatrice di valori maggioritari, alla teoria delle minoranze creative, cioè all’idea che quei valori, per sopravvivere, dovessero essere propri di realtà minoritarie. Il servizio pubblico e lo spettacolo potevano rendere questo passaggio meno traumatico. In questo Baudo è stato geniale: ha gestito la transizione in modo non traumatico, non come rottura ma come passaggio».
Negli anni Ottanta, però, la Rai perde l’egemonia e si afferma la tv commerciale.
«Sì, è stato un inseguimento. Ma un inseguimento che ha garantito che la partita fosse tra Coppi e Bartali, non tra un dominatore e un vinto. Personaggi come Baudo, Bongiorno, Corrado, Vianello hanno lavorato da un lato e dall’altro, creando una certa osmosi. La trasmissione che a mio avviso ha segnato la rottura principale è stata Drive In: “l’idealtipo” di una nuova stagione al contempo sociale e televisiva. Da quel momento i due mondi, pur non nettamente separati, hanno scontato una evidente rottura. Nell’ambito della politica televisiva, Baudo ha rappresentato la conservazione possibile, laddove si sarebbe potuti cadere nella conservazione impossibile, con esiti molto più laceranti».
Baudo è solo una figura del passato o c’è qualcosa di lui che parla al presente?
«È sbagliato ritenere Baudo il passato. Non è un caso che venga rivendicato persino da personaggi come Fiorello o da tanti protagonisti di oggi. Declinarlo solo attraverso la categoria della nostalgia mi lascia perplesso. Baudo non era un uomo di regime, ma un personaggio che aveva misura e, nello stesso tempo, capacità di cogliere le novità e di integrarle in un discorso che aveva spessore, che non perdeva il senso della sedimentazione dei fenomeni e quindi anche del passato. Ed è proprio questo l’elemento che oggi è più difficile da replicare: la capacità di dare forma a un presente che non sia solo consumo immediato, ma che tenga conto della profondità storica. Per chi voglia perseguire questo tentativo, Baudo è ancora un riferimento».