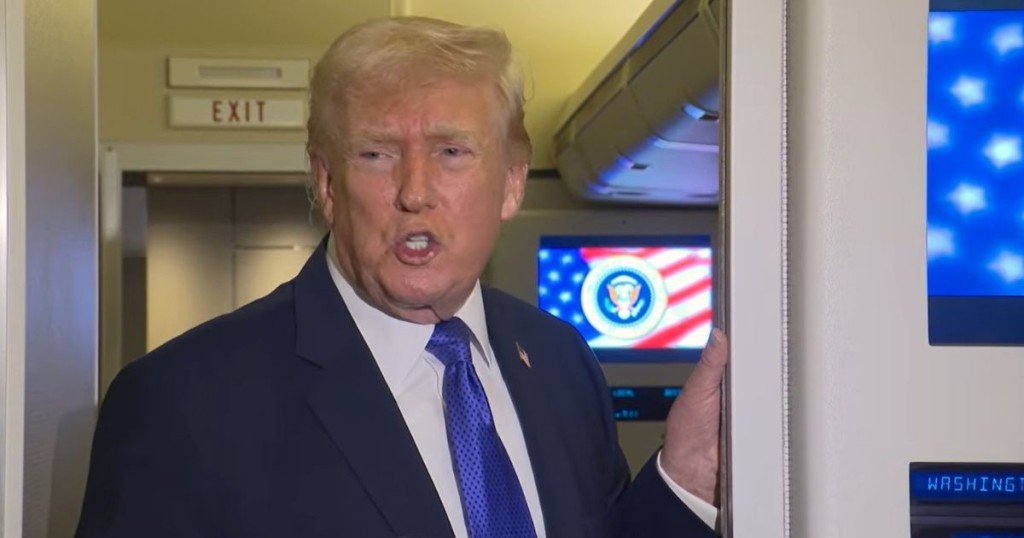La questione del comandante libico Almasri, accusato di gravi violenze nei centri di detenzione in Libia, è tornata in cima alle cronache politiche dopo che, nella serata di lunedì, è stata notificata alla premier Meloni l’archiviazione del procedimento nei suoi confronti, avviato dopo che il governo aveva deciso di rilasciare Almasri nonostante su di lui pendesse un mandato di arresto della corte penale internazionale. Analizziamo la vicenda sotto un profilo giuridico con Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Enna “Kore”.
Professore, il procedimento nei confronti della premier è stato archiviato. Lei che idea si è fatto?
«Da quanto emerge dalle sintesi che leggiamo, sembra che la procura di Roma abbia scisso la responsabilità politica della premier dalla sua responsabilità giuridica, come a dire: non ci sono atti ufficiali in cui la Presidente del Consiglio assume la decisione di rispedire in Libia Almasri e quindi non ricorrono le ipotesi dei reati ipotizzati».
Che, nel caso specifico, sono i reati di peculato e favoreggiamento.
«Si tratta di ipotesi abbastanza ardite, soprattutto per quanto riguarda il peculato».
Perché?
«Perché non si sta parlando di prendere un aereo e usarlo per fini privati, ma per fini istituzionali, per quanto sindacabili. Per questo l’ipotesi di peculato mi sembra molto ardita».
E sulla separazione della responsabilità politica da quella giuridica cosa può dire?
«Si tratta sicuramente di piani che vanno distinti, perché non tutto ciò che è politicamente inopportuno diventa un reato. Però nel caso specifico questa separazione mi lascia perplesso, perché la premier, sulla base dell’art. 95 della Costituzione, ha il compito di assicurare la direzione unitaria del governo. Separare i due profili solo perché materialmente la premier non ha firmato l’atto, è un’operazione discutibile. D’altra parte, con grande onestà intellettuale, la Meloni ha rivendicato quel provvedimento e ammesso che il governo ha agito in maniera unitaria».
Del resto, è stata chiesta l’autorizzazione a procedere, oltre che per i ministri Nordio e Piantedosi, anche per il sottosegretario Mantovano, che fa riferimento direttamente alla Presidente del Consiglio.
«E questo mi lascia ancora più perplesso, perché se nel caso dei ministri si può ipotizzare una responsabilità individuale dei soggetti che hanno gestito la vicenda, il sottosegretario agisce per delega del Presidente del Consiglio. Quindi come si fa a pensare che il sottosegretario sia penalmente responsabile di qualcosa che ha fatto sulla base di una delega e che invece il delegante non sia responsabile?»
Al ministro Nordio, oltre al favoreggiamento, è contestata l’omissione di atti ufficio. Crede che anche in questo caso l’accusa sia campata in aria?
«Sotto il profilo giuridico, credo che l’ipotesi abbia un qualche fondamento. E personalmente credo anche che di fronte a un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, il ministro avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più collaborativo. Ho l’impressione che il governo, per non assumere una posizione decisa, abbia voluto appigliarsi a un’eccezione procedurale. Il problema è che il ministro ha posto la vicenda tutta su un piano giuridico, facendone una questione di legittimità, di rispetto delle regole e delle procedure. In questo modo si è esposto a obiezioni e contestazioni su quello stesso piano».
Come avrebbe dovuto agire?
«Il ministro Nordio e gli altri coinvolti avrebbero dovuto porre la questione su un piano puramente politico, prendendo il toro per le torna e dichiarando chiaramente che la decisione era stata presa sulla base dell’interesse nazionale e assumendosene le responsabilità politiche. Paradossalmente, questo sarà anche il punto di arrivo di tutta questa vicenda».
Si riferisce al fatto che il Parlamento respingerà l’autorizzazione a procedere?
«La Camera chiamerà in causa la legge costituzionale sulla responsabilità dei ministri in cui si stabilisce che viene negata l’autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri “ove si reputi che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”. Quindi, negando l’autorizzazione a procedere, la Camera espliciterà quell’elemento di ragion di Stato che il governo, ponendo la questione su un piano esclusivamente procedurale, ha tenuto in secondo piano».