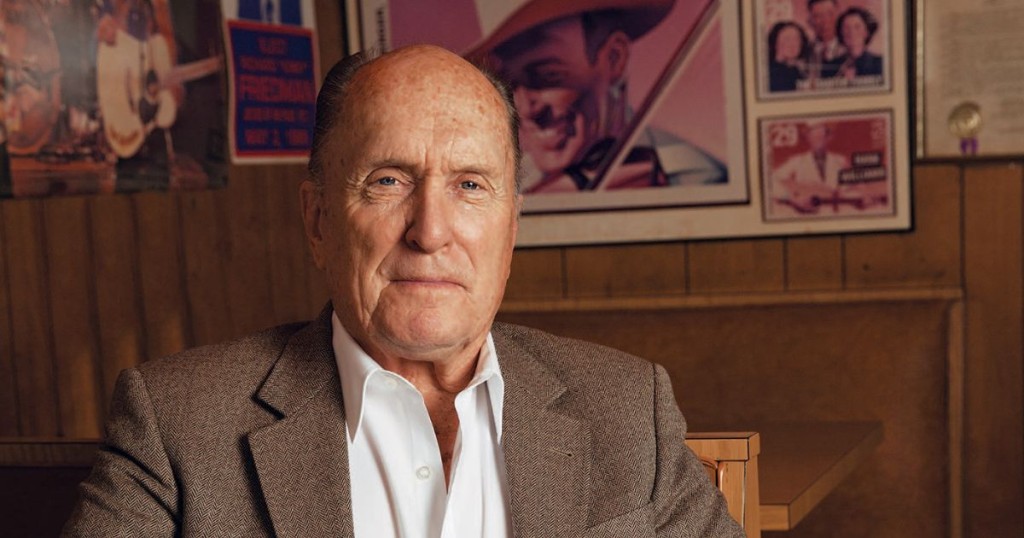L’Italia si classifica tra i big europei per la detenzione di brevetti. Uno dei problemi è la carenza di Technology Transfer Offices funzionanti e capillari
«Abbiamo inventato un airbag intelligente per motociclisti… e lo hanno brevettato in Francia». Inizia così la storia di Cefriel, centro di innovazione, ricerca e formazione milanese, che nel 2010 ha sviluppato un sistema rivoluzionario: un airbag wireless integrato in giacca e moto, il D-air street. Tra i più importanti progetti di innovazione per organizzazioni pubbliche, private, nazionali e internazionali, D-air street, nonostante la tecnologia fosse made in Italy, ha un brevetto che è stato depositato presso l’European Patent Office (EPO), ben lontano dall’ufficio italiano, per garantire protezione internazionale.
Stessa sorte per il macchinario Idra presse, una delle presse più grandi al mondo per le auto elettriche, nata a Brescia che promette di trasformare il processo di produzione delle e-car tagliando scarti e costi, anch’essa con il miglior brevetto europeo. Due testimonianze che illustrano un paradosso: la creatività italiana arranca quando si tratta di tutela.
L’Italia si classifica tra i big europei per la detenzione di brevetti, ma con qualche limite. Guardando ai dati nel 2023 il Bel Paese è risultato quinto in Europa per il numero di domande presentate all’EPO: 5.053, con un +3,8% rispetto al 2022, su un totale europeo di 199.275. Un trend in crescita: +38% in dieci anni, +15% in cinque. Eppure, su base pro capite – 85 domande per milione – restiamo lontani da Paesi come Svizzera (1.085), Svezia e Germania. Il 2024 ha segnato un’inversione: 4.853 domande, –4,5%, ma l’Italia resta quinta nell’UE e undicesima nel mondo. La flessione riguarda soprattutto il Nord Italia: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto trainano, con la Lombardia leader in Italia; ma segnali di rallentamento si registrano anche lì.
Nonostante i dati che creano dissapore, la composizione tecnologica delle domande italiane riflette le eccellenze del sistema produttivo nazionale nei diversi settori industriali. Nell’handling (sistemi di imballaggi e trasporto merci) circa 433 brevetti, l’8,3% sono presentati all’EPO; nei trasporti, 449 domande che classificano l’Italia al quarto posto in Europa; le tecnologie mediche per circa 343 domande e le macchine elettriche/sistemi di energia pulita in forte crescita, circa il +12% presentati in Europa e il +28% in Italia. Le grandi imprese restano protagoniste e tra di loro Coesia, Ferrari, Iveco, Leonardo e Pirelli prime nelle domande EPO.
L’Italia resta la “culla dell’idea”, ma il valore economico si trasferisce dove la protezione è più strategica. E le motivazioni per cui si sceglie di brevettare al di fuori del territorio italiano sono molteplici soprattutto attraverso l’EPO. Registrare un brevetto tramite l’EPO ha un costo medio compreso tra i 5.000 e i 7.000 euro, ma consente protezione contemporanea in più Paesi europei, con un’unica procedura. Al contrario, il sistema nazionale, gestito dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), è meno costoso nella fase iniziale (250–600 euro per la domanda), ma meno efficace nel lungo termine: richiede iter separati per estensioni internazionali, con oneri cumulativi e tempistiche non sempre rapide.
Inoltre, i tempi di rilascio di un brevetto italiano possono superare i 24 mesi, mentre alcune giurisdizioni internazionali o il percorso EPO garantiscono maggiore rapidità e certezza dei tempi. Uno dei problemi chiave è la carenza di Technology Transfer Offices (TTO) funzionanti e capillari: molte università italiane non dispongono di strutture specializzate in tutela brevettuale, o le hanno ma con organici ridotti e competenze limitate. Le piccole e medie imprese, che costituiscono oltre il 90% del tessuto produttivo italiano, spesso non hanno accesso a consulenti esperti in proprietà intellettuale. E i fondi pubblici dedicati alla brevettazione (come Brevetti+ o Voucher 3I) sono preziosi, ma frammentati, a sportello, e non strutturali.
In un contesto di competizione globale, brevettare in Italia non basta più. Un’invenzione tecnologica deve essere protetta nei mercati principali: Stati Uniti, Cina, Germania, Francia, Giappone. Per farlo, le imprese italiane scelgono vie più internazionalizzate e performanti come l’EPO (con copertura estesa) o il PCT (Patent Cooperation Treaty), che avvia una procedura unica per 157 Paesi. Chi sviluppa innovazione vuole – e deve – pensare in grande fin da subito: essere primi in classifica sul mercato conta più che sul territorio.
La valorizzazione dell’innovazione non si esaurisce con la creatività e lo sviluppo tecnologico. Di fondamentale importanza è la costruzione di un’infrastruttura nazionale solida di protezione e trasferimento della conoscenza, in grado di accompagnare ricercatori, startup e piccole, medie imprese in tutte le fasi della tutela della proprietà intellettuale. L’attivazione di sportelli dedicati alla proprietà intellettuale all’interno di università, enti pubblici di ricerca e distretti tecnologici permetterebbe un primo contatto qualificato per chi sviluppa un’idea innovativa. Questi sportelli, dotati di personale specializzato (ingegneri, giuristi, consulenti brevetti), offrirebbero orientamento gratuito, valutazione del potenziale brevettuale e supporto nella redazione delle domande.
Accanto a questo, è cruciale potenziare i voucher per le piccole e medie imprese (come il “Voucher 3i” del MIMIT), rendendoli strutturali e non solo legati a bandi a sportello. Il vantaggio? Evitare che le piccole imprese rinuncino a brevettare per mancanza di risorse, lasciando che l’innovazione resti priva di protezione.
Intervenire sui TTO, in Italia sono spesso sottodimensionati, scollegati dai dipartimenti, o limitati a compiti burocratici. Serve un modello di TTO potenziato, con presenza fisica costante all’interno degli atenei, figure multidisciplinari formate anche in economia e diritto, e un forte coordinamento con il mondo industriale. Nei Paesi Bassi o in Germania, i TTO sono veri e propri “ponti” tra laboratorio e mercato: in Italia, possono diventarlo se dotati di autonomia operativa e budget per scouting, networking e valorizzazione.
Troppo spesso studenti e giovani ricercatori scoprono solo tardi – o mai – cosa sia un brevetto, come funziona e quanto possa incidere sul destino di un’invenzione. Introdurre nei corsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) moduli obbligatori di proprietà intellettuale, con elementi di economia dell’innovazione, tutela giuridica e strategie di licensing, è una necessità. La consapevolezza della dimensione “industriale” del sapere è fondamentale per evitare che idee brillanti restino carta bianca nei cassetti della ricerca.
Inoltre, l’attuale frammentazione tra l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l’EPO crea un sistema ridondante, disomogeneo e poco accessibile. Occorrerebbe puntare sulla integrazione delle banche dati e l’interoperabilità dei sistemi; snellire le fasi burocratiche e documentali mediante modelli unificati e procedure online standardizzate; proporre delle agevolazioni sui costi, soprattutto per le startup, gli spin-off universitari e i giovani innovatori. Per questi ultimi punti, il PNRR ha previsto specifiche misure per favorire la brevettazione e rafforzare la capacità dell’Italia nel trasferimento tecnologico. Tuttavia, il vero nodo è l’attuazione: le risorse esistono, ma spesso non arrivano tempestivamente, o non sono accompagnate da un cambiamento organizzativo nei soggetti attuatori.