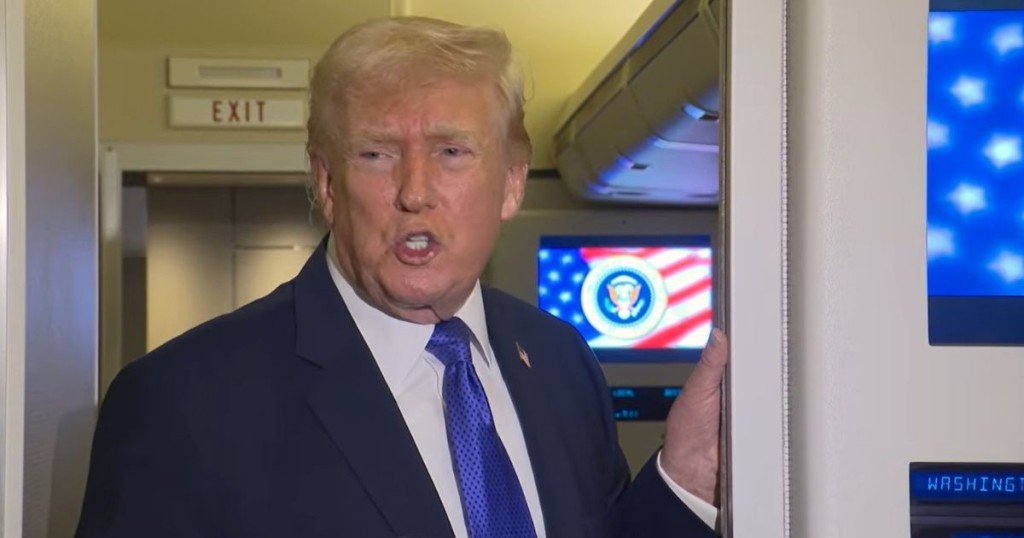Mentre il Mezzogiorno, soprattutto grazie alla spinta del Pnrr, continua a marciare a un ritmo più veloce del Centro Nord, segnando il sorpasso per il terzo anno consecutivo, l’Italia rallenta il passo e riemerge il gap di crescita con l’Eurozona. L’analisi sul Pil delle regioni nel 2024 della Svimez mette a fuoco la dinamica economica delle macroaree del Paese, che in un contesto dominato dall’incertezza – tra il conflitti russo-ucraino, i fronti di guerra in Medio Oriente e l’aggressiva politica commerciale di Donald Trump – viaggia con il freno tirato: lo scorso anno il Pil italiano è cresciuto dello 0,7%, in linea con il 2023, ma al di sotto della media della Ue a 27 (+1%) per la prima volta dal 2021.
Il Sud cresce più del Nord: +0,1 contro +0,6%, anche se il “vantaggio” del Meridione si riduce rispetto al 2023 (da 1 a 0,4). La crescita realizzata nel triennio 2022-2024 segna complessivamente +8,6%, 3 punti percentuali in più rispetto al Centro-Nord che si ferma a +5,6%.
La spinta del Pnrr
Merito degli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr, e in particolare della spinta data dal settore delle costruzioni (+3% contro il +0,6% del Nord). Secondo i dati Svimez, il contributo del Pnrr alla crescita del Mezzogiorno nel 2024 vale 6,6 punti percentuali, 0,4 punti per il Centro Nord.
I servizi (+0,7% contro +0,5% nel Centro Nord), rileva Svimez, sono il secondo pilastro della crescita del Pil meridionale, tiene l’industria (+0,1%) a fronte della contrazione registrata nel resto del Paese (-0,2%), mentre l’agricoltura meridionale arranca nel confronto con quella made in Nord: +0,5% contro +2,9%.
Sicilia e Campania le regioni trainanti
A far da traino alla crescita del Sud sono state soprattutto la Sicilia e (+1,5%) e la Campania (+1,3%) – +11,2% e +9,5% rispettivamente la crescita cumulata nel triennio di indagine – segno meno per Molise (-0,9%) e Calabria (-0,2%).
I Comuni sono stati i grandi protagonisti della nuova stagione degli investimenti pubblici: su 45 miliardi di investimenti pubblici poco meno della metà è stata mobilitata dalle amministrazioni comunali. Spicca la performance dei comuni meridionali, dove tra il 2022 e il 2024 gli investimenti sono aumentati del 75,3%, passando da 4,2 a 7,4 miliardi, mentre nel complesso i municipi italiani hanno messo in cantiere opere per 21,7 miliardi.
La crisi dell’industria si riflette nella contrazione dell’export, in calo dell’1,1% sul 2023. Tra le maggiori regioni del Nord solo la Lombardia segna un aumento seppur modesto (+0,6%), a picco invece le vendite all’estero del Piemonte (-4,9), del Veneto (-1,8%) e dell’Emilia Romagna (-2%): pesa soprattutto il calo dell’export dell’automotive. C’è la farmaceutica del Lazio, con i suoi 26 miliardi di export (+4%), e il boom (+50%) del comparto orafo toscano dietro la buona performance del Centro sui mercati esteri. Nel Mezzogiorno la riduzione delle esportazioni è più pronunciata che altrove – ed è dovuta in gran parte al crollo del settore auto – l’impatto sul Pil è contenuto dal momento che è il contributo della domanda estera è meno rilevante. Da rilevare è l’incremento del 10% dell’export agroalimentare, che è pari a oltre 11,5 miliardi.
Cresce il mercato del lavoro
Il mercato del lavoro italiano si conferma vitale anche nel 2024, e soprattutto nel Mezzogiorno la crescita resta sostenuta – benché concentrata su settori a basso valore aggiunto – beneficiando in particolare dell’effetto Pnrr sulle costruzioni dove la crescita degli addetti ha doppiato la media nazionale (+9,9% contro +5%): il numero di occupati è aumentato nel Sud del 2,2% su base annua – oltre 142 mila unità in più – contribuendo per il 40% all’incremento nazionale (+1,5%).
Sul fronte delle retribuzioni reali l’Italia spicca per un doppio gap, rispetto agli altri Paesi Ue e del Mezzogiorno rispetto al Nord: nonostante il rinnovo dei contratti e il rientro dello shock inflazionistico la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni italiane rispetto al 2019 è pari a -4,3 punti percentuali, si arriva a -6 nel Mezzogiorno, dove resta ampia anche la platea dei lavoratori poveri che sono oltre 1,8 milioni (31,2%), 4,6 milioni il dato italiano (21%).