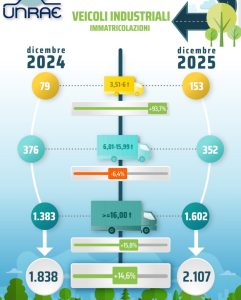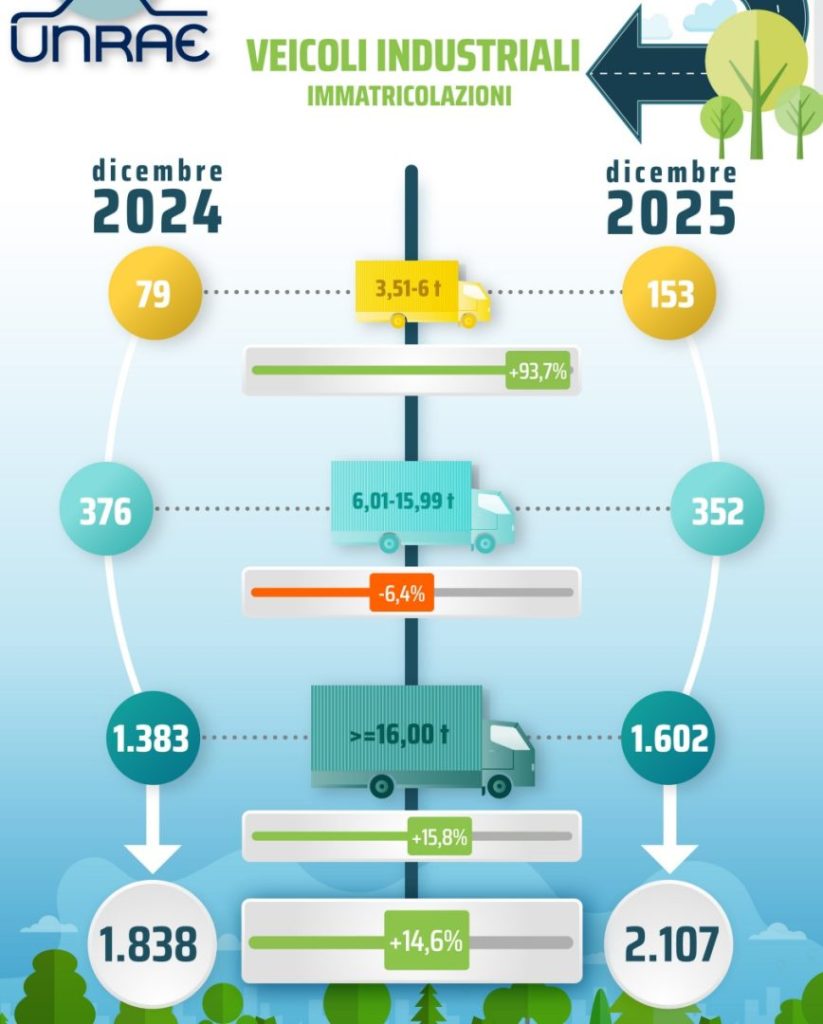Le sigle chiedono allo Stato di salvare la fabbrica. Ma se non si è riusciti ad amministrare la crescita, chi saprà gestire il declino?
“Nazionalizzate!”: è il coro di tutti per risolvere “definitivamente” la vertenza Ilva. Peccato che sia quasi il contrario di come stanno le cose: la storia dell’acciaio a Taranto è stata soprattutto una storia pubblica, cioè la storia di uno Stato che, in un certo momento, ha deciso di dotarsi di una grande base siderurgica nel Mezzogiorno per ragioni industriali, occupazionali e geopolitiche. Quindi: niente pregiudizi. L’intervento pubblico in Italia c’è sempre stato, è previsto dalla Costituzione ed è dentro la nostra storia industriale.
La fuga del capitale industriale
Ma c’è un pezzo che dal 2012 in poi si è fatto finta di non vedere. Dal sequestro dell’area a caldo in avanti, in particolare dal Governo Renzi fino all’attuale governo Meloni – nessuno escluso e tra gli applausi di gran parte della politica locale e nazionale – hanno di fatto organizzato la fuga del capitale industriale che voleva investire e risanare.
Nello stesso tempo, hanno giocato a fare gli apprendisti stregoni con formule di intervento pubblico e nazionalizzazioni estemporanee, più da repubbliche delle banane che da grande Paese manifatturiero. Prima si è reso impossibile lavorare in condizioni certe, poi ci si è scandalizzati perché i partner cercavano di uscire.
Sos allo Stato
E oggi arriviamo al paradosso finale: un coro a chiedere la nazionalizzazione di un’azienda che è già pubblica. Come se bastasse cambiare etichetta o ministero vigilante per far ripartire gli altiforni. Ogni volta che si invoca “la nazionalizzazione temporanea” senza dire come, chi gestisce, con quali soldi e per fare che cosa, quel conto lo pagano i contribuenti con le loro tasse e – più di tutti – le migliaia di lavoratori a cui oggi si propone la soluzione più facile: 6-7 anni di cassa integrazione.
Il declino
Questa non è politica industriale, è cattiva amministrazione del declino. Andrebbe urlato: non siete riusciti a guidare la crescita, figuriamoci il declino. I numeri dovrebbero bastare a farci arrossire: nel 2018 ArcelorMittal vinse la gara con 1,8 miliardi più gli investimenti; più di recente la cordata Baku Steel Company con il fondo statale Azerbaijan Investment Company si presentò con 1 miliardo; dopo l’incredibile incendio dell’Afo1 nel maggio 2025 sono scesi a 500 milioni. Cioè: meno asset, meno valore. E noi, invece di dare certezza e rilanciare, diamo l’idea che il ciclo integrale sia una variante della panificazione: lo metti lì, lo copri di cassa e prima o poi riesce con il lievito del rinvio e della demagogia.
La resa alla demagogia
Il risultato è che Ilva diventa un cartello all’ingresso del Paese: “Qui non si investe”. Perché se un’azienda già pubblica, su cui lo Stato è presente da decenni, finisce di nuovo dentro una richiesta di nazionalizzazione, il messaggio a chi dovrebbe mettere capitali, tecnologie e forni nuovi è uno solo: non c’è certezza del diritto, non c’è perimetro, domani cambia tutto di nuovo. È una resa incondizionata alla demagogia: meglio una bandiera da sventolare che un piano industriale da finanziare. La cassa – diciamolo – sta bene a troppi: a un governo che racconta il miracolo del Sud e a un’opposizione che, quando va bene, il Sud lo usa come logo per il “buon retiro”. Nel frattempo, gli investitori poco seri sanno che l’Italia è un buon investimento: fingete di investire e vi pagheranno, in temerarie cause legali per andar via.
Il precedente di Bagnoli
Non è la prima volta: Bagnoli chiuse nel 1992, bonificata solo per un terzo, da allora il suo futuro è consegnato alla camorra e alla cassa integrazione. L’acciaio in mano pubblica è da anni un grande affare solo per chi lotta per svenderlo in Italia e riaprirlo altrove senza bonifiche.
I costi a carico dei cittadini
Siamo in un continente che stenta a capire che il suo “primario” non può essere messo in mani qualunque – acciaio, chip, data center, gpu, energia, competenze – ed è il cuore della nostra sovranità industriale. Anche per questo non esiste intervento pubblico “vuoto”: o hai capacità di gestione, obiettivi misurabili (produzione, decarbonizzazione, sicurezza), una governance professionale e partner industriali veri, oppure stai solo spostando il conto più avanti. L’azionista conta, ma contano di più la capacità industriale, l’occupazione, i bilanci e la sostenibilità complessiva. Se mancano questi pilastri, ogni “ritorno dello Stato” è l’ennesimo giro di giostra. E il biglietto, puntualmente, lo pagano cittadini e lavoratori.