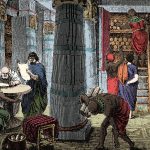“In fondo al mare le balene cantano. Lo fanno anche le navi? Sembrano immobili sul fondo, immobili e mute, ma non è vero, perché ormai lo sappiamo che non c’è mai niente di fermo, nel mare, neanche un relitto di ferro arrugginito, incrostato di alghe e di sale, appoggiato a un fondo di sabbia e di roccia da anni e anni e anni” (Carlo Lucarelli in “Navi a perdere”). È apparso così agli occhi del noto apneista Enzo Maiorca nel giugno del 1993, il sommergibile “Sebastiano Veniero” durante un’immersione alla ricerca proprio del suo relitto. Varato il 7 luglio 1918 e inabissatosi dopo una collisione con un mercantile il 26 agosto 1925 nelle acque di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. Custodisce ancora il suo equipaggio, mai recuperato. Cercato, anche probabilmente individuato negli anni, ma mai perlustrato da vicino.
Si spiegano così le notizie contrastanti sulla profondità del fondale su cui giace (90 m. poi 60 m. e infine 48 m.). Ma cosa accadde in quella esercitazione della marina militare nell’estate di cento anni fa? La perdita del sommergibile di crociera “Veniero” fu tra gli eventi di cronaca che più colpirono in quel periodo, occupando per alcuni giorni la prima pagina dei quotidiani italiani e stranieri. Partita il 24 agosto 1925 dalla Maddalena con un equipaggio di 48 uomini, tra cui nove allievi siluristi e motoristi, al cui comando era il capitano di fregata Paolo Vandone, l’imbarcazione della Regia Marina si trovava al largo, per una esercitazione in cui si sarebbe dovuta disporre in agguato tra Capo Passero e Capo Murro di Porco.
Alle ore 6.50 del mattino, invece, il “Veniero” fu speronato, in fase d’immersione, dalla motocisterna “Capena”. La nave che non si accorse della presenza del sommergibile, seguì la sua rotta passandogli praticamente sopra. Il contraccolpo avvertito fece pensare a un possibile impatto con un fondale roccioso, quindi la motonave proseguì la navigazione. Il sommergibile invece s’inabissò con tutto il suo equipaggio, senza dare alcuna segnalazione né di pericolo né di avaria. Quando la motocisterna arrivò a Londra si era diffusa anche lì la notizia della sparizione del “Veniero” e allora qualcuno dell’equipaggio della Capena ripensò all’alba del 26 agosto.
I dubbi si trasformarono subito in certezza quando, su disposizione del ministro delle Comunicazioni italiano Costanzo Ciano, lo scafo della motocisterna fu sottoposto a una perizia dalla quale risultò che la carena presentava alcune deformazioni, in corrispondenza delle quali c’erano striature di bronzo del tipo impiegato nella costruzione di alcune parti del “Sebastiano Veniero”. Nei giorni successivi navi e idrovolanti iniziarono le ricerche individuando macchie di combustibile alla deriva ma nessun corpo o relitto. L’inchiesta che ne seguì nei mesi successivi non condannò nessuno: la “Capena” navigava in “acque libere”, all’esterno di tratti di mare interdetti a causa di esercitazioni militari e nessun membro dell’equipaggio aveva avvistato alcunché in mare.
Sui giornali la notizia del Veniero disperso fu data il primo settembre 1925: “Le ricerche del sommergibile “Venerio” fatte a mezzo di aeroplani e cacciatorpediniere lungo la costa della Sicilia…spinte fino a 60 miglia da terra hanno dato finora esito negativo. Pur essendo scomparso il 26 agosto la notizia della sua sparizione divenne pubblica soltanto tre giorni dopo, quando il sommergibile era atteso alla parata di tutte le unità navali di fronte al re.
Alle 22 del 28 agosto non aveva risposto all’ordine di rientro, ma si era pensato a un’avaria della radio. Ma Il Veniero mancava proprio all’appello e il timore che fosse successo qualcosa d’irreparabile divenne una certezza. Furono inviati allora dispacci a tutte le stazioni radiotelegrafiche con l’invito a esplorare lungo il mare tra Santa Croce e Murra di Porco. Particolarmente colpito dalla possibile sciagura, il re chiese di essere informato in tempo reale.
Il 30 mattina fu intercettato un radiotelegramma “Ho un’elica rotta”. Il Veliero in avaria? Purtroppo no: dalla radio di un piroscafo era partita quella richiesta di aiuto. Poi il 2 settembre “Il Mattino” dedicò la prima pagina al ricordo dei quattro napoletani imbarcati sul sommergibile: il maresciallo Pasquale De Rosa, l’allievo cannoniere Vincenzo Caiazzo, i marinai Armando d’Eustacchio (21 anni) e Michele Di Meglio.
Il 3 settembre, dopo sei giorni di ricerca senza risultato, un comunicato del Ministero della Marina diede la notizia che la nave doveva essere ritenuta persa “per cause imprecisabili”. Intanto, ma la notizia non fu resa subito pubblica, si ispezionava la “Capena”. Il 4 settembre il ministro della Guerra ammise: “Le speranze vanno spegnendosi”. Una grande perdita, eroi persi negli abissi … e un grande dolore per decine e decine di famiglie italiane.
Cominciarono ad arrivare i messaggi di cordoglio, anche dalla Francia. Solo qualche tempo dopo si diffuse la notizia, pubblicata dai quotidiani romani, della scoperta di una macchia di grasso sulla superficie del mare tra Siracusa e Capo Passano che, benché spazzata via, ricompariva “assieme a delle bolle d’aria”. Non riaffiorarono rottami, né corpi. Nessuno s’immerse per una verifica. Era davvero lì il “Veniero”? Per anni – si disse – non si riuscì a individuare il punto esatto del fondale su cui il relitto si era adagiato. Nel cimitero del Verano nel 1927 fu eretto un monumento per ricordare il sacrificio di questi ufficiali di Marina. Ma poi la cronaca di quegli anni e poi la guerra sommersero anche il bisogno di dare una tomba a 48 uomini, perché le loro famiglie potessero portare un fiore e onorarli.
La Sicilia non aveva dimenticato: nella memoria e nel cuore dei siracusani, soprattutto, quel tratto di mare era diventato una triste incognita. A volte, le reti dei pescatori si impigliavano e si strappavano, sempre nello stesso specchio d’acqua. Che cosa c’era sul fondale? A metà degli anni ’90, durante una trasferta a Cuba, il celebre apneista Enzo Maiorca siracusano, allora 61enne, conobbe un comandante siciliano, Armando Santoro. Riaffiorò, in una delle loro conversazioni, il ricordo di quella tragedia avvenuta decenni prima. Maiorca sanguigno, impulsivo, si sentì come investito di una missione particolare: prima di ritirarsi dall’attività agonistica avrebbe voluto ritrovare quel sommergibile scomparso. Così, di ritorno in Italia con un gruppo di amici cominciò le ricerche e le immersioni nella zona indicatagli da Santoro.
L’11 giugno 1993, a 20 metri l’avvistamento e a 48 metri di profondità la scoperta: “A venti metri di quota avvistammo sotto di noi una forma geometrica. Ci apparve sbandata sulla sinistra e inclinata di prua. – scrisse Maiorca in “L’ultima immersione”, libro dedicato al ritrovamento. Si avvicinò e ne descrisse lo scafo esterno deteriorato, quello interno integro, il boccaporto di prua e quello di poppa aperti, il controboccaporto chiuso. Dopo Maiorca toccò ai sub dell’arma della Marina fare un’ispezione del sommergibile. Fu proprio grazie a quella immersione che venne fuori una notizia che creò dolore e malcontento nelle famiglie delle vittime del “Veniero”: il luogo esatto dell’inabissamento era noto. Tutte le carte nautiche lo segnalavano. Ma una comunicazione ufficiale alle famiglie non fu mai data.
In seguito all’immersione di Maiorca, la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa dispose una ricognizione e un’inchiesta dell’arma di Messina e di Catania realizzando filmati e rilievi fotografici del mezzo affondato nel 1925. È ancora lì. Quest’anno, l’Associazione culturale Lamba Doria ha presentato la richiesta di “riconoscimento del Regio sommergibile Sebastiano Veniero” come Sacrario Militare. Un sacrario immerso. Riposa – scrisse Maiorca – in un fondale sabbioso, adagiato nella melma. Secondo me la tomba migliore per un uomo di mare è il mare. Chi ha detto che sulle tombe dei marinai non fioriscono rose? Il sottomarino è coperto di concrezioni bellissime, una specie di giardino di Poseidone”. E ritorna alla mente un altro passaggio del libro di Carlo Lucarelli, per ricordare quell’imbarcazione “Piegata da una parte, come si fosse appoggiata su un fianco, schiacciata da un’agonia infinita”.