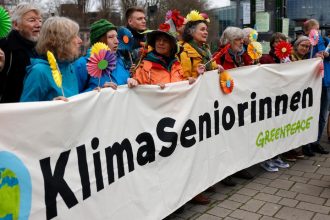Da Caivano una storia che parte dalla scelta criminale, per arrivare allo studio negli istituti penitenziari e a un’associazione che oggi aiuta minori in difficoltà
Quando il Parco Verde era solo il Parco Verde, non era un modello né un covo di pedofili, la vita e la morte erano scandite da un unico ritmo, quello del sistema. Un sistema che entrava nelle case e si portava via i ragazzini, o che restava fuori ad attenderli, pronto a risucchiarli in un vortice senza uscita. Bruno Mazza era ancora minorenne quando il padre si suicidò. Non aveva soldi né istruzione.
Aveva soltanto il Parco, e il Parco aveva lui e i suoi coetanei. Andava a scuola, ma era un ragazzino ingestibile, ferito e incompreso, e ogni mese i professori, secondo quella che era la didattica dell’epoca, lo lasciavano a casa per metà dei giorni: sospensioni che non erano punizioni, ma una sorta di premio, tanto per gli studenti quanto per i docenti.
«Ero a casa e combattevo la noia con qualche furto, qualche scippo. Con un gruppo di amici, travestiti da poliziotti, assaltavamo le macchine sulla superstrada: fingevamo un posto di blocco e poi le rapinavamo».
“Un’infanzia da vivere” per i più fragili
Inizia così la parabola criminale di Bruno Mazza, 45 anni, sopravvissuto del Parco Verde di Caivano, nella provincia della Napoli peggiore. Da baby boss a educatore: oggi, con la sua associazione “Un’infanzia da vivere”, sostiene i ragazzi a rischio e li aiuta a istruirsi, a capire che c’è una strada migliore di quella indicata dalla camorra. Una strada che Bruno conosce bene.
Da adolescente fa il rapinatore e viene “notato” dal capoclan, che lo inserisce nella sua paranza, lo arma e lo paga in cocaina.
Ma quando è cambiato tutto? «Quando sono stato arrestato e mi hanno portato in carcere. Nel carcere vero». «In precedenza – racconta – ero stato al minorile di Nisida. Lì nascevano le paranze: ci picchiavano con asciugamani bagnati per non lasciare segni. Un incubo. Ti rendevano cattivo e ti affiliavano». Bruno viene accusato di aver preso parte a un omicidio.
«Che non ho mai commesso – sostiene – ma che mi fu attribuito perché alcuni ex boss pentiti dissero che, durante un agguato a un clan rivale, io ero presente, nascosto dietro una siepe». Per quei fatti fu condannato a dieci anni di carcere, ma non ne parla con rancore. Anzi.
Prima della condanna, nel 1999, finì nuovamente nei guai. «Mi commissionarono un agguato, ma non trovammo la persona a cui sparare. Intanto la polizia era sulle nostre tracce: ci fermò mentre tornavamo al Parco. Quando mi arrestarono avevo un’arma carica, la foto dell’uomo che dovevo colpire in tasca e un giubbotto antiproiettile addosso. Non sapevo che, quel giorno, non solo avevo evitato il più grande errore della mia vita, ma che quelle manette mi stavano anche salvando la vita».

«Ho conosciuto la mia libertà in carcere. Perché è stato nelle case circondariali di Poggioreale e Secondigliano che ho capito che esisteva un mondo diverso da quello della malavita: un mondo lontano dalla rassegnazione dell’ora d’aria passata a progettare nuovi reati. Mi isolai nella lettura e, quando arrivò la professoressa Antonella, che insegnava ai detenuti a leggere e a scrivere, mi aggrappai a lei».
Leggere, scrivere, lavorare in carcere
Bruno conseguì la quinta elementare, poi la licenza media. Tutto in carcere. «Leggere, scrivere, lavorare su me stesso mi diedero una libertà che non avevo mai conosciuto. Lo psichiatra del carcere mi propose dei farmaci per aiutarmi a superare le ferite, ma rifiutai: volevo essere lucido, pienamente consapevole delle mie scelte. Dovevo lavorare su me stesso, soffrire anche, ma uscirne con le mie forze».
Durante la detenzione capì che potevano aprirsi altre porte, se solo lo avesse voluto. «Quando ero nel clan mi davano un milione di lire a settimana, ma ne spendevo altrettante per la coca. Andavo avanti pensando che non ci fossero altre strade. Poi ho capito che essere liberi significa conoscere, studiare, poter fare qualcosa per gli altri».
Uscito dal carcere, inizialmente lontano dal Parco Verde per ordine del giudice, andò a vivere nel centro storico: la casa dell’infanzia felice con la madre maestra, i tre fratelli e il padre. La casa che avevano dovuto lasciare dopo il terremoto per trasferirsi negli alloggi popolari di Caivano.
«Una volta fuori, continuai a studiare e mi iscrissi alle superiori: non volevo perdere il cammino iniziato in carcere, volevo continuare a crescere». Ma intanto un altro dramma colpì la famiglia Mazza: uno dei fratelli di Bruno morì per overdose. «Aveva due figli piccoli: capii in quel momento che indietro non si poteva più tornare». Appena la misura restrittiva decadde, Bruno tornò al Parco Verde.
«Chiamai il volontario che da bambino saliva ai piani dei palazzi per portarci nella sua associazione. Gli dissi: “Giovanni, ti ricordi di me?”. Si ricordava. E insieme riprendemmo quello che già negli anni ’90 era stato un tentativo di strappare i minori alla criminalità».
La nascita dell’associazione
Da questo percorso nasce l’impegno che oggi porta l’associazione a seguire quattrocento minori: dal 2008 dà speranza a chi nasce credendo che la speranza sia solo un’illusione.
«Quando tornai al Parco vidi i bambini fare ciò che facevo io alla loro età: lanciare sassi contro le auto, rubare frutta dai furgoncini degli ambulanti. Andai a prenderli uno per uno, fin dentro casa».
Oggi circa 80 bambini al giorno sono seguiti nell’accompagnamento allo studio; trascorrono il tempo libero in ludoteca, frequentano laboratori di cucina, lavorano negli orti sociali, seguono corsi di basket. L’associazione sostiene anche 94 famiglie con pacchi alimentari, per un totale di circa 500 persone. Se gli chiedono il peggiore e il migliore tra i momenti dei suoi primi 45 anni – delle sue due vite – Bruno non ha dubbi. «I ricordi più felici? Avere visto i miei nipoti realizzarsi e sposarsi. La nascita di mio figlio, venuto al mondo nel giorno dell’anniversario della morte di mio fratello. E poi tutti i ragazzi che posso seguire ogni giorno».
E il peggiore? «Coloro che volevano farcela, ma non ce l’hanno fatta: come un ragazzo che seguivo e che è morto di Aids». E poi ci sono i nuovi “camorristi”. «In passato era difficilissimo aiutare i minori provenienti da famiglie criminali. Oggi i camorristi ci scrivono dalle carceri chiedendoci di stare vicini ai loro figli, per evitare che facciano la loro stessa fine. È un cambiamento epocale. Nel nostro piccolo non smetteremo mai di fare la nostra parte».