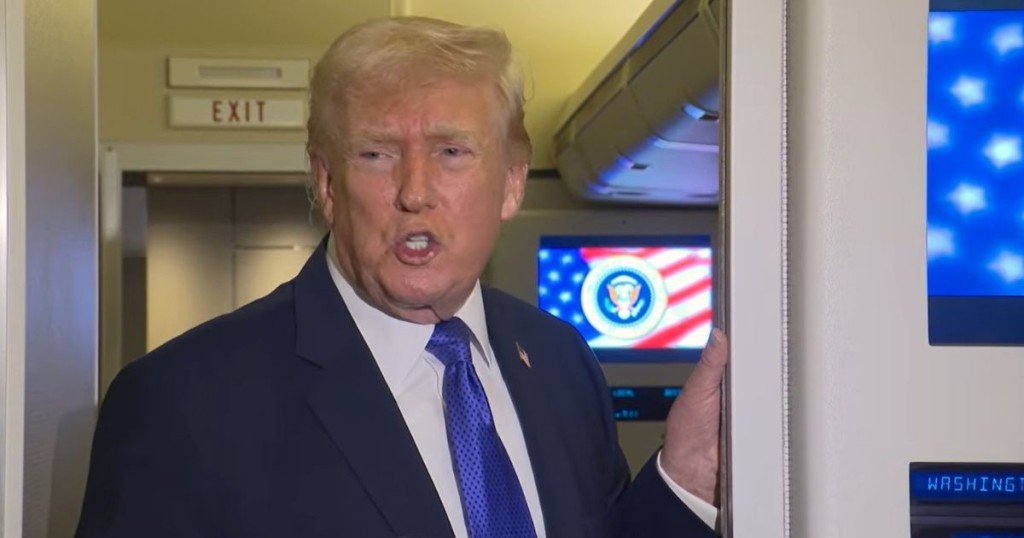Nanni Loy un cagliaritano, con l’anima napoletana e lo sguardo sornione dei romani veraci. Inconfondibile. E oggi, nel ricordarlo a cento anni dalla nascita, cerchiamo di approfondire il suo legame con il Sud, e quell’ impegno civile che fu un punto fermo della sua vita. Non è stato soltanto il genio della candid camera Nanni Loy, ma un professionista il cui stile e la competenza, l’interesse per la storia e le storie hanno lasciato il marchio dell’originalità. Mai banale. Mai irrispettoso: “Io vado alla ricerca del personaggio, non della risata”, diceva.
Giovanni Loy-Donà, questo il suo vero nome, era nato a Cagliari il 23 ottobre 1925. Suo padre Guglielmo era un noto avvocato che nel 1938 si trasferì con la famiglia a Roma. Ma anche Napoli comparve presto nella vita di Giovanni Loy: vi abitava la nonna. La città divenne la sua seconda casa. Gli metteva allegria la vivacità di quel luogo e della sua gente. Scoprì che “in ogni napoletano c’è una splendida umanità e li ami tutti… poi ti viene di odiarli quando vedi come, tutti insieme, hanno reso invivibile Napoli”. Lo disse in un’intervista e si guardò bene dall’identificare la città con i suoi stereotipi. Descriveva il napoletano doc come un signore che ogni giorno “non forma le fiumane di greggi in corsa verso l’ufficio, come a New York, Parigi, Milano. Arriva in ritardo. Se per strada incontra qualcosa che lo interessa, si ferma. Non è puntuale perché è libero. Così difende i suoi spazi, la sua fantasia”. Osservatore geniale e rispettoso. Completati gli studi classici, Loy si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, per assecondare la volontà paterna e si laureò nel 1947 con una tesi in Filosofia del diritto. Poi conseguì il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo un breve apprendistato con numerosi registi, a 32 anni cominciò la carriera nella regia: esordì con Gianni Puccini nel giallo “Parola di Ladro”. La collaborazione proseguì con “Il marito” (1958), film interpretato da Alberto Sordi (coautore del soggetto e della sceneggiatura) e girato in Spagna, benché ambientato a Roma, poiché il produttore era spagnolo. Realizzò nel 1959 l’ “Audace colpo dei soliti ignoti”.
Sembrava essere orientato verso la commedia all’italiana. Aprì, invece, una finestra sul periodo della Resistenza, stuzzicato dalla lettura di “Guerriglia nei Castelli romani”, scritto da un partigiano genovese. Ne nacque il film “Un giorno da leoni” (1961). Fu il preludio di quello che, ancora oggi, è considerato il suo capolavoro: “Le Quattro giornate di Napoli” del 1962. Nato da un’idea di Vasco Pratolini, un toscano che fu testimone di quegli eventi, con la sceneggiatura di Massimo Franciosa, Pasquale Festa Campanile, Carlo Bernari e dello stesso Loy, il film fu prodotto dalla Titanus. Loy seppe mescolare attori famosi con persone comuni, riuscendo a coinvolgere la popolazione napoletana e dirigendola come se fosse un gruppo di attori consumati. Ma erano di più: veri protagonisti di una rievocazione corale e fedele alla storia di quelle giornate. Un far rivivere al popolo il senso della riscossa, con la fierezza e la rabbia di chi si sentì preso in giro e umiliato. Fu la gente del popolo a ribellarsi eroicamente all’invasore tedesco. Fu la gente del popolo davanti alla cinepresa a rendere omaggio ai ribelli. Quasi tutte le scene furono girate a Napoli, anche se non tutte nel luogo in cui erano avvenuti i fatti. Durante le riprese capitò anche un piccolo incidente: c’era da rappresentare l’uccisione di un marinaio catturato dai tedeschi. L’attore “da fucilare” era Jean Sorel. Gli fu fatta indossare, sotto una maglietta, una sacca di liquido rosso, con tre piccole cariche di dinamite che, al rumore dei fucili, un addetto agli effetti speciali avrebbe dato il via allo scoppio e alla foratura della maglietta. Le tre cariche scoppiarono, però, al contrario bruciacchiando la pelle dell’attore. Il film vinse il Nastro d’argento 1962 per la regia e per la sceneggiatura, un premio a Mosca e fu candidato come film straniero agli Oscar. Eppure (o proprio per questo) sollevò molte critiche e fu pesantemente attaccato sia da una minoranza in Italia sia da gran parte dei giornali tedeschi. L’allora ministro degli Esteri di Bonn, Gerhard Schrbder, cercò di dimostrare storicamente la “correttezza” dell’occupazione nazista di Napoli. Ovviamente la difesa fu un flop. Il film ancor oggi è una testimonianza vibrante della Resistenza napoletana.
E Loy? Avrebbe potuto cavalcare il successo (e anche le polemiche), ma cambiò totalmente registro. Era un uomo capace di guardare il mondo con amarezza, ma anche con grande ironia. Intelligente, sensibile nel ritrarre i personaggi della cronaca e della storia, descrisse con la stessa scrupolosità la routine, i labirinti giudiziari e burocratici, la protesta civile, costantemente presente, e la reazione delle persone di fronte agli imprevisti. Di lui Alberto Sordi (che con Loy aveva interpretato anche un ruolo drammatico in “Detenuto in attesa di giudizio”) disse: “La sua caratteristica era la chiarezza. Con Nanni non si perdeva mai tempo, perché aveva sempre tutto chiaro in mente”. Si appassionò a un programma televisivo visto in America e ne fece la sua versione made in Loy: nacque nel 1964 “Specchio segreto” la prima candid camera della tv italiana, il programma che rivoluzionò il modo di fare televisione e che lo rese famoso. Chi non lo ricorda lasciare senza parole un signore che voleva sorseggiare un cappuccino, per aver intinto una brioche nella sua tazza? Loy scoprì con i suoi assalti a sorpresa un mondo a sé. Fu un trionfo. Cavalcarlo? Macché! Tornò alla cinepresa. Diresse “Made in Italy”, “II padre di famiglia”, “Rosolino Paternò, soldato” e “Café Express”, tutti film con Nino Manfredi. Seguirono “Testa o croce” e, nel 1984, “Mi manda Picone”, con Giancarlo Giannini e Lina Sastri. Fu un successo di botteghino. La sua ultima regia fu “A che punto è la notte” del 1994. Nanni Loy lavorò anche in radio. Nel 1977 (anno in cui in tv propone una candid camera nei treni dei pendolari “Viaggio in seconda classe”) presentò con Annabella Cerliani “Perfida Rai” su Radio1, con testi di Maurizio Costanzo. Nella rubrica “Parla come mangi” sottolineò, per esempio, gli stereotipi nel gergo giornalistico (“il tonfo che è sempre sordo, il delitto efferato, una scena agghiacciante…). Ma in fondo, Loy in giro non ha mai preso nessuno: mise in risalto gesti, abitudini, luoghi comuni perché si riflettesse su di essi. Era quello che faceva lui, per primo. E fu una persona di grande impegno civile e politico. Lo dimostrò non solo con il suo lavoro: manifestò contro la guerra nel Vietnam, si batté per la liberazione di Alekos Panagulis, l’ufficiale ribelle alla dittatura militare in Grecia e organizzatore dell’attentato a Papadopoulos. Loy fu anche tra i 757 firmatari della lettera contro Luigi Calabresi in cui il povero commissario della questura di Milano, poi assassinato, sembrava responsabile della morte di Pinelli. La lettera fu pubblicata dall’Espresso il 13 giugno 1971. Due anni prima, il regista aveva polemizzato con Franco Zeffirelli, che reclamava la censura per film a suo avviso “immorali”. “Nessuna censura – disse Nanni Loy – Tutti hanno diritto di lavorare e di poter esprimersi liberamente, come fa lui”. Morì per un attacco cardiaco il 21 agosto 1995. Era in villeggiatura a Fregene nella sua casa accanto alla villa dell’amico Gillo Pontecorvo. Non stava bene, ma aveva due progetti da realizzare: un film con Sidney Poitier dal titolo “Il mio amico selvaggio”, una storia vera che avrebbe raccontato l’amicizia tra il figlio di un podestà fascista e un principe etiope, e il suo primo film di ambientazione sarda, tratto dal giallo “Procedura” di Salvatore Mannuzzu. Chi lo incontrò il 21 agosto lo descrisse stanco, ma ancora con la voglia di scherzare: “Ma tu, ricordi la zuppetta?”, chiese Nanni Loy all’ultima persona che incrociò, mentre tornava a casa. Lui, che non aveva mai cercato la risata quel giorno, volle andarsene con un sorriso.