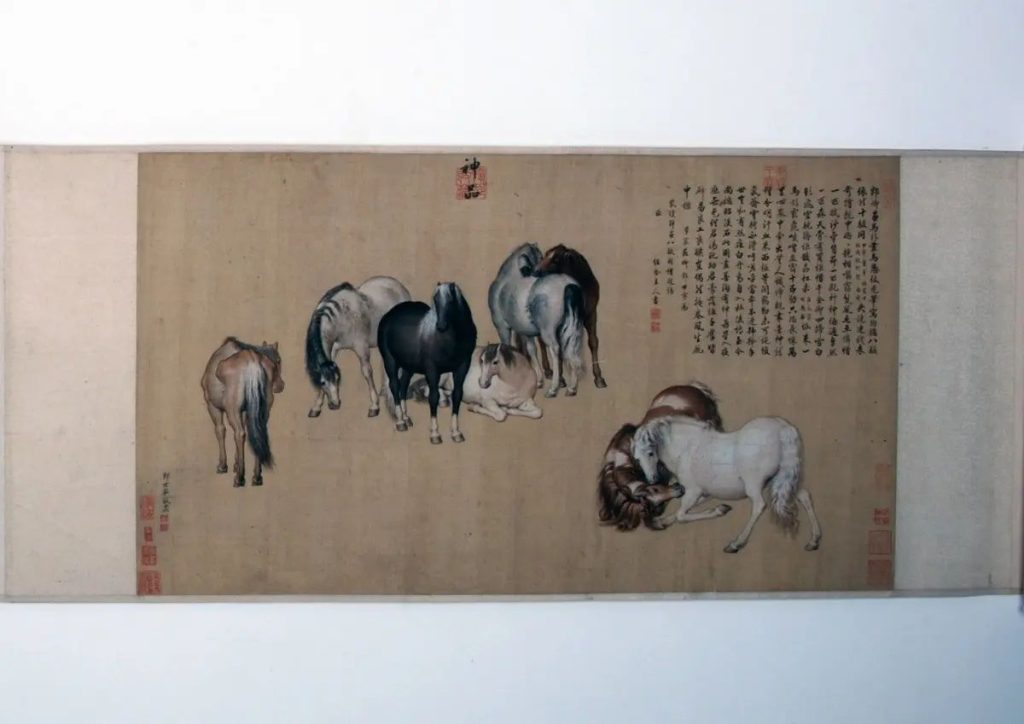Notoriamente, nessuno è più cinico dei romani: dall’alto di ventotto secoli di storia ne hanno viste di ogni. E, come dicono, da loro gli uomini si travestivano da donne quando gli altri costruivano palafitte. Rispetto al resto del mondo, l’Europa è un po’ come Roma rispetto all’Italia, soprattutto se il confronto è con gli Stati Uniti. Bravi a fare il cinematografo ma non la guerra, pensava il fascista medio. Gli americani, per noi, restano eterni ragazzi cresciuti a cornflakes e Coca-Cola, con la patente presa a sedici anni senza mai aver letto un classico latino. L’entusiasmo per la bandiera, per i discorsi del presidente e per la torta di mele è l’altra faccia della loro incapacità di capire Machiavelli, Voltaire e Hegel.
L’europeo li guarda e, collocatosi sul montarozzo del proprio cinismo, scuote la testa. È quello che molti hanno fatto davanti al rito in memoria di Charlie Kirk: troppe preghiere e canti, troppe testimonianze di perdono e retorica cristiana. Eppure Giuliano Ferrara ci ha visto qualcosa di essenziale: un revivalismo protestante che mette in scena la fede, la famiglia e la libertà. In America la religione è parte dello spazio pubblico e della vita civile, a differenza dell’Europa, dove il laicismo “alla francese” esclude i simboli e i riti della fede dalla sfera collettiva. Notevolissimo è il contrasto tra quello che abbiamo visto in tv e ciò che Ferrara chiama il “proceduralismo” delle nostre democrazie.
LEGGI: In duecentomila per Kirk, la vedova perdona il killer
La vita pubblica degli europei si regge prevalentemente sulle convenzioni della dialettica parlamentare, le garanzie costituzionali, le norme di convivenza svuotate di qualsiasi contenuto sostantivo, religioso o morale che sia. Questa democrazia funziona come un ingranaggio che deve garantire diritti individuali senza mai invocare un fondamento trascendente o comunitario. È la “neutralità” dello Stato che diventa ideologia: non esiste alcuno scopo ultimo dichiarato, solo il metodo, la regola, la burocrazia.
Al contrario: il ricorso a Dio, le cerimonie di massa che celebrano perdono e sacrificio, significano che la libertà non è solo emancipazione individuale ma anche vincolo fondato su una tradizione spirituale. Non importa che a presiedere queste cerimonie ci sia un poco di buono come Trump: scandalizzarsene è un po’ come cadere nell’antica eresia del donatismo, per cui un sacerdote indegno non può amministrare validamente i sacramenti. Ma la forza di un rito non dipende dalla bontà di chi lo guida, bensì dalla fede della comunità che vi partecipa. È qui la cifra di una democrazia che non si limita alle procedure.
La domanda di Ferrara è radicale e non va dribblata: può resistere e fortificarsi una democrazia che s’ingegna a considerarsi neutra, esclude la memoria dei morti e il senso del sacro come comportamenti collettivi, coltivando esclusivamente una teoria dei diritti? L’europeo – romano o parigino, berlinese o milanese – è certo che l’unica politica è quella delle regole: ciò che non è formalizzato è sospetto, ciò che ha sapore religioso o comunitario viene subito liquidato come fanatismo. La nostra storia millenaria, una sequenza strabiliante di trionfi e sconfitte, slanci incendiari e cocenti delusioni, ci ha parecchio raffreddato e persuaso che tutta la ragione sta dalla parte di qualche verità ridotta all’osso.
Purtroppo, la verità è sempre disincantata e sconsolante, e proprio per questo ostile alla vita. Una democrazia che voglia nutrirsi soltanto di verità nuda e cruda – senza illusioni, senza simboli, senza comunità – finisce per arrancare. Le illusioni comunitarie non sono un lusso, ma un bisogno dell’esistenza. Nemmeno sono bugie, ma miti civili, riti che danno sostanza al legame tra individui. In America lo capiscono. Magari in modo ingenuo, a tratti teatrale, ma lo capiscono. Quelle cerimonie, quei canti, perfino l’intimo travaglio di un perdono ammannito davanti alla folla, non sono folklore: sono il tentativo di dare alla politica una fisionomia e un volto nei quali potersi riconoscere.
Il cinismo europeo
In Europa, invece, la scelta obbligata del cinismo sta scavando una fossa: la nostra. Siamo i soli adulti nella stanza, sicuri di avere smascherato ogni illusione. Ecco perché siamo diventati incapaci di costruire alcunché di duraturo. Anche una democrazia liberale, per quanto disincantata, ha bisogno di riti, simboli, parole capaci di scaldare e non solo di misurare. È paradossale che proprio noi, che ci vantiamo di avere inventato la filosofia e la politica, sembriamo incapaci di riconoscere che la vita non si regge solo sul disincanto della verità, ma anche su quelle illusioni comunitarie che la rendono sopportabile. Dire “famiglie vi odio!” probabilmente coglie nel segno ma può avere conseguenze catastrofiche e, demograficamente parlando, le ha già avute.
Un aneddoto su Nietzsche, non dei più noti, ci racconta lo sconforto che provò quando, nell’inverno del 1883, a Nizza, chiese a un geologo ebreo quali fossero le speranze del suo popolo. La totale indifferenza del geologo verso un ideale collettivo rattristò parecchio Nietzsche, convinto che gli ebrei dovessero aspirare a qualcosa di grandioso. Al che il geologo gli rispose: “io sono uno spirito libero, non è proprio quello che lei celebra nei suoi libri?”. Nietzsche rispose che sì, effettivamente lui amava la libertà e il disincanto dello spirito, ma aggiunse che nessun popolo può sopravvivere abbeverandosi solo a queste fonti. A noi europei resta il compito di reimpararlo, prima che la nostra sconfinata saggezza ci condanni a vivere in un edificio di regole ineccepibili ma senza un’energia capace di animarle.