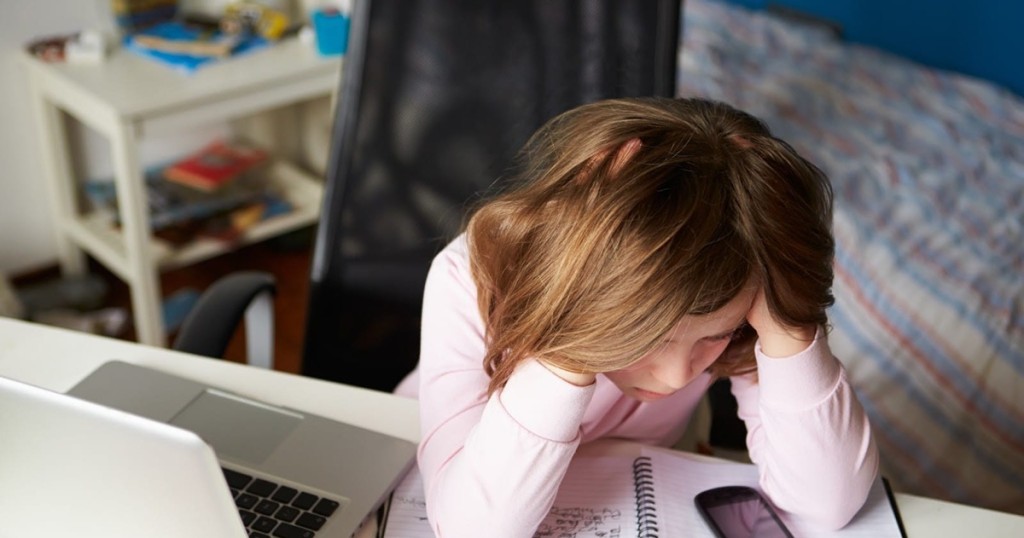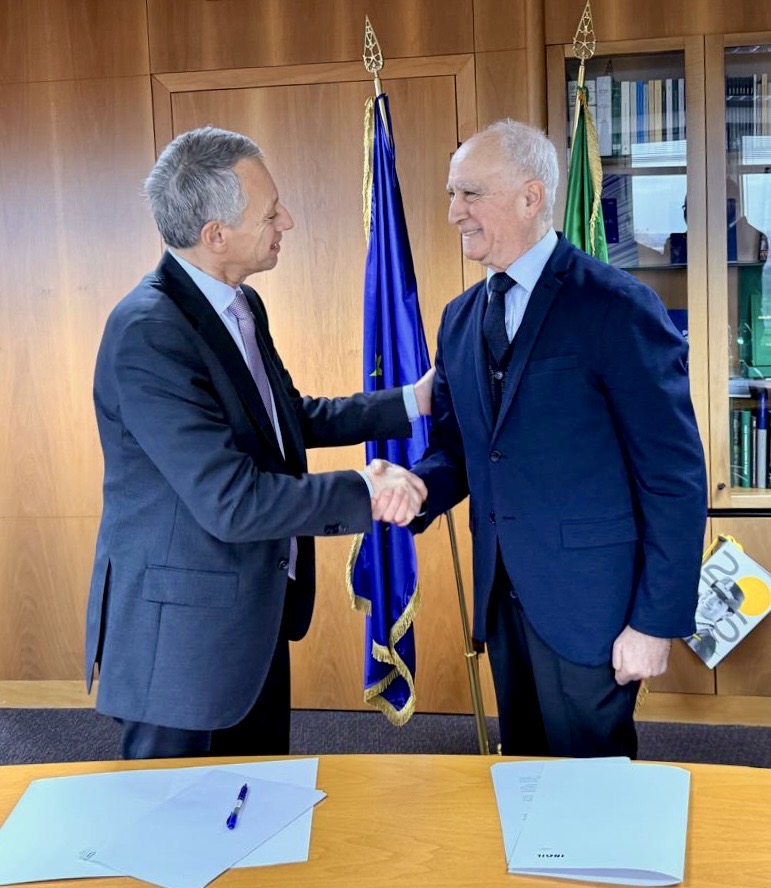«È una transizione che coinvolge tutti i Paesi e sarebbe opportuno osservare come stanno operando quelli che fanno da apripista sulla transizione digitale». Il professor Francesco Profumo, Presidente di Isybank e rettore dell’Open Institute of Technology, già ministro dell’Istruzione, confuta l’idea dell’utilità di vietare i cellulari a scuola.
Professor Profumo, in assenza di una pedagogia digitale consolidata, il divieto non può essere almeno una misura-ponte?
«Viviamo in un mondo accelerato. La velocità dell’altro secolo ormai è un ricordo che non esiste più. Dobbiamo convivere con questa situazione. Naturalmente si possono trovare dei punti di controllo, ma volendo fare una cosa di questo genere bisognerebbe prima definire un modello pedagogico di una scuola generativa, digitale, le cui componenti sono più di una: non sono solo gli studenti, ma anche i docenti. E su un’operazione di questo genere la formazione degli insegnanti è prioritaria. Io credo che bisognerebbe avere una visione complessiva e poi, su quella, definire quali sono i passi e in quale tempo. Perché non è che ci sia molto tempo: i ragazzi crescono velocemente, entrano nella società, entrano nella vita».
Vietare secondo lei rischia di trasmettere l’idea di una scuola che non sa educare all’autonomia. Ma l’autonomia non nasce dopo un percorso di limiti e regole?
«Sì, ma qui il punto è che io mi propongo di insegnare non solo l’uso tecnico degli strumenti, ma anche la logica e le conseguenze. Soprattutto questo. Noi lo stiamo già vivendo, lo abbiamo già vissuto più volte: la tecnologia nasce e muore. La cultura che sta dietro la tecnologia è quella che continua nel tempo. Pensiamo a cos’era inizialmente lo smartphone, a cosa pensavamo potesse essere e a cos’è diventato. E non sappiamo mica ancora che cosa diventerà. Da una parte non credo che si possa mantenere una scuola come quella attuale in un mondo come questo, in cui dovremmo educare le generazioni future. E’ un tema molto più profondo del semplice sì o no».
In Francia esiste la “digital pause”, l’alternarsi tra disconnessione e uso consapevole. In Italia si potrebbe introdurre questi concetto?
«Non è una brutta idea. Naturalmente, se a questo si collega un disegno pedagogico complessivo e l’avvio di tutta l’attività di formazione ed educazione anche dei docenti. Il “pause” significherebbe che durante la giornata ci sono alcune fasi in cui si stacca, ma questo consente anche di utilizzare il telefono come un ambiente, come una grandissima opportunità per un modello educativo molto più stimolante, molto più vicino al sentire dei ragazzi e, in generale, a quelle che sono le necessità della nostra società. Io credo che questa cosa debba essere pensata. Ma sono convinto che l’educazione vada trattata con i guanti: le grandi riforme, molte volte, hanno fallito. L’educazione ha bisogno di evidenze sperimentali. Si può fare: il corpo docente ha le sue difficoltà, ma è fatto di persone di valore. Si potrebbero avviare sperimentazioni, darsi un piano, valutare l’impatto di ciò che è stato fatto. Sarebbe un bel segnale di rispetto per l’evoluzione di questi anni. E darebbe anche speranza: perché poi i risultati arrivano, ma serve un po’ di tempo».
Cosa intende per “educazione generativa”, termine che usa spesso?
«Quando racconto queste cose dico sempre: noi siamo stati educati in una scuola in cui il simbolo era la cattedra. Da una parte c’era il docente, dall’altra gli studenti. La trasmissione era unidirezionale, dal docente allo studente. Oggi non è più così. Sempre di più ci sarà un’ibridazione tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale e sempre di più ci sarà partecipazione degli studenti. Questa cattedra singola verrà rimossa. Avremo un modello di tipo socratico, in cui gli studenti partecipano attivamente: sono importanti le risposte, ma sono ancora più importanti le domande. E bisogna imparare a imparare, perché nel corso della vita bisognerà tornare tante volte a scuola».
Perché questa esigenza di tornare a scuola tante volte?
«Perché le prime rivoluzioni industriali avevano una durata lunghissima. Quella del vapore, dell’energia elettrica, perfino quella dell’automazione: sono durate decenni. Questa, la quarta rivoluzione industriale, durerà molto meno. Non ha come elemento caratterizzante una forma di energia, ma una cogenerazione tra intelligenza naturale e artificiale. E quindi le competenze rischiano di diventare obsolete molto in fretta. Non è più il tempo di imparare un mestiere e basta: bisogna imparare a imparare. Altrimenti, ogni volta che si torna a scuola, si ripartirebbe da zero».
Quindi umano e digitale ormai sono inseparabili?
«Il digitale ha avuto e avrà un’evoluzione di cui non conosciamo ancora tutti gli impatti. Ma sarà rilevante. Nelle prime rivoluzioni industriali c’era una trasformazione dell’attività muscolare. Qui c’è una generazione nuova dal punto di vista cerebrale, molto più profonda. Non bisogna spaventarsi: bisogna avviare processi educativi che accompagnino le persone in questa esperienza, di cui non conosciamo ancora tutti gli elementi, ma che non possiamo ignorare».