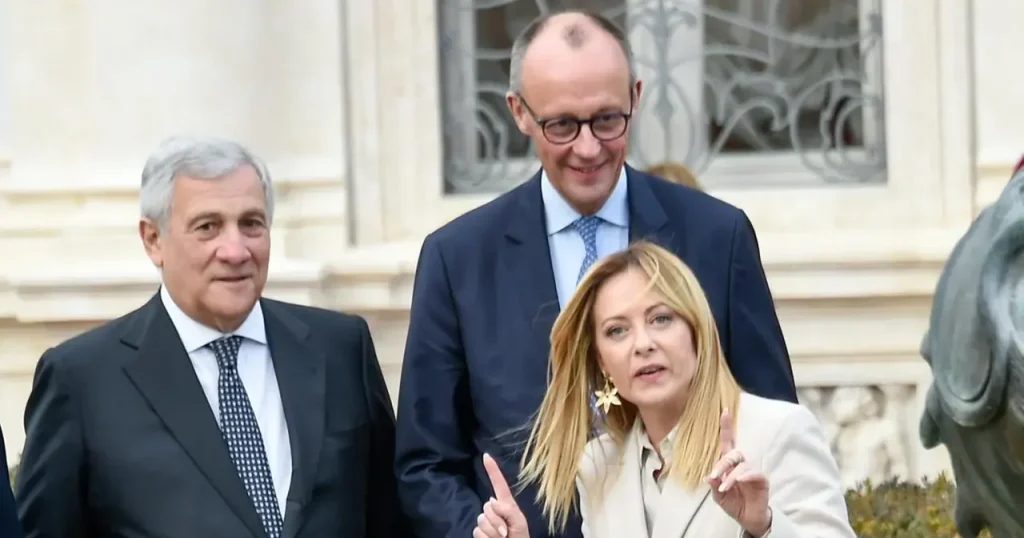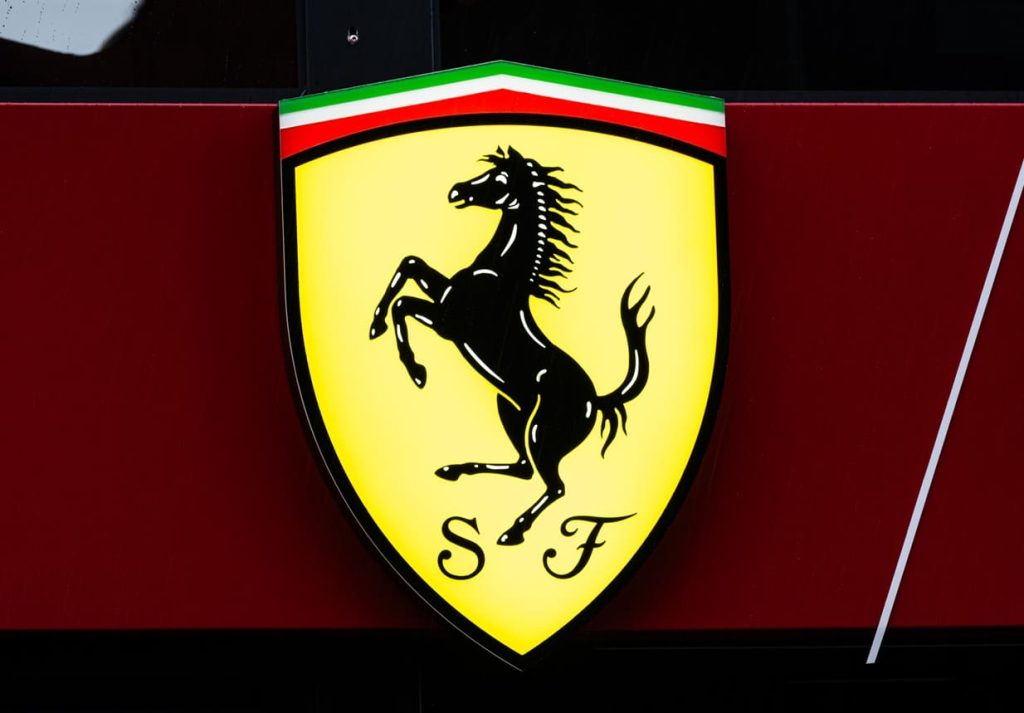La reputazione della personalità è un bene tutelata dalla Costituzione, ma da Tangentopoli si è smesso di tutelarla
Potremmo definire, con una translitterazione creativa dal cinese, “mianzi”, ciò che in italiano significa ”faccia” intesa come “reputazione”. Nella cultura confuciana dell’Oriente estremo rappresenta il valore sociale più importante di cui può disporre ogni uomo. Una volta perduto è la vita stessa a svuotarsi di senso.Eesempi noti anche in Occidente sono i samurai giapponesi, i guerrieri medievali che non esitavano a darsi la morte trapassandosi con la spada piuttosto che sopportare lo smacco di una sconfitta.
Nel parlato italiano, specie nello slang politichese, circola spesso una sua declinazione assai meno solenne e convinta, un’espressione abbastanza urticante, in verità, “ci metto la faccia”, locuzione ambigua che sembra sottintendere due cose. O che solitamente non lo si fa, preferendo nascondere la preziosa porzione anatomica frontale, e dunque, visto che adesso lo sto facendo mi devi pure ringraziare, oppure che chissà cos’altro potrei “metterci” (per scrollare da me responsabilità dirette) e dunque mi devi riconoscenza comunque perché, appunto, non lo faccio.
In realtà la reputazione (una volta si chiamava onore, ma nelle società democratiche può bastare dignità) è, alla fine, l’unica cosa veramente nostra che resta anche dopo che non siamo più su questa terra, che in vita ci segue nella comunità in cui troviamo accoglienza, il bene assoluto che distingue l’essere umano dagli altri viventi.
LEGGI ANCHE Bindi, il PD e il garantismo perduto
Da Tangentopoli in poi
Se tutto questo è vero, appare, allora, piuttosto strano che nel dibattito, molto infiammato, in verità, sulla giustizia legato al referendum, nessuno abbia sfiorato la questione del diritto alla reputazione della persona nel processo, della tutela della sua dignità, al diritto, come diceva il filosofo israeliano Margalit, di non essere umiliato. Quel poco che del merito è stato portato all’attenzione pubblica, infatti, ha riguardato molto gli interna corporis delle carriere magistratuali, delle strutture organizzative e poco o niente il prodotto dei procedimenti, la loro qualità, la ricaduta sulle persone. La reputazione, appunto. Ai tempi di Tangentopoli, nel pieno del furore giustizialista dominante, 41 persone si suicidarono per le accuse infamanti che nei media già li avevano condannati prima ancora che cominciasse il procedimento. Più recentemente ha scosso l’opinione pubblica italiana il caso dei due genitori suicidi di un femminicida.
I diritti della personalità
Qui non c’entra il procedimento, ma il ludibrio malevolo degli odiatori seriali via web porta allo stesso esito. Un’applicazione dell’harakiri, appunto, senza il supporto dottrinario di Confucio, però. Solo per il dolore di aver perduto la propria reputazione sociale. Eppure quella reputazione rappresenta un bene tutelato fin dai primissimi articoli della Costituzione italiana, l’art. 2 e 3, così come viene ricordato dalla Corte di Cassazione in almeno un paio di sentenze.
Non è un fuori luogo questo richiamo costituzionale se solo si pensa che sono quei due articoli a rappresentare le norme-principio su cui si può dire che la nostra Carta sia stata edificata, con l’attribuzione della rilevanza più alta alla “persona umana” e ai suoi diritti inviolabili, attraverso cui è possibile il suo sviluppo (rammentato dalla Corte Costituzionale). Si tratta di “diritti della personalità umana”- la reputazione, l’onore, la riservatezza, l’immagine, il nome- che si rappresentano come tessere di un unico mosaico.
La società decente
Il tema è vecchio e abusato, e incrocia altri valori fondamentali, come quello tutelato dall’art.21 della Costituzione che riguarda il diritto di cronaca. Ma occorre sempre che si operi con equilibrio perché se la reputazione viene violentata per settimane intere attraverso titoli e articoli che reiterano informazioni giudiziarie che dovrebbero essere coperte dal segreto istruttorio. Se l’esposizione sproporzionata genera di fatto una condanna senza appello per i sovraesposti, creando anche un clima che certamente non si concilia con la necessaria serenità richiesta dal giudizio. Se la perversione degli hater nella Rete, sospinta da quel clima, diventa così insopportabile da indurre al suicidio, che cosa resta di quel diritto fondamentale alla reputazione?
Ancora, se la società civile è quella in cui, secondo i filosofi del diritto, i suoi membri non si umiliano gli uni con gli altri, la società decente è qualcosa in più: sono le istituzioni che si impegnano a non umiliare le persone.
Dobbiamo forse domandarci se civiltà e decenza si sentono da noi ancora a casa oppure no.