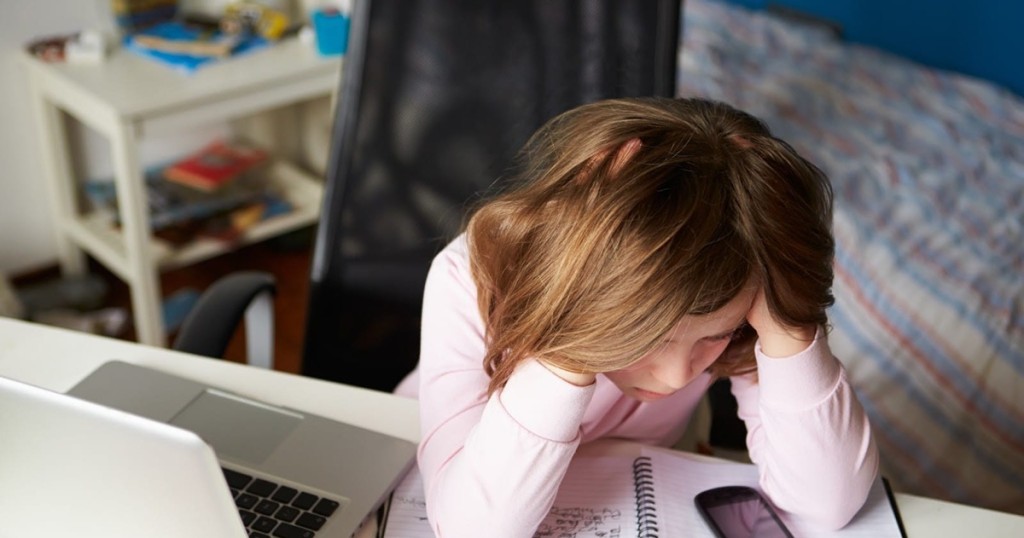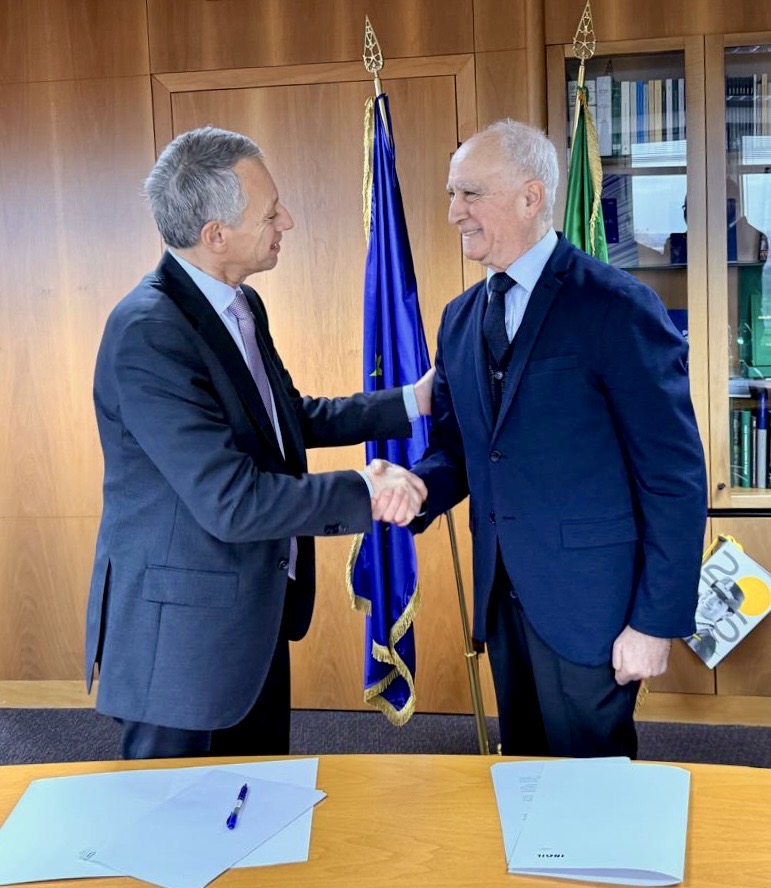In dialogo con l’Altravoce, lo psicoanalista e psichiatra Sarantis Thanopolus riflette sul trauma della prigionia degli ostaggi israeliani e su cosa noi abbiamo sbagliato nel raccontarlo.
In tutto il periodo delle trattative di pace le nostre parole chiamavano costantemente in causa loro, gli ostaggi. Forse troppo, tanto che abbiamo finito per dimenticarne le vite, i corpi, le sofferenze. Insomma, tutto quello che dietro questa parola, “ostaggi”, si nascondeva. Non ci interessa qui scandagliare le loro storie personali, le loro biografie, i loro nomi o le loro origini. Ci interessa capire quello che hanno vissuto e se possono sperare di tornare alla “normalità” pre-7 ottobre. Sarantis Thanopulos è psicoanalista specializzato in psichiatria.
Dottore, cosa vogliono dire 738 giorni di prigionia?
«Senza dubbio l’esperienza è traumatica. Non è solo la prigionia in sè, è l’impatto ad essere devastante. È come trovarsi immediatamente sradicati, come un albero portato via dal vento».
Che cosa viene meno in questo sradicamento?
«Si perde la propria identità, c’è un elemento forte di depersonalizzazione e di deprivazione. Queste persone erano tenute in dei tunnel: il fatto di stare nelle viscere della terra è qualcosa che viene percepito e sentito. Tutto questo crea un enorme trauma psichico».
Quali fattori concorrono a esacerbare questo trauma?
«La sensazione di vulnerabilità e di impotenza in cui sei costretto a vivere. Inoltre, per sopravvivere in quelle condizioni sei costretto a dissociarti dal tuo corpo. A ciò va aggiunto che l’apparato psichico non riceve il nutrimento che normalmente riceve dai sensi. In quelle condizioni la preoccupazione maggiore non è quella di sopravvivere fisicamente, ma quella di non impazzire, di non perdere il senso dell’esistenza. C’è una contrazione psichica enorme».
E poi c’è il fatto di essere vittime di violenza.
«La violenza viene iscritta all’interno dell’apparato psichico e accompagnata da un sentimento di rabbia che non si può esprimere».
Il momento della liberazione cosa rappresenta?
«Lo paragonerei all’esperienza di un cieco che dopo un’operazione ricomincia improvvisamente a vedere. Ma il ritorno alla vita ha a sua volta qualcosa di violento».
LEGGI Il giorno della liberazione: lacrime e gioia a Israele e Gaza
Ci sono dei margini di recupero dal trauma o è un’esperienza destinata a segnare la vita futura di queste persone?
«Ci sono naturalmente persone più vulnerabili che possono avere conseguenze più persistenti. Molto dipende dal contesto familiare e da come i parenti hanno elaborato la perdita. Prima di uno o due anni è quasi impossibile superare il trauma, ma può segnarti anche per l’intera vita».
Nel dibattito pubblico ci siamo un po’ dimenticati del problema del corpo degli ostaggi. Pensa che la categoria di “nuda vita” descriva efficacemente la loro condizione dal 7 ottobre 2023 fino a ieri?
«Non solo gli ostaggi sono ridotti a nuda vita, ma vengono anche trattati come nude vite prive della loro umanità. Ma sono anche loro a dover denudarsi di sè per poter sopravvivere. Sono corpi che si svendono».
C’è una responsabilità anche nostra in tutto questo, relativa al modo in cui abbiamo raccontato la questione degli ostaggi?
«Ne abbiamo fatto tutti una narrazione sbagliata. Abbiamo reso quei corpi qualcosa di astratto, un oggetto negoziale. Pensiamo anche ai conti relativi a quanti ostaggi vivi e quanti vengono restituiti come cadaveri. Tutto questo è disumanizzante e dovrebbe farci porre seri interrogativi sul modo in cui viviamo».
Che cosa intende dire?
«La dimensione mediatica rischia di creare assuefazione. Il continuo ragionare di come gli ostaggi avrebbero potuto essere usati ha rischiato di renderci alla fin fine del tutto insensibili e di non smuoverci mai dal piano retorico. Io personalmente posso identificarmi con i cari che li hanno accolti. E sospendo ogni altra valutazione».
LEGGI Trump a Sharm: «Al via fase 2». Il summit dei leader mondiali sul futuro di Gaza