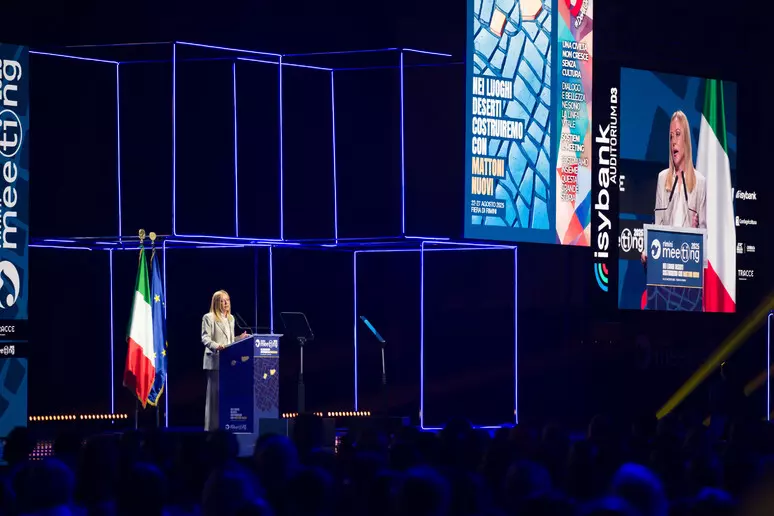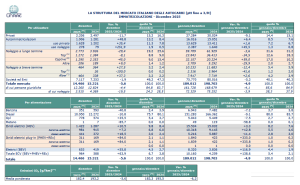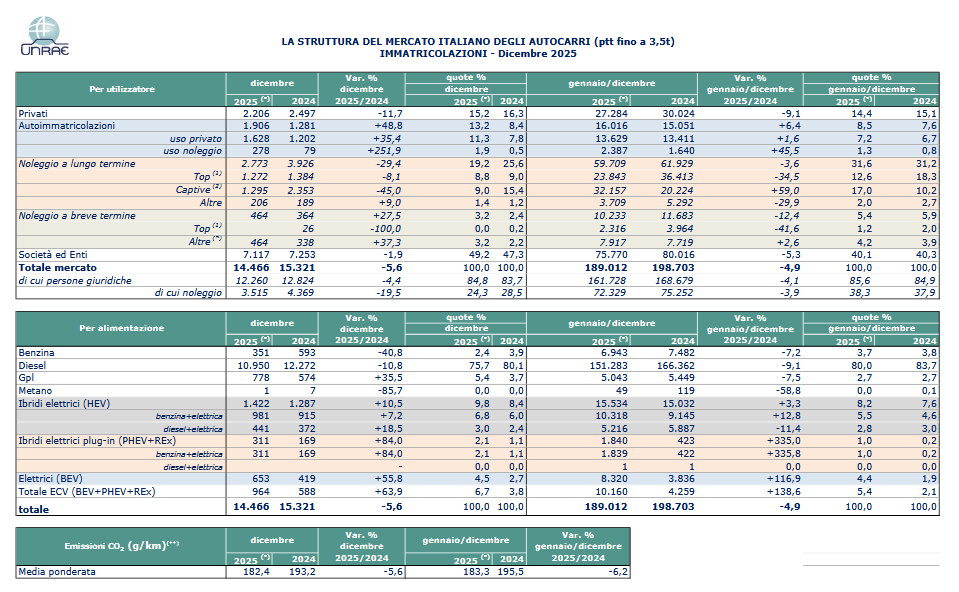C’è qualcosa che non torna e qualcosa che, tuttavia, c’interroga nel coinvolgente discorso di Giorgia Meloni al meeting di Rimini. A un’attenta riflessione, il rivendicato pragmatismo di una destra fondata su valori religiosi e comunitari, convinta della missione culturale dell’Occidente, che parla la lingua della famiglia, del lavoro, della sussidiarietà, che si ispira a Eliot e a Ratzinger, che rivendica una tradizione da reinventare, mostra non poche contraddizioni nel confronto con ciò che il governo e la maggioranza di centrodestra hanno fatto e detto in questi tre anni.
La prima contraddizione riguarda l’europeismo. Non si può infatti riconoscere in maniera esplicita la frattura che si è aperta in Occidente e che il ciclone Trump ha certificato, dire che Draghi ha ragione e invocare allo stesso tempo «un’Europa che faccia meno cose ma le faccia bene». Non solo perché le soluzioni proposte dall’ex presidente della Bce alla fragilità geopolitica del Vecchio Continente muovono tutte verso il completamento della dimensione sovranazionale, e prescrivono nello specifico una nuova governance, un bilancio continentale cospicuo, una massiccia dose di debito pubblico e una regia comunitaria degli investimenti in tutti i settori strategici, mentre nessuno di questi obiettivi è espressamente visibile nel pur benvenuto impallidire del sovranismo meloniano. Ma anche perché la fine dell’equilibrio multipolare e il caos globale che attraversa il mondo fanno più stretta l’interdipendenza tra potenza militare, forza economica e primato tecnoscientifico, punti su cui l’Europa paga non tanto la debolezza degli Stati membri, quanto piuttosto la loro solitudine nel fronteggiare fenomeni che ormai sono troppo più grandi della loro sfera d’azione.
La seconda contraddizione riguarda il modo di intendere la sussidiarietà, che pure nel suo discorso Giorgia Meloni collega correttamente a una pedagogia del dovere, con un forte richiamo alla responsabilità collettiva. Se si guarda al rapporto tra questa maggioranza e le diverse minoranze organizzate del suo bacino elettorale, è facile vedere come nella prassi la sussidiarietà si sia tradotta troppe volte in corporativismo, accentuando una cronica patologia del sistema italiano. Questa tendenza si esprime non solo nella rinuncia a smontare i fortini di alcune categorie protette, come i tassisti e i balneari, ma nell’uso della leva fiscale per fidelizzare, attraverso una declinazione parziale e strumentale della flat tax, un bacino elettorale di riferimento del lavoro autonomo, e per stabilire, attraverso una scellerata rottamazione delle cartelle esattoriali, un patto fondato sull’ambiguità con quote di contribuenti che rappresentano altrettante sacche di irresponsabilità civile. Altro che doveri!
Ma questo malinteso senso della sussidiarietà si esprime, a un livello più alto, in patti di scambio con alcuni ben precisi oligopoli privati, per riportare sotto controllo segmenti chiave del mondo bancario e del mercato finanziario che avevano fin qui goduto di un’indipendenza consona allo statuto di una democrazia liberale. Più grave è che ciò avvenga attraverso l’uso abnorme del golden power, uno strumento che dovrebbe servire a proteggere segmenti chiave dell’economia nazionale da incursioni straniere, non a truccare il risultato di competizioni tutte italiane tra poteri diversamente orientati rispetto all’azione di governo. Di fronte a questi giochi, l’invocazione “meno Europa” sembra esprimere l’irritazione per un controllo sovranazionale e un malinteso senso della sovranità all’interno di una prospettiva di integrazione.
La terza e ultima contraddizione riguarda la pur giusta rivendicazione di una riforma della giustizia perseguita come una sfida di liberazione, mossa alla casta del sistema correntizio magistratuale. Tutto bello e giusto, se non si accompagnasse a provvedimenti di matrice securitaria e a un’inazione cinicamente indifferente alla tragedia del sistema carcerario italiano. Questa doppiezza appare sartorialmente ritagliata sugli interessi di ben specifici soggetti di riferimento, ed è anche in questo caso frutto di un garantismo che distingue tra i deboli propri, meritevoli di indulgenza e tutela, e i deboli altrui, assunti a bersaglio di un rigore spendibile in chiave elettorale.
In conclusione, Meloni razzola peggio di come parla, ma la sua persuasiva eloquenza è, nel deserto delle alternative, sufficiente a prendersi la scena e gli applausi, oscurando il riformismo liberale, che in Italia ha voce flebile, e umiliando un’opposizione divisa e inconsistente, schiacciata in una concrezione tra gli slogan del vecchio sindacalismo novecentesco e il nulla del populismo post grillino. Ma perché la sua avventura approdi a una prospettiva compiutamente comunitaria occorrerà che nella prassi i valori abbiano almeno lo stesso peso degli interessi.