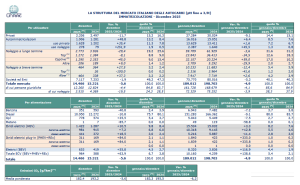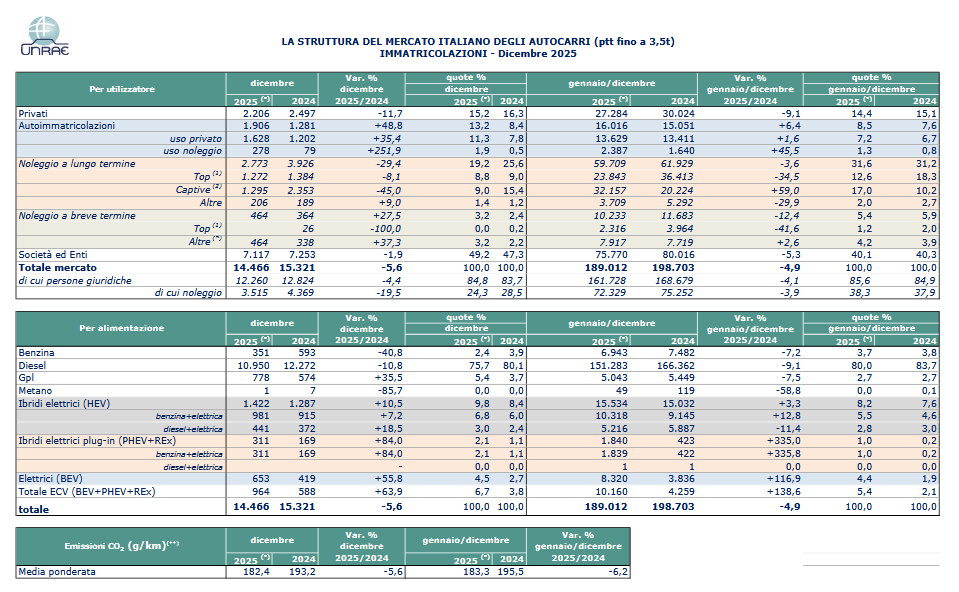Si può immaginare l’apertura del nostro governo alla via degli sminatori – la via delle buone intenzioni – come la metafora perfetta dell’approccio italiano all’Europa e alla guerra in Ucraina: partecipare senza compromettersi, esserci restando ai margini.
La logica è, al di là di ogni considerazione nel merito della disponibilità annunciata, piuttosto chiara: se Berlino mostra fermezza con Putin, se Ottawa stanzia mezzo miliardo di dollari in armi, l’Italia non può restare spettatrice, ma nello stesso tempo non vuole esporsi a una guerra che nell’opinione pubblica resta – inutile negarlo – impopolare. Così nasce la formula dell’impegno tecnico – non truppe, ma nemmeno semplice neutralità; non partecipazione al conflitto, ma nemmeno indisponibilità all’assistenza – che è anche l’ennesima incarnazione della nostra arte del rinvio. In fin dei conti un equilibrio che sa di escamotage.
Dentro questa ambiguità il ministro Matteo Salvini si muove come un pesce nell’acqua: è lui, nel governo italiano, a incarnare più di chiunque altro la figura dello smarcamento, lui che coltiva ormai da tempo le sue «eresie di consenso»: parla ai pacifisti di professione, agli euroscettici incalliti, ai reduci del no-vax, a quel ceto elettorale che si nutre di slogan più che di scelte, di paure più che di visioni. E se riesce a farlo senza minare la coalizione è perché gioca – molto al ribasso – su due tavoli: approva infatti le missioni in Consiglio dei ministri, ma sui social e nelle piazze deride l’Europa e ammicca a Mosca.
Il suo lessico è quello dell’irrisione: fa le sue battutine su Emmanuel Macron, provocando un incidente diplomatico con la Francia, perché cerca applausi facili. Finché Meloni conserva l’egemonia nel governo e la credibilità in Europa, può continuare a farlo, recitando impunemente il ruolo del tribuno a beneficio del suo piccolo pubblico che ignora in fondo i grandi cambiamenti negli scenari internazionali e riducendo la politica estera a teatro di cabaret.
Ma il mondo non aspetta certo i calcoli di via Bellerio. Prima o poi l’Europa, una volta raggiunta la pace – si spera molto prima che poi – dovrà decidere: se vuole garantirla, questa pace, dovrà dotarsi di un esercito comune e di un piano coordinato di riarmo. Dovrà cioè assumersi responsabilità che non si risolvono solo con l’invio degli sminatori. E in quel momento i giochini di Salvini diventeranno un problema sistemico, non solo per la coalizione, ma anche per la credibilità internazionale dell’Italia.
Che cosa significherà, infatti, in un futuro ormai immediato, stare in Europa, se non assumere che la sicurezza del continente non può più dipendere solo dalla Nato, né dagli umori di Trump al telefono con Putin? La risposta sprezzante di Salvini alle «macronate» – così il nostro ministro ha bollato i progetti del presidente francese su «eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili» – non è solo sarcasmo contro un leader politico già inviso al populismo italiano. C’è, naturalmente, di più. C’è la negazione dell’idea stessa che l’Europa possa emanciparsi dalla tutela americana, darsi strumenti comuni, pagare il prezzo della propria sicurezza. È il linguaggio della derisione elevato a piattaforma politica. Salvini si fa interprete, così, di un miscuglio di pulsioni che attraversano l’Italia: euroscettici che temono un super-Stato, pacifisti che rifiutano ogni spesa militare, sovranisti che preferiscono trattare direttamente con Mosca, nostalgici che coltivano l’illusione dell’Italia «neutrale». È la sua nicchia di consenso, per fortuna minoritaria, coltivata senza mai trasformarla in responsabilità di governo
Così la frattura potenziale della coalizione si misura in questa distanza: un partito che vuole parlare la lingua del consenso immediato, di «pancia», contro un partito che tenta di parlare la lingua, seppur timida e cauta, della responsabilità europea. Ma non è solo la maggioranza a vivere di ambiguità. Nessun partito dell’opposizione ha il coraggio di dire che l’Italia deve assumere un impegno alla pari con gli altri governi europei. Ci si limita a invocare la pace senza nominarne i costi, senza dire come costruire un’architettura di sicurezza in Europa, preferendo richiamare genericamente l’unità europea senza mai indicare strumenti concreti. È lo specchio di un vizio antico, la tentazione di parlare alto e agire piano, di rifugiarsi nelle formule ibride, nell’attesa che siano altri a prendere decisioni scomode. L’Italia intera, maggioranza e opposizione, si muove così: dentro un eterno gioco di specchi in cui tutti si lasciano spazi di incertezza.
Per quanto ancora continueremo a navigare in questa ambiguità? Perché l’Europa presto arriverà al bivio: e in quel momento l’Italia non potrà cavarsela con gli smarcamenti di Salvini, con i compromessi del governo, e nemmeno con i silenzi dell’opposizione. Quando l’Italia, nel prossimo «dopoguerra», dovrà assumere il proprio posto accanto a Francia e Germania, infatti, non ci sarà più spazio per i doppi registri, né per i lazzi da comizio. Sminare i campi di battaglia è doveroso, ma prima occorrerà sminare la politica italiana dal suo vizio più antico: l’arte di rinviare le decisioni più importanti, confidando che siano altri a sostenerne il peso. Perché la pace è un compito politico, e chi si illude di aggirarlo con i trucchi della propaganda e la vecchia partita del «particulare» scoprirà presto che le mine più pericolose non sono sotto terra, ma dentro la nostra incapacità di scegliere.