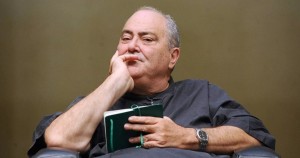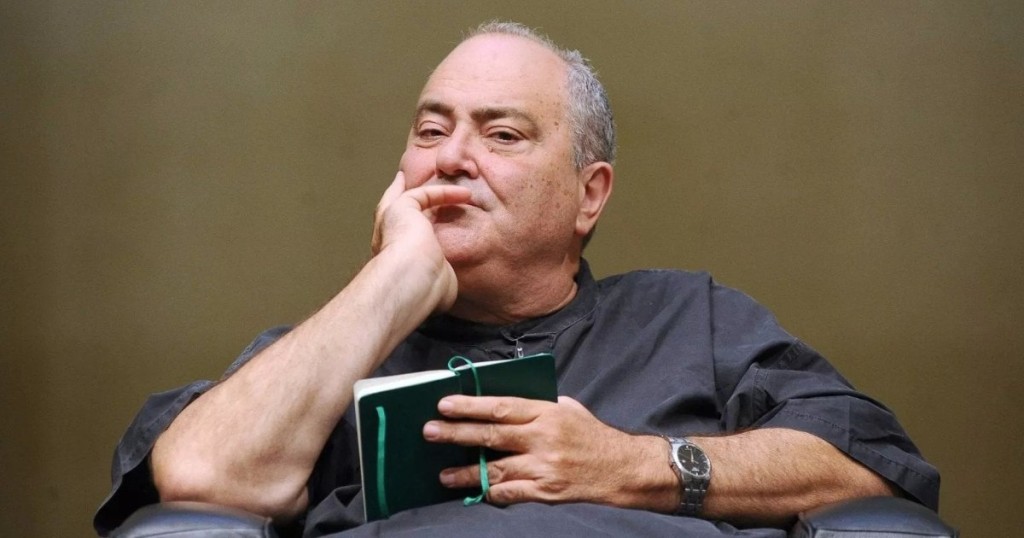La parola «corruzione» è forse quella che, più di ogni altra, scandisce la storia pubblica dell’Italia contemporanea, un termine che dovrebbe descrivere una precisa fattispecie penale ma che, negli anni, si è gonfiato fino a diventare una delegittimazione generalizzata, un sospetto permanente.
È la parola con cui abbiamo imparato a leggere ogni stagione politica, l’ombra che si allunga su ogni vigilia elettorale, la formula con cui i giornali aprono le prime pagine e con cui la società civile misura il proprio grado di indignazione. Non indica più soltanto un reato tipico, ma un’etichetta pronta a marchiare e a travolgere. È diventata, cioè, la parola con cui il Paese si racconta a sé stesso, la lente con cui leggere ogni vicenda collettiva.
Così, quando vediamo esplodere inchieste a Bari, Torino, Genova, e da ultimo a Milano, tutte a ridosso delle elezioni, assistiamo a un rituale ripetuto: prima la deflagrazione mediatica, la consegna delle intercettazioni alla pubblica indignazione, il clima di emergenza morale; poi, con il tempo, l’evaporazione silenziosa tra archiviazioni, prescrizioni, contestazioni ridimensionate. L’inchiesta, intanto, ha prodotto però un effetto narrativo, sostituendo la giustizia alla politica come grande romanzo nazionale. In questo l’eredità di Mani Pulite, che non fu soltanto un’inchiesta giudiziaria bensì la creazione di un nuovo immaginario – la corruzione come cifra assoluta, l’illegalità come essenza di un sistema – sta producendo ancora le sue conseguenze, come un’onda lunga.
E la vicenda giudiziaria che ha colpito Milano è il segno più chiaro di come questo immaginario funzioni e, al tempo stesso, di come cominci a mostrare le sue crepe. L’inchiesta è esplosa anche qui con il consueto fragore: intercettazioni, nomi noti, accuse gravi, la sensazione che ancora una volta il cuore amministrativo del Paese fosse contaminato. Milano si è vista trascinata nel cono d’ombra. Poi il Tribunale del Riesame ha cominciato a revocare le richieste di custodia cautelare formulate dalla procura. Fino all’ultima, la sesta, che ha annullato gli arresti domiciliari anche per Manfredi Catella. È un dato, questo, che pesa quasi come una sentenza. Non nel merito del processo, che dovrà andare avanti e stabilire le responsabilità, ma nel senso politico e civile di ciò che significa.
L’impianto narrativo che aveva travolto il capoluogo lombardo si è infranto contro la terzietà del giudice, mostrando tutta la sproporzione tra la potenza del racconto e la fragilità delle prove. E forse per la prima volta, dopo anni di automatismi, ci troviamo di fronte a un punto di resistenza. Milano, a differenza di altre città – a Genova un’indagine analoga ha portato alle dimissioni del governatore, destabilizzando il quadro politico – non è crollata sotto il peso dell’inchiesta. Ha accusato il colpo, certo, ha aperto un dibattito pubblico, ha riconosciuto errori e contraddizioni, ma ha retto, dimostrando di possedere anticorpi culturali e civili che altrove sembrano indeboliti. Parliamo di una città che negli ultimi trent’anni ha costruito un modello di sviluppo e di amministrazione capace di integrare pubblico e privato, di mantenere una continuità politica pur attraverso alternanze, di preservare un tessuto civile coeso. Di una città che, a differenza di altre, non si è consegnata al populismo, che ha difeso un equilibrio tra governo e società, che ha tenuto viva una cultura amministrativa.
Per questo l’inchiesta attuale ha assunto un valore così simbolico. Si trattava, infatti, di mettere in discussione un modello, di delegittimare un’intera stagione amministrativa, insinuando l’idea di una corruttela diffusa. La vera domanda da porsi è allora questa: che cosa intendiamo oggi per corruzione? Se essa coincide con tutto ciò che appare ingiusto, allora continueremo a vivere in una Repubblica in cui l’inchiesta è la forma della politica, e la politica sopravvive solo per essere processata. Se invece corruzione torna a significare ciò che il codice prevede, allora sarà possibile distinguere di nuovo, separare l’azione penale dal mito, difendere la politica come spazio legittimo di decisione. Milano ci ha ricordato che questa distinzione è ancora possibile.
Che la corruzione è un problema serio, certo, ma trasformarla in una chiave di lettura totalizzante finisce per divorare la politica senza produrre giustizia. Allora c’è ancora un’altra domanda da porci: non soltanto che cosa intendiamo per corruzione, ma se siamo disposti a lasciare che la sua evocazione come parola-totem diventi la nuova forma della sovranità, o se invece siamo capaci di ricostruire un equilibrio democratico in cui il diritto torni a essere diritto e la politica torni a essere politica. Milano, forse, ci sta dando la risposta giusta, proponendosi come laboratorio di resistenza.