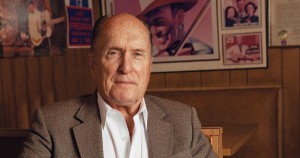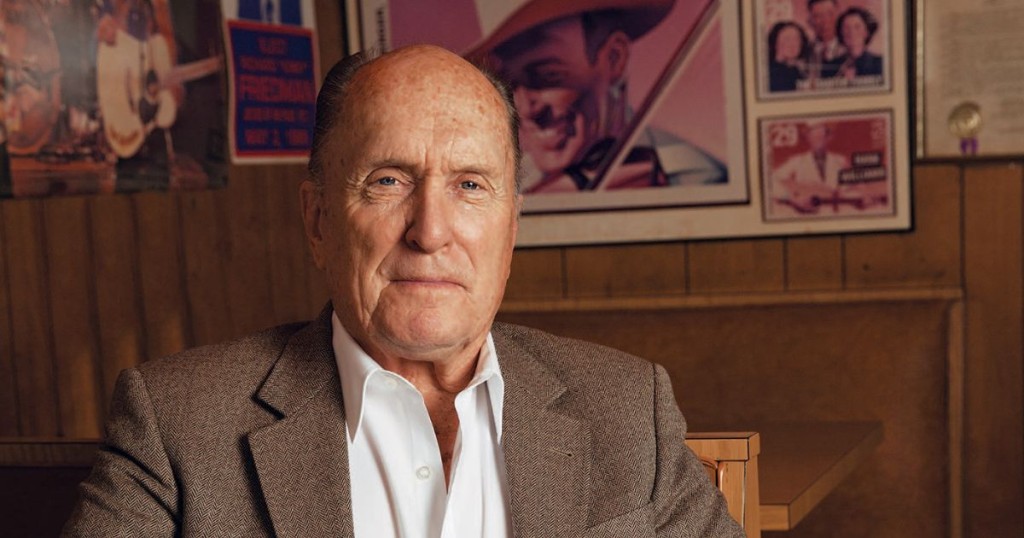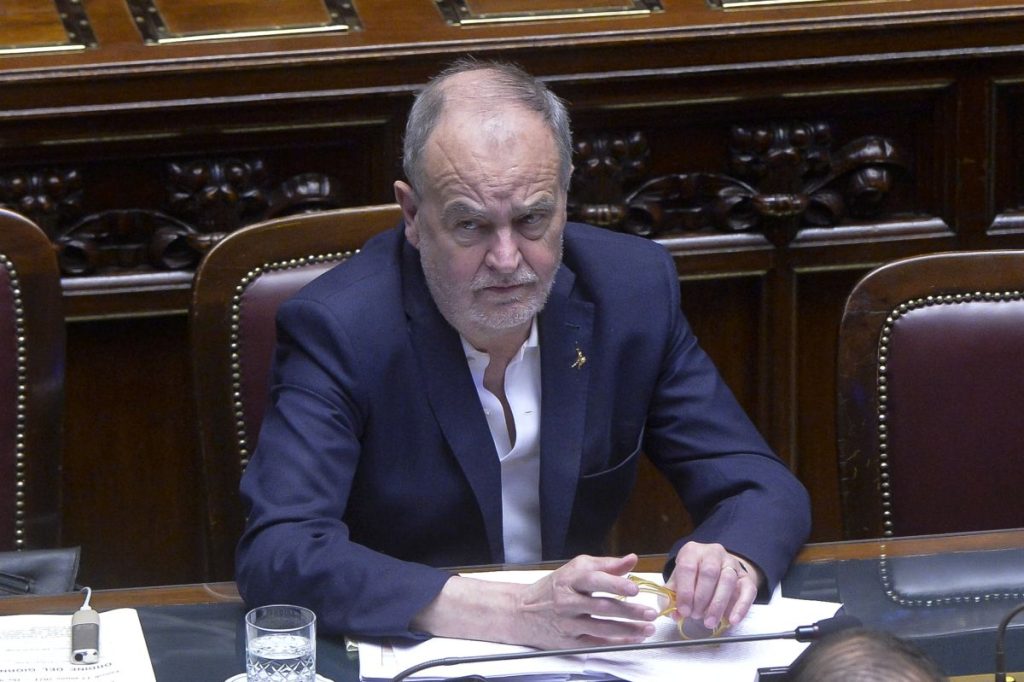L’Occidente è anche latino. La presidenza Trump, l’offensiva cinese, la guerra in Europa, la crisi nella regione islamica hanno avuto un impatto potente nell’America centrale e meridionale, ma con gradi molto diversi di penetrazione (o di attenzione). Nonostante questo, gli Stati latini e le loro diverse aree regionali hanno sempre declinato una propria versione del momento storico dell’Occidente. Si tratta di un contesto immenso territorialmente, demograficamente, economicamente, politicamente, con infinite sfaccettature, peculiarità, tradizioni, in cui possiamo cercare alcune linee comuni, funzionali al confronto con il resto dell’Occidente globale.
SUDAMERICA, PAGINE DI UN CONTINENTE
All’inizio del XIX secolo, con l’indipendenza, furono del tutto inventati oltre venti Stati, in grande parte sulle ceneri dell’impero spagnolo (e su scala minore di quelli portoghese e francese). Si creò uno spazio politico relativamente omogeneo dal punto di vista culturale e linguistico, quanto fragile nello sviluppo delle istituzioni statuali e dell’accesso alla rivoluzione capitalista: erano stati privi di qualsiasi esperienza precedente o di modelli di élite consolidate. I sistemi politici latini erano però integrati a quelli europei: a partire dalle famiglie liberale e conservatrice (e poi socialista), con accentuazioni federaliste, autonomiste, democratiche.
L’emigrazione di decine di milioni di europei in America e la formazione delle élite latine a Parigi, Londra, New York conservò questa omogeneità. Allo stesso tempo, l’America post-spagnola si allontanò subito dai grandi conflitti europei.
Innanzitutto, la scomparsa delle monarchie (dopo gli ultimi fuochi in Messico e Brasile) e la pressocché totale affermazione dei modelli repubblicani esclusero il continente dalle ultime tappe della lotta tra assolutismo e liberalismo in Europa. In secondo luogo, le realtà nazionali erano fragili: rivoluzioni, conflitti interni, guerre civili furono il motore della costruzione statuale, mentre le potenze europee edificavano grandi imperi, progetti ideologici potenti, guerre mondiali di proporzioni mai viste prima.
ASFALTO, ACQUA, PIETRA: IL FUTURO DI UN EMISFERO
L’America latina, tranne eccezioni marginali, non partecipò né alle esperienze imperiali né ai conflitti globali, continuando un suo percorso originale segnato da rivoluzioni e guerre sanguinose, in genere civili, ma mai comparabili a quelli europei. Questa distanza non fu mai tale sul piano politico-culturale. Infatti, iniziata la Guerra Fredda, si accentuò l’integrazione tra modelli e sistemi di partito, oltre che nelle relazioni internazionali. Il processo di costruzione e consolidamento statuale, così come di integrazione nel capitalismo industriale (con una sua impressionante declinazione di impresa pubblica), continuò con successo, nonostante le tensioni che avevano ribaltato anche nelle Americhe centrale e settentrionali il conflitto tra comunismo e democrazia.
Questo scontro ebbe due variabili estreme, potenti e radicali, con la formazione del regime marxista a Cuba (con partiti e guerriglie affini ovunque) e lo sviluppo di dittature militari nella parte meridionale del continente. Gli USA erano entrati in forza nel continente, facendo da garante e controllore, contro ogni intrusione di tipo filosovietico o rivoluzione similare. In genere, nei paesi a tenuta democratica, si affermarono partiti di tipo europeo (socialdemocratici, democristiani, radicali, conservatori), ma con una accentuazione populista, all’interno di uno stato di tensione permanente e irrisolto, condizionato dalle fratture sociale e da un’intensa ideologizzazione della società.
Quando crollò il sistema sovietico, per un attimo anche l’America latina sembrò avviarsi verso un processo di tipo europeo, con la definitiva scomparsa del ruolo dei militari, l’integrazione nel capitalismo globale, la ritirata precipitosa degli USA. Invece, non fu così. Se da un lato quasi tutta l’America latina conobbe, con gradi diversi, una intensa crescita economica, simboleggiata dalla impressionante affermazione del ceto medio, dall’altro questo meccanismo si inceppò sul terreno della stabilizzazione dei sistemi politici, della pacificazione sociale, della violenza criminale. Le due tendenze sopravvissute della Guerra Fredda, il marxismo e il populismo, sopravvissero e si intrecciarono. A sinistra, si formò il Foro di Sao Paulo, una alleanza di partiti radicali, populisti o autoritari, spesso con declinazioni violente, ispirate da Castro (Cuba), Lula (Brasile) e poi incarnata da Hugo Chavez, a destra si sviluppò un populismo conservatore e liberale, interpretato da Calderon (Messico), Cardoso (Brasile) e infine da Uribe (Colombia).
Nella prima parte del XXI secolo Chavez e Uribe hanno rappresentato i due poli opposti di questa storia. Il primo è giunto al potere con un discorso moralista, giustizialista, denso di promesse sociali: ha trasformato un Paese relativamente democratico e stabile, il Venezuela, in una dittatura perversa e ossessiva. Il suo successore, Maduro, ha poi provocato la peggiore crisi umanitaria della nostra epoca. Uribe fu eletto con la promessa di affrontare narco-guerriglie marxiste, paramilitari, cartelli criminali, che avevano drammaticamente destabilizzato il Paese. Realizzò un risultato opposto a Chavez, perché riuscì a vincere la guerra, salvaguardando le istituzioni democratiche e rafforzando l’economia colombiana. Nonostante questo, la partita non era per nulla chiusa.
L’America Latina entrò frammentata nel tempo presente, quello dello scontro tra democrazia ed autocrazia. Il quadro internazionale è stato indebolito dalla aggressiva presenza di russi, cinesi e iraniani nelle dinamiche politiche continentali, oltre che dalla persistente distanza degli USA. Soprattutto, questo processo è stato accentuato dalla radicalizzazione estremista di una parte importante di élite politiche ed intellettuali, accese da discorsi postcoloniali, antioccidentali e in genere illiberali, indifferenti alla degenerazione dittatoriale del castro-chavismo. Un meccanismo che ha provocato una reazione simile al trumpismo, denso di insofferenze verso i proclami del politicamente corretto, della rivincita sociale, dello stato oppressore. I presidenti di Brasile e Argentina, Lula e Milei, interpretano ora queste due posizioni opposte.
I PARTENARIATI UE-AMERICA LATINA
In realtà, tra mille sfumature, si delineano anche altri progetti radicalmente alternativi: da un lato Ecuador e El Salvador, che hanno fatto dello stato minimo e della lotta senza esclusioni di colpi alla criminalità la loro bandiera; dall’altro Cuba, Nicaragua e Venezuela, che mantengono in piedi dittature para marxiste brutali, ma del tutto fallite sul terreno sociale, economico, civile. L’arrivo della tempesta di Trump ha avvicinato il continente all’Europa, sia per lo scontro con il Messico, sia per le alleanze costruite nel continente. Russi e cinesi hanno cominciato a perdere terreno, mentre le guerre in Europa e in Oriente restano ancora lontane. In ogni caso, l’America latina resta parte importante dell’Occidente, e sta facendo i conti con l’attacco alla democrazia, sia nelle istituzioni, che nel discorso pubblico, che è uno dei passaggi decisivi della nostra epoca.