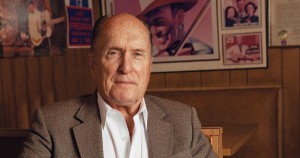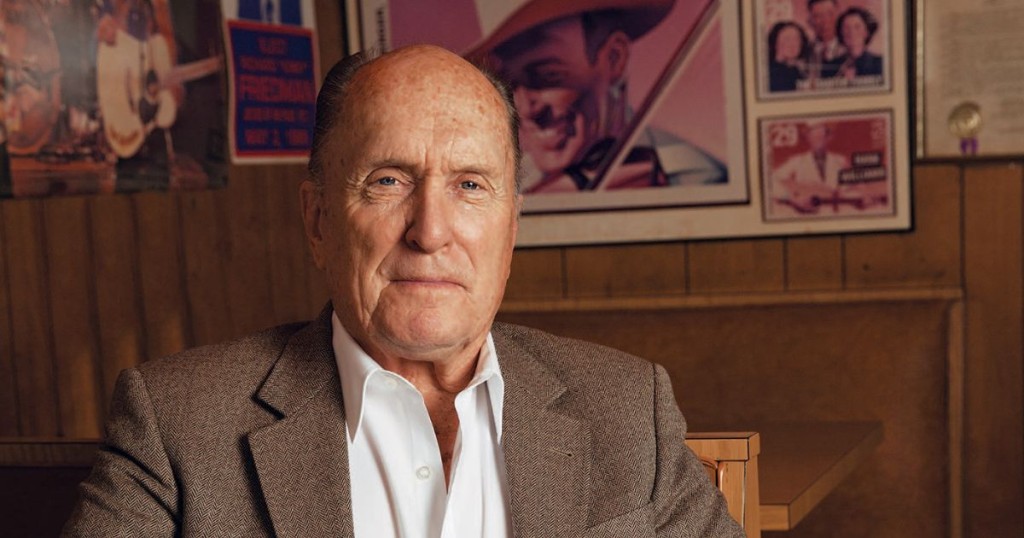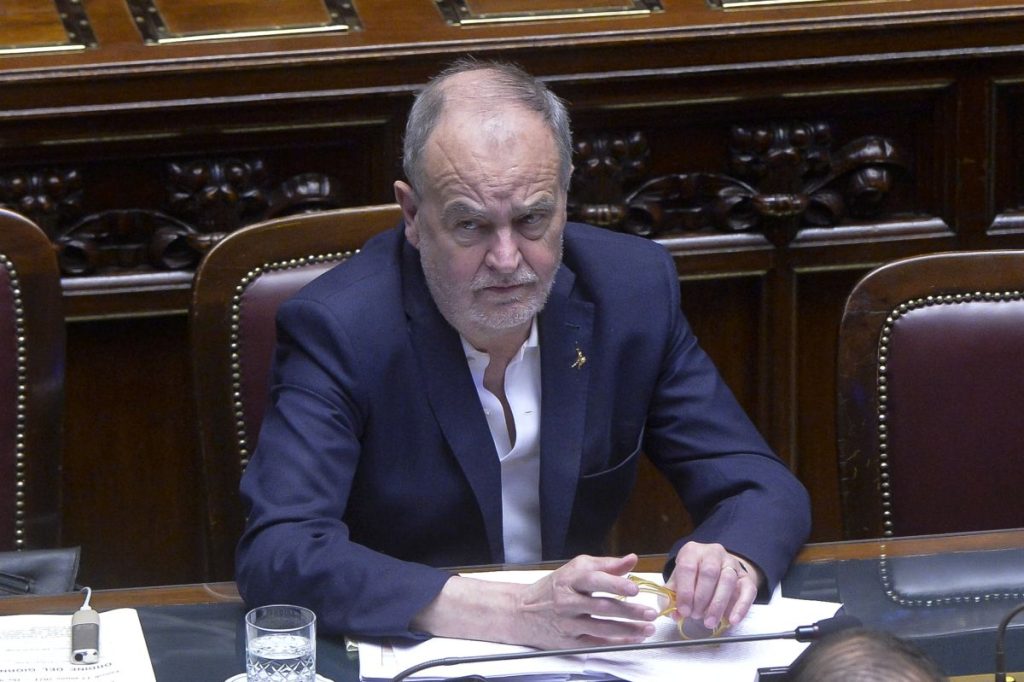L’accordo raggiunto tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi va valutato su piani distinti: politico, economico, strategico. E, su ciascuno di essi, racconta più debolezze che successi. Non solo europee, come una certa narrativa vuole far credere, ma anche (e forse soprattutto) americane.
Sul piano politico, è evidente quanto l’Unione Europea si muova con un passo incerto. Nonostante la Commissione cerchi di parlare a nome di tutti i Ventisette, la frammentazione degli interessi nazionali e l’assenza di una vera autonomia strategica restano i suoi talloni d’Achille. In questo scenario, la trattativa con Washington ha assunto i toni di una gestione danni più che di una vera negoziazione.
Lo si capisce anche osservando le reazioni nell’arena pubblica. Sui social media abbondano i commenti amareggiati sul presunto “orgoglio perduto”, e non mancano nostalgici che invocano il ritorno alla “liretta”, come se abbandonare la moneta unica fosse la scorciatoia per riconquistare sovranità. Ma è una narrativa fuorviante: a mancare non è l’indipendenza monetaria, bensì una convergenza politica capace di produrre strumenti comuni — da una difesa efficace alle tecnologie critiche — con cui poter negoziare davvero alla pari con le grandi potenze.
I dazi sono tassa sui consumi interni americani
Dal punto di vista economico l’impatto sull’Europa potrebbe non essere tropo negativo. L’accordo svela molte delle contraddizioni della politica protezionistica americana. I dazi non sono un segno di vittoria, ma una tassa sui consumi interni. E come ogni tassa, devono essere pagati da qualcuno. In questo caso, dagli stessi importatori statunitensi che avranno il dilemma se assorbire il costo nei loro margini, come è successo nei primi mesi, oppure trasferirlo sui consumatori finali come probabilmente succederà nel medio periodo per la maggior parte dei beni. Molti prodotti europei, infatti, appartengono a fasce di mercato medio-alte e godono di una domanda relativamente rigida. Non saranno facilmente sostituibili da equivalenti locali, anche per ragioni di qualità percepita e reputazione. Il “parmesan” americano non è il Grana, né lo diventerà.
E non basta un dazio per mutare il gusto del consumatore. Di conseguenza, anche se l’export europeo subirà un colpo, non è affatto detto che il mercato statunitense risponda con una crescita significativa della produzione domestica. Gli Stati Uniti non hanno un’infant industry da proteggere nel settore dei formaggi stagionati o della meccanica di precisione: non c’è capacità produttiva inutilizzata da rilanciare, né investimenti pronti a scattare. E’ quindi probabile che le riduzioni di quantità dell’export europeo saranno minime.
Il problema delle compensazioni
In questo contesto, le richieste di compensazioni e sussidi da parte dei produttori italiani vanno maneggiate con cautela. Stanno già circolando stime fantasiose su perdite miliardarie di fatturato.
Ma i danni economici reali, se ci saranno, andranno valutati con metodo: non in base al fatturato mancato, ma agli eventuali profitti perduti. Sussidi a pioggia, in assenza di un’analisi puntuale, rischiano solo di trasformarsi in rendite.
Sarebbe stato bello poter rispondere “a muso duro”, come alcuni invocano. Ma la verità è che l’Europa non aveva carte forti in mano. Non possiede risorse strategiche insostituibili, come le terre rare. È assente da molte delle tecnologie più avanzate. E non può minacciare dazi sulle piattaforme digitali americane senza danneggiare sé stessa: in mancanza di un’offerta alternativa europea, un dazio su Google o Amazon si tradurrebbe solo in un costo più alto per le imprese italiane ed europee.
Lo stesso contesto interno agli Stati Uniti merita attenzione. I dazi voluti da Trump sono parte di un disegno politico che ha un chiaro sottofondo redistributivo: ma al contrario. Le entrate che il governo raccoglierà grazie a queste nuove “tasse doganali” non provengono dall’estero. Non sono pagate da Bruxelles, Roma o Berlino. Le pagano cittadini e imprese americane. E saranno usate per coprire i tagli fiscali precedenti, quelli del famoso Big Beautiful Bill che ha beneficiato soprattutto i più ricchi.
A questo si aggiungerà un probabile effetto inflazionistico generalizzato, anch’esso socialmente distorto, perché colpirà prevalentemente le famiglie con reddito medio-basso.
Insomma, se l’obiettivo di Trump era proteggere l’economia nazionale, l’operazione appare quanto meno discutibile. Se l’obiettivo era segnare un punto elettorale, allora forse ha un senso — ma solo in termini di consenso politico interno. Di certo non in termini di efficienza economica.
In conclusione, sarebbe stato meglio un accordo che evitasse del tutto i dazi. Ma nel mondo reale, le dinamiche sono più complesse di un tweet. Gli effetti economici di questa scelta saranno distribuiti nel tempo e nello spazio, spesso in modo controintuitivo. Le perdite per l’Europa sembrano più contenute di quanto sbandierato da Trump e di quanto paventato da molti, a meno di una rincorsa americana al rialzo, guidata dal puntiglio di un leader incerto che creerebbe instabilità. Sul piano politico, invece, se l’Europa vuole giocare un ruolo da protagonista e impedire giochi pericolosi per tutti, dovrà prima dotarsi di una voce sola — e di leve reali con cui farla pesare.