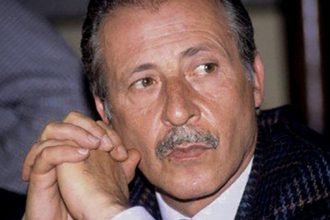Può capitare di trovare lati positivi, perché qualunque cosa accada, questa stagione vale tutta la fatica. E vale, naturalmente, un racconto
Si sa che l’estate è cambiata e comincia prima, e quindi capita che certi weekend metropolitani somiglino a un giorno d’agosto. C’è prima di tutto un fattore clima che muove le persone in un altro modo e in un altro senso, rispetto a trentaquarant’anni fa. Sono migrazioni, almeno queste non drammatiche: si comincia prima a parlare del caldo e delle mezze stagioni che non esistono più, solo che lo dicono gli scienziati prima di noi.
In tutto questo, rimane – come certifica OpenPolis – un trenta per cento di famiglie che non può permettersi le vacanze. L’unico sollievo è prendere un trenino da Cosenza a Paola, da Roma a Ostia, da San Donà a Jesolo o Caorle. Anche se questa percentuale – evviva! – sembra in diminuzione. Toccherebbe riscrivere film come Il sorpasso o Un sacco bello, perché nel frattempo la città in agosto si è animata, non è obbligatorio scappare, qualche amico si trova sempre, non mancano i rifornimenti. Non è più il deserto dei servizi, perfino gli uffici pubblici funzionano meglio, anche se buona parte del personale sta in ferie.
E può capitare di trovare un grosso grasso pomodoro o un’albicocca che sa di albicocca in una bancarella gestita con orario lungo da stranieri, quei posti che ora chiamano bangla: perché le regole sono chiare, anche se a noi ignote. Per cui agli asiatici va il settore “food”, agli egiziani i fiorai H24 (e non si capisce dove dormano), ai cinesi l’area oggetti/attrezzi/cartoleria, insomma nulla di deperibile.
E quindi si passa in rassegna una decina di ventilatori esposti anche sulla strada, da quelli tascabili agli enormi a misura d’uomo, a grandezza naturale, con la forza di pale eoliche. Questi posti diventano poli di attrazione per il quartiere, insieme naturalmente ai supermercati. Resta in vigore la teoria ZTL, per cui certi quartieri sono vuoti, e altri in agosto mantengono una vita propria, sufficiente e dignitosa.
Per esempio Roma ha una sua bellezza, che è quella del silenzio, del traffico che non c’è più, anche se in centro permangono gli ingorghi pedonali dei turisti. Ma quando il sole è imperdonabile, cerchi con lo sguardo un albero, e viene in mente la sindaca di Parigi che ha chiuso le strade per fare verde, e Stefano Mancuso che vorrebbe piantarne tanti per salvare la Terra (ma non tutti i suoi colleghi sono d’accordo).
Alla sera, ci sono più luci accese di una volta: quelli rimasti in città, per lavoro e solitudine, un tempo si affidavano a tossici camioncini che fornivano rosette e salsiccia come allo stadio, per placare la fame. Oggi qualche ristorante aperto c’è e stende il gazebo. Funzionano perfino infernali macchine che sfornano la pizza, e quello che in lontananza ti sembra un locale è solo una fiera di distributori automatici pronti ad appagare qualunque voglia.
Ci sono perfino quelli per la cannabis light, governo permettendo.
Viene quindi una certa nostalgia a pensare alle estati di 30 anni fa, almeno per chi le ha vissute. Perché allora l’estate in città era una sfida, con un certo grado di noia. E qui tornano in mente un paio di libri. Uno è firmato Rocco Carbone, scrittore reggino formatosi a Roma e Parigi, la cui storia bella con finale triste è raccontata da Emanuele Trevi nel libro “Due Vite”, che vinse lo “Strega” nel 2021.
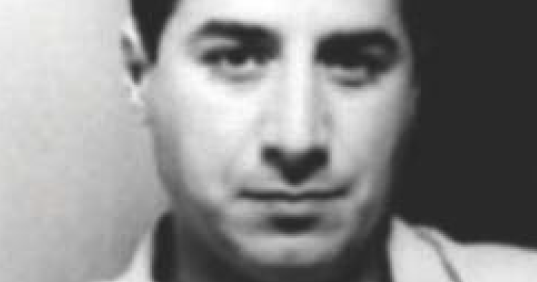
Il romanzo d’esordio di Carbone Agosto è appunto lo svolgimento stanco di un mese, un cronista di nera alle prese con una condanna: i giornali devono uscire tutti i giorni, e questo per fortuna accade anche oggi. La sonnolenta esistenza viene improvvisamente rotta da un temporale, che porta un’eccitazione infantile. E qui si ritorna al fattore clima ormai diventato decisivo, la metereopatia, i siti che oggi fanno migliaia di clic al giorno.
La pioggia a un certo punto viene invocata, come un tempo si faceva nelle processioni, a patto che non diventi tempesta e alluvione. La natura arbitro, anzi arbitra delle nostre esistenze.
Che poi l’estate non è uguale per tutti, perfino Francesco Guccini nella Canzone dei dodici mesi dedica solo due versi a luglio e due ad agosto, e agli altri il doppio. Come se fosse obbligatorio rallentare in estate, con certi eccessi solo italiani: le fabbriche e le scuole chiudono, le ferie per molti sono obbligate in quel certo periodo, e pazienza se tutto costa più caro, se gli ingorghi di Roma si trasferiscono a Ostia e Fregene, dove è impossibile che vengano pescate ogni giorno tutte quelle telline per le bruschette. Pazienza se i primi di agosto sono gli unici giorni di emergenza al porto di Villa San Giovanni: portano di default i proclami sul Ponte necessario, anche se l’anno scorso risulta un’attesa massima di tre ore, in un solo giorno. La propaganda non si cura dei numeri.
Ma qualunque cosa accada, l’estate vale tutta questa fatica, e vale naturalmente un racconto. Sempre a proposito di Guccini, c’è un’altra canzone che descrive l’ambivalenza dell’estate, che può diventare solitudine: Giorno d’estate, giorno fatto di vuoto/ Giorno di luce che non si spegnerà/ Sembra d’andare in un paese remoto/ Chissà se in fondo c’è la felicità.
E qui noi tutti ci misuriamo con le nostre individuali esistenze: c’è chi accoglie con sollievo la rarefazione dei rapporti: ci si vede di meno, molti partono e poi ci sarà il rito del racconto delle vacanze. Altri invece restano più soli: siamo un paese anziano, i nostri vecchi devono rimanere al fresco, e non vanno dimenticati. Anche cani e gatti, i famosi pets, hanno una loro dignità e soffrono per il caldo. Tocca pensare anche a loro.
I tg, diligenti, registrano tutto. Resta il pensiero del dopo. Perché l’estate porta cambiamenti: si aspetta la fine del ciclo scolastico di un figlio per cambiare casa o città. I diplomati devono scegliere la facoltà o pensare a un lavoro. Si ricomincia, all’improvviso da un’altra parte, si lasciano vecchi amici per trovarne dei nuovi. Oltre questo mese c’è il mistero, molto più del Capodanno: e qui torna in mente un altro romanzo di esordio, sempre di una reggina, la popolare scrittrice e editor Rosella Postorino, che poi si è formata in Liguria, a Siena, a Roma, mantenendo sempre un filo con la Calabria.
Ne L’estate che perdemmo Dio Postorino racconta un cambio di vita dopo una “sciagura”, con una partenza improvvisa per l’Altitalia, dove il fine è solo quello di “provare ad essere felice”. E questo, se permettete, non vale solo per l’estate.