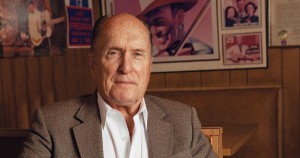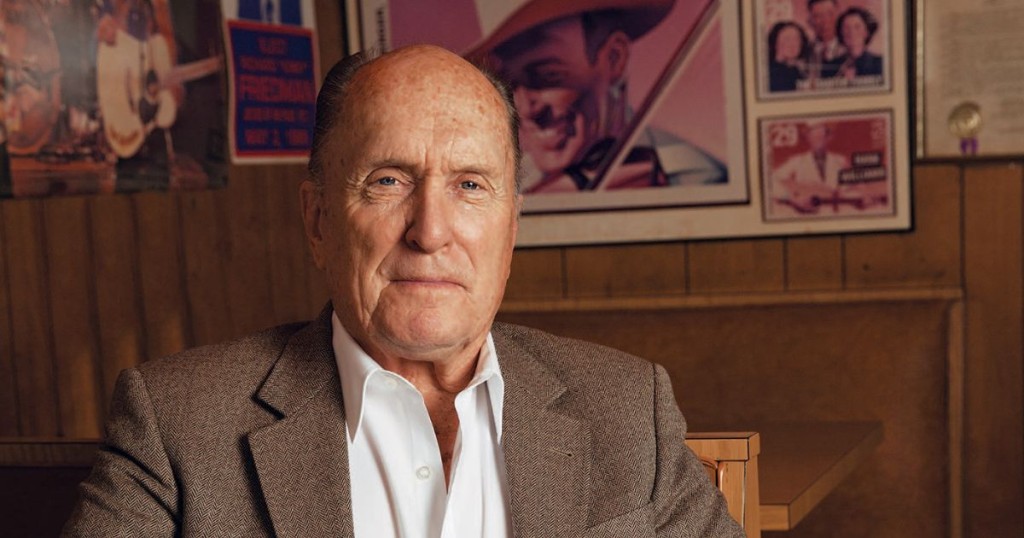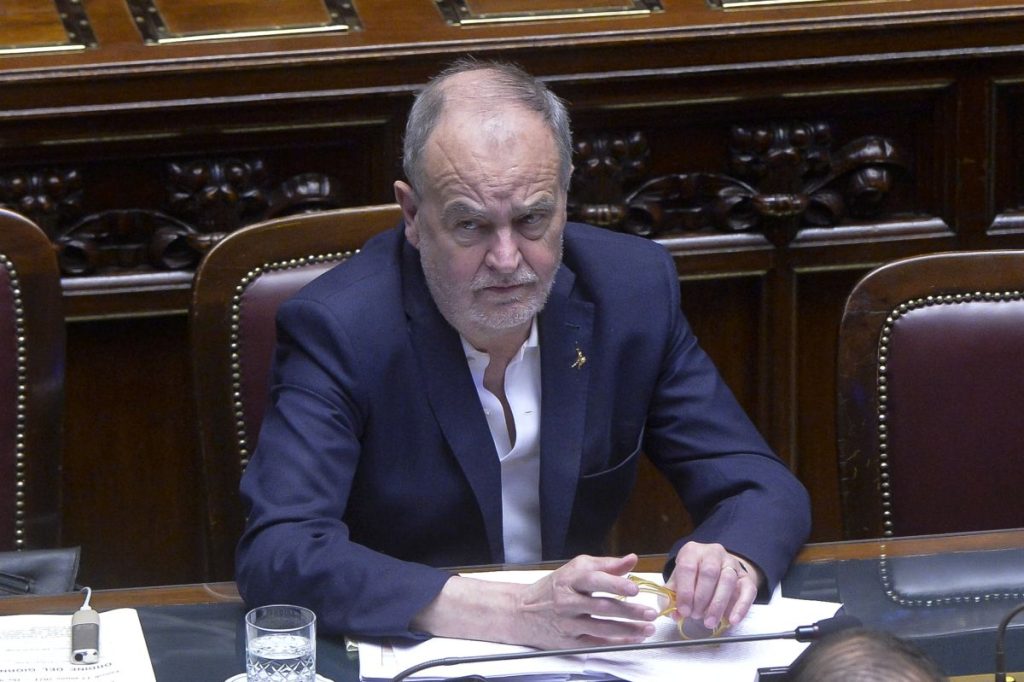Parole più competenti, più esplicite e più ultimative non avrebbe potuto pronunciare Sergio Mattarella, incontrando i vertici del Dap. Perché il Capo dello Stato non ha detto solo che i suicidi in carcere sono un problema drammatico che da troppo tempo si ripete e a cui occorre porre fine immediatamente; che il sovraffollamento è insostenibile; che le strutture degli istituti di pena sono bisognose di ristrutturazioni radicali e urgenti; che la carenza di operatori e di competenze rende difficile perfino l’accesso alle cure sanitarie per i detenuti. Mattarella ha detto soprattutto che il carcere non può essere concepito unicamente come luogo di custodia, ma deve includere ambienti destinati alla socialità, all’affettività, alla progettualità del trattamento.
Quest’ultima affermazione merita di sciogliere un equivoco, che altrimenti rischia di trasformare il rapporto tra le istituzioni coinvolte in un dialogo tra sordi. Il Presidente della Repubblica parlava ai vertici del Sistema penitenziario, gli stessi che qualche mese fa hanno emanato una circolare che dispone tassativamente la chiusura delle porte delle celle in tutti i reparti cosiddetti di alta sicurezza, dove sono custoditi diecimila degli oltre sessantamila detenuti totali. Si tratta spesso di persone che hanno scontato anni di carcere duro, il cosiddetto 41 bis, che hanno già dieci, venti e talvolta trenta anni di custodia alle spalle. Per i nove decimi di loro, in assenza di qualunque attività rieducativa, la socialità consisteva nel poter sostare per ore nel corridoio su cui danno le porte delle celle. La circolare li ha trasformati in morti viventi, reclusi per i quattro quinti della giornata in celle anguste e sovraffollate, dove la malattia psichiatrica non è più un accidente ma l’esito conseguenziale del trattamento penitenziario.
Si tratta di un fenomeno che risponde a una precisa strategia custodiale. Che ha visto ridurre negli ultimi due anni le esperienze di sorveglianza dinamica, in ragione del principio per cui chi non partecipa ad attività rieducative resta in cella. E poiché le attività rieducative coinvolgono una percentuale molto minoritaria dei detenuti, il carcere è per i nove decimi di loro uno strumento consapevole di punizione corporale e psichica.
Occorre uscire dall’ipocrisia che circonda il dibattito, e le parole del capo dello Stato ne offrono l’occasione. È ridicolo indignarsi per il numero di suicidi che non accenna a diminuire se il carcere è concepito come un modo per indurre i detenuti a considerare la morte come un’exit strategy a una vita insostenibile.
Il sistema penitenziario italiano è il rovesciamento e la negazione del principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione, che non solo prescrive la rieducazione quale obiettivo della pena, ma soprattutto, sconfessa l’idea che la rieducazione coincida con il castigo, cioè si produca come effetto della punizione. La prassi dimostra l’esatto contrario.
1 Lug, 2025
Carceri, l’equivoco di un sistema fatto solo per punire

Una voce delle notizie: da oggi sempre con te!
Accedi a contenuti esclusivi
Potrebbe interessarti
Le rubriche
Mimì
Sport
Primo piano
Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.