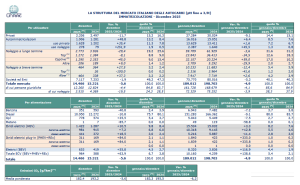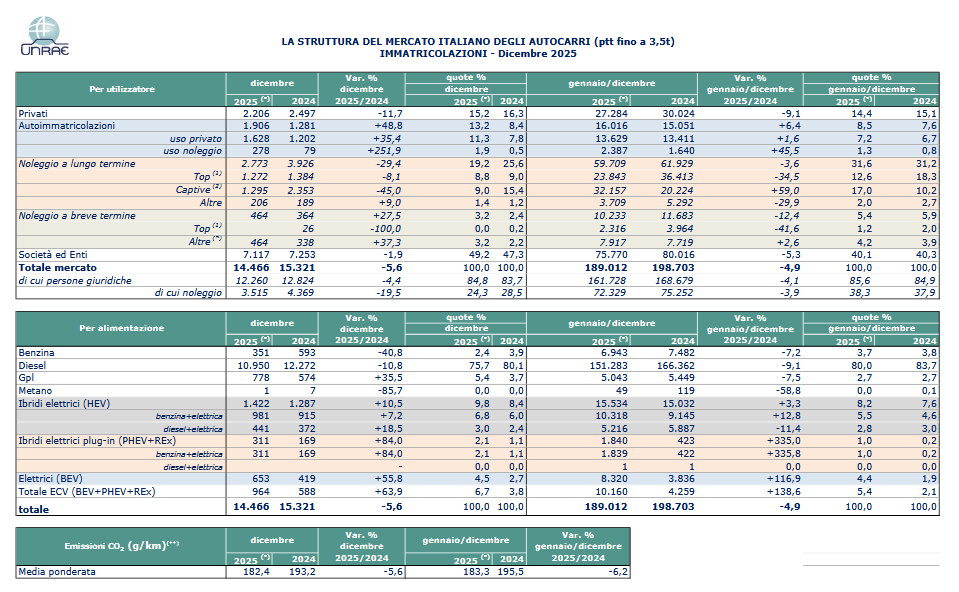Lo sgombero definitivo del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una parabola politica e culturale che ha attraversato mezzo secolo di storia milanese. Un epilogo che invita a riflettere non tanto sulla cronaca giudiziaria, quanto sul fallimento di un modello che, pur avendo avuto numerose occasioni di regolarizzazione e dialogo istituzionale, ha preferito coltivare un’identità antagonista sempre più autoreferenziale e distante dal tessuto urbano contemporaneo.
La storia del Leoncavallo inizia nel 1975, quando l’occupazione di via Mancinelli intercettava istanze reali di una periferia operaia priva di servizi. Ma già dalla tragica morte di Fausto e Iaio nel 1978, il centro sociale ha iniziato a costruirsi un’aura mitologica che, se da un lato ne ha alimentato la forza identitaria, dall’altro ne ha progressivamente cristallizzato le modalità operative. Fu allora che nacque l’associazione delle “Mamme antifasciste del Leoncavallo”: un soggetto giuridico col quale far in qualche modo dialogare le istituzioni, ma con una denominazione che, con involontaria ironia, trasformava la maternità in militanza politica permanente in una specie di retorica di “antifascismo genetico”.Il tentato sgombero del 16 agosto 1989 e la resistenza violenta che ne seguì rappresentarono l’apice di questa fase eroica, ma anche l’inizio di una frattura interna tra chi cercava il dialogo con le istituzioni e chi preferiva mantenere una posizione di antagonismo puro.
Il sindaco leghista Marco Formentini, eletto nel 1993 con la promessa di sgomberare il Leoncavallo, paradossalmente ne provocò il trasferimento prima in via Salomone e poi, nel settembre 1994, nell’ex cartiera di via Watteau. Fu in questo periodo che nacquero le “tute bianche”, in risposta alla minaccia di Formentini che solo “spettri si sarebbero aggirati per la città”. Ma dietro il simbolismo c’era una svolta: la scelta della non-violenza, teorizzata nella Carta di Milano del 1998, che segnava l’abbandono delle pratiche più radicali a favore di una strategia di “disobbedienza civile” .
L’entrismo in Rifondazione Comunista, con l’elezione di Daniele Farina prima in Consiglio comunale (2001-2006) e poi alla Camera (2006-2008), rappresentò il tentativo più compiuto di istituzionalizzazione. Un percorso che sembrava trovare il suo compimento naturale durante l’amministrazione di Giuliano Pisapia, quando nel 2011 venne aperto un tavolo per la regolarizzazione dello spazio. La vicesindaca Lucia De Cesaris lavorò a una permuta di immobili che avrebbe dovuto chiudere definitivamente la questione. Ma l’ostruzionismo del centrodestra in Consiglio comunale, unito alle resistenze interne dello stesso centro sociale, fece naufragare l’accordo.
È significativo che anche il sindaco di centrodestra Gabriele Albertini avesse dichiarato di voler essere “il sindaco di tutti, da Tronchetti Provera al Leoncavallo”, e che la giunta Moratti avesse ipotizzato la costituzione del centro sociale in Fondazione. Persino Vittorio Sgarbi, nel 2006, aveva definito i murales del Leoncavallo “la Cappella Sistina della contemporaneità”. Ma questi tentativi di dialogo si sono sempre scontrati con una duplice resistenza: quella ideologica del centrodestra più intransigente e quella identitaria del centro sociale stesso, incapace di abbandonare completamente la sua natura antagonista.
Beppe Sala aveva riaperto le trattative, dichiarandosi disponibile a “tornare al tavolo” per una regolarizzazione. Ma anche questa volta il processo si è arenato, fino alla sentenza della Corte d’Appello che ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire 3 milioni di euro alla proprietà Cabassi per il mancato sgombero. Una sentenza che ha precipitato gli eventi, rendendo inevitabile l’intervento delle forze dell’ordine.
Il paradosso del Leoncavallo sta proprio in questa sua incapacità di evolversi: nato come risposta a bisogni concreti di una periferia operaia, alla mancanza di aggregazioni giovanili urbane, agli stati di abbandono edilizio, ha progressivamente sostituito la progettualità sociale con una militanza ideologica sempre più astratta. La retorica del “qua siamo e qua restiamo” ha finito per prevalere su qualsiasi proposta costruttiva, trasformando quello che poteva essere un laboratorio di innovazione sociale in un fortino dell’antagonismo fine a se stesso.
Milano nel frattempo è cambiata profondamente. La città post-industriale ha sviluppato nuove forme di aggregazione giovanile, nuovi linguaggi culturali, nuove modalità di partecipazione civica che prescindono completamente dal modello dei centri sociali occupati. I giovani milanesi di oggi trovano i loro spazi di espressione negli hub creativi, negli spazi di coworking, nelle iniziative di rigenerazione urbana partecipata. Il Leoncavallo è rimasto ancorato a un immaginario novecentesco, incapace di intercettare le trasformazioni della metropoli contemporanea.
C’è poi la questione della legalità, che non può essere elusa. Per cinquant’anni il Leoncavallo ha operato in una zona grigia, tollerata dalle amministrazioni di ogni colore politico ma mai realmente legittimata. Questa ambiguità ha finito per diventare un alibi: il compiacimento per la propria clandestinità ha sostituito la ricerca di soluzioni praticabili. L’occupazione abusiva è diventata un valore in sé, un marchio identitario irrinunciabile anche quando esistevano alternative concrete.
L’epilogo di via Watteau chiude simbolicamente un’epoca. Non quella dei movimenti sociali, che continueranno a esistere in forme diverse, ma quella di un certo antagonismo autoreferenziale che ha confuso la testimonianza con l’efficacia politica. Il Leoncavallo aveva tutte le carte per trasformarsi in un’istituzione culturale riconosciuta, mantenendo la sua autonomia critica. Ha preferito rimanere un simbolo di opposizione perpetua, finendo per diventare anacronistico.
La Milano del 2025 non ha più bisogno di fortini antagonisti ma di spazi aperti di confronto e progettualità. Il tessuto urbano richiede inclusione, non separazione; dialogo, non contrapposizione ideologica. Il Leoncavallo avrebbe potuto essere parte di questa trasformazione. Ha scelto di rimanere fuori dalla storia, coltivando un mito sotterraneo che oggi appare definitivamente esaurito. Lo sgombero non è quindi solo la fine di un’occupazione, ma la certificazione di un tramonto politico e culturale che meriterebbe una riflessione più profonda da parte di chi ancora crede nel valore dell’impegno sociale.