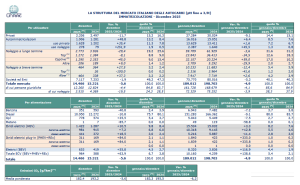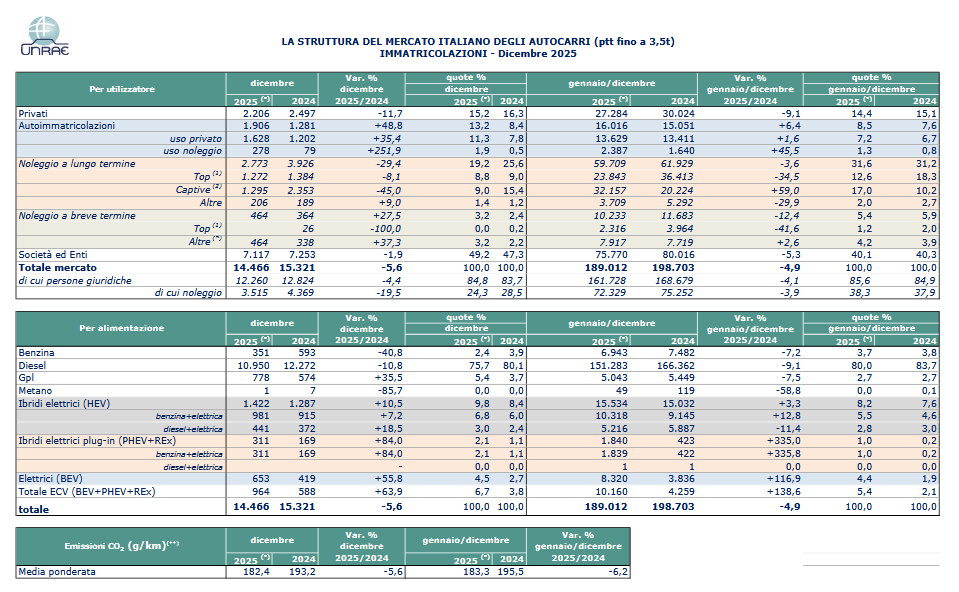I vaccini, da terreno di approfondimento scientifico, di pubblicazioni di lavori inerenti le tecnologie per la loro messa a punto o di confronti sulla base di studi relativi alla loro sicurezza ed efficacia, sono diventati un terreno di scontro politico anche all’interno della maggioranza di governo. Il sasso nello stagno sono state le nomine ministeriali del Nitag (il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni) effettuate agli inizi di agosto dal titolare del dicastero della Salute, Orazio Schillaci.
Nomine travolte dalle critiche della comunità scientifica nazionale per la presenza, nel gruppo, di almeno due profili scettici sui vaccini: il pediatra Eugenio Serravalle e l’ematologo Paolo Bellavite, che in passato hanno assunto posizioni critiche nei confronti dei vaccini, in particolare quelli contro Sars-CoV-2, agente del Covid. Contro di loro c’è stata una presa di posizione netta anche da parte della Sip, la Società Italiana di Pediatria. A Ferragosto il ministro Schillaci ha dunque deciso, in solitaria, di fare marcia indietro e revocare le nomine, ricevendo il plauso e i ringraziamenti pubblici anche di Rino Agostiniani, presidente della Sip.
Ma proprio quando la polemica sembrava conclusa, nella serata del 16 agosto è arrivata la doccia gelata del retroscena che attribuirebbe alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni un disappunto per una decisione (quella della revoca) “non concordata” da parte di un suo ministro. Del resto è stato lo stesso Paolo Bellavite, in un’intervista a Repubblica, a sostenere che «con la revoca delle nomine è stato danneggiato il pluralismo».
«Un aspetto e una definizione che attengono più alla cultura politica, alla filosofia e all’arte che a quella scientifica»; così Silvio Garattini, farmacologo, oncologo e ricercatore italiano di fama internazionale, noto soprattutto per essere il fondatore e a lungo direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Bergamo, diventato sotto la sua guida uno dei centri di ricerca più importanti a livello internazionale ed esempio di trasparenza e di etica in campo biomedico.
Professor Garattini, cosa si intende per pluralismo in campo scientifico?
«È un termine improprio: se pure volessimo interpretarlo secondo l’attinenza al caso specifico delle nomine in seno al gruppo consultivo del Nitag, si può solo pensare che l’identificazione dei suoi componenti debba rispondere a profili di ricercatori provenienti anche da altre nazioni o da varie scuole di medicina, ma non certo essere relativa alla rappresentazione di posizioni basate su opinioni scettiche contro i vaccini o sostenitrici di filosofie alternative come l’omeopatia.
La scienza, il suo metodo di lavoro in tutti i campi, non solo quello medico, evolve con un metodo fatto di ipotesi, osservazioni, studi e approfondimenti per dimostrare o confutare ciò che si è ipotizzato. Mentre l’arte e la filosofia si confrontano con il mondo delle opinioni, in campo scientifico si procede per dimostrazioni, pubblicazioni, lavori e studi sottoposti alla verifica di organismi internazionali e alla cosiddetta revisione tra pari».
C’è chi sostiene, anche tra i camici bianchi, che i vaccini possono procurare danni a un soggetto sano. Col Covid poi questo scetticismo si è ingigantito per l’uso innovativo della tecnologia a Rna messaggero…
«Guardi, quando alla fine del ’700 fu messo a punto dal medico inglese Edward Jenner il vaccino contro il vaiolo con virus attenuato, la profilassi si diffuse rapidamente in Europa e nel mondo, portando a una drastica riduzione dei casi di vaiolo e, infine, all’eradicazione della malattia nel 1980.
In Italia la vaccinazione antivaiolosa fu resa obbligatoria nel 1888, ma molti evitarono di vaccinare i propri figli e ancora oggi vediamo persone che per tutta la vita hanno convissuto con una paralisi infantile a causa di questa paura. Oggi, a causa dell’emergere di scetticismi antiscientifici, vediamo riemergere casi di vaiolo, piccole epidemie di morbillo e di altre patologie considerate eradicate. Tutto questo è causato da una regressione della nostra società e dalla mancanza di una cultura scientifica diffusa».
Come rimediare?
«Bisogna esprimere una volontà politica a coltivare la scienza e la cultura scientifica sin dalle scuole primarie. Non esistono in Italia programmi scolastici orientati alla scienza e alla cultura scientifica, e di questo paghiamo un prezzo come comunità, ancora più pesante a causa del fatto che questo vuoto viene colmato da strumenti potenti ma non verificabili nella loro attendibilità ed autorevolezza, come internet e i social. A subirne le conseguenze sono soprattutto persone che non hanno i mezzi per capire e decifrare ciò che viene loro riferito».
Quando le fonti sono medici scettici come si fa?
«Si effettua un controllo sulle fonti. Spesso il nodo è la comunicazione dei dati. Anche durante la pandemia da Sars-CoV-2 il fatto che ci fosse un agente infettivo nuovo ha generato una grande confusione e un grave vulnus nella comunicazione, quasi sempre fuori bersaglio e fuorviante.
Quando il governo negli anni del Covid assumeva decisioni poi riviste in corso d’opera, avrebbe dovuto spiegare nei dettagli e in maniera comprensibile le ragioni delle scelte».
Un farmaco del resto non è mai esente da rischi…
«Esatto. Un soggetto a rischio in oncologia, ad esempio, si definisce tale in base a una probabilità più alta di incorrere in alcune lesioni tumorali in base, ad esempio, al consumo di alcool o fumo di sigarette. Ma occorre spiegare che chi è più a rischio potrebbe non ammalarsi mai e chi è meno a rischio potrebbe incorrere in un cancro anche conducendo una vita sanissima. La biologia e la medicina si basano su probabilità, non su certezze».
Quanto è stato importante il vaccino del Covid?
«Il vaccino basato su Rna è stato messo a punto in tempi rapidissimi grazie al fatto che gli studi erano in corso da vent’anni. È stato un grande vantaggio per l’umanità. In sua assenza avremmo contato centinaia di migliaia di vittime in più».
C’è chi punta l’indice sugli interessi di mercato e le pressioni delle case farmaceutiche…
«Anche questo aspetto esiste, la pressione commerciale viene esercitata in tutti gli aspetti della nostra vita. Basta saper esercitare i controlli necessari con rigore e metodo scientifico. È sempre la scienza il faro con cui orientare le nostre posizioni. Anche la scienza può essere confutata, ma va fatto con lo stesso metodo. Per questo in organismi di controllo e indirizzo devono esserci personalità scientifiche autorevoli, credibili e trasparenti, badando anche ai conflitti di interesse».
Quindi in commissioni come il Nitag?
«Collaborazioni e consulenze per l’industria farmaceutica vanno evitate. Evitare i conflitti di interesse dovrebbe essere la regola. Del resto è scritto anche nel regolamento del Comitato, ma prima della revoca nessuno sembra aver dato peso a questo aspetto.
In Italia manca una cultura condivisa su questo tema. Basta vedere le farmacie, diventate supermercati, quando potrebbero essere punti utili di informazione ed educazione. Oggi è effettivamente difficile trovare studi scientifici in cui non emerga qualche conflitto di interesse, e ciò pregiudica la credibilità del sistema della comunicazione scientifica».
Manca dunque un’informazione indipendente?
«È carente, ma gli scienziati autorevoli, competenti e senza conflitti esistono. Vanno premiati».
Spesso però i finanziamenti privati sono irrinunciabili per la ricerca…
«È vero, ma serve un sistema di regole che renda trasparenti i processi di finanziamento della ricerca pubblica da parte dei privati. Sono poi i risultati, quasi sempre misurabili, a fare la differenza».
Il “Mario Negri” come esempio di trasparenza?
«Noi pubblichiamo tutti i risultati delle nostre ricerche e rinunciamo ai brevetti, che servono a incentivare gli aspetti commerciali. Ma la ricerca indipendente ha bisogno di risorse: parliamo di miliardi l’anno per essere al passo con i grandi Paesi Ocse. La mancanza di fondi spinge verso il sostegno delle industrie private».
In passato la legge assegnava il 5% delle spese pubblicitarie farmaceutiche per ricerche indipendenti Aifa. È ancora così?
«Quelle risorse sono state progressivamente ridotte quasi a zero. La ricerca indipendente oggi è quasi scomparsa, mentre gli studi clinici arrivano a costare milioni di euro. Basterebbe avviare una revisione sistematica del prontuario farmaceutico per ricavare risorse da investire in ricerca indipendente.
Un analogo discorso servirebbe per validare i nuovi farmaci e considerarli innovativi. Tutto ruota attorno a questi strumenti di trasparenza, ma da qui a mettere in discussione la validità dei vaccini c’è un abisso. I vaccini sono stati e restano una delle principali conquiste dell’umanità».