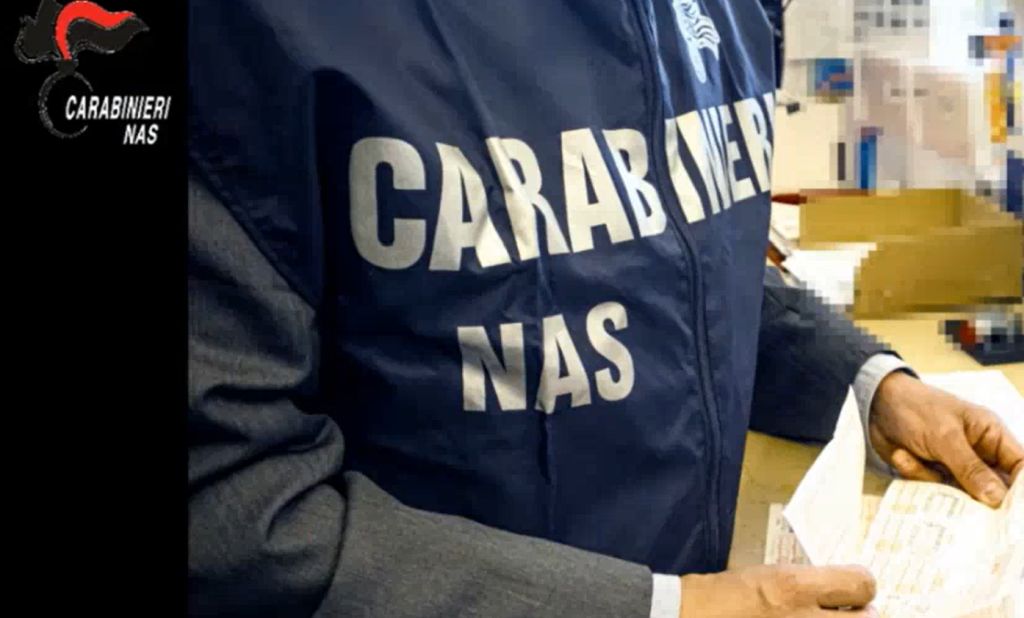di LIDIA MARASSI
Ogni anno, circa 4 milioni di bambine e ragazze nel mondo rischiano di subire una mutilazione genitale femminile. Per mutilazioni genitali femminili (MGF) si intende qualunque intervento che altera o danneggia i genitali esterni femminili per motivi non medici, come escissione, infibulazione, amputazioni parziali o ricuciture. Secondo le stime dell’UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono oltre 230 milioni le donne che convivono oggi con le conseguenze di questa pratica. Di queste, circa 144 milioni si trovano in Africa. In particolare, nei Paesi del Corno d’Africa – come Somalia (98%), Guinea (97%) e Gibuti (93%) – la diffusione è quasi totale tra le donne tra i 15 e i 49 anni e, soprattutto in molte aree rurali, questa tradizione resiste nonostante le leggi che la vietano e le campagne internazionali di sensibilizzazione.
Le ragioni di questo fenomeno sono complesse e profondamente radicate in norme culturali, sociali e religiose. In molte comunità, la mutilazione è considerata un rito di passaggio per le giovani, un processo che “prepara” la bambina al ruolo sociale di moglie e madre e viene spesso associata a ideali di purezza, modestia e controllo della sessualità femminile. Secondo queste logiche, una donna “pura” è una donna che non prova desiderio e che è stata “modellata” per rispondere a esigenze societarie.
Le MGF riguardano soprattutto gruppi etnici specifici in cui il mancato accettare è sinonimo di esclusione e chi rifiuta può subire pressioni o essere considerata inadeguata al matrimonio. Queste pratiche si accompagnano infatti inevitabilmente ad una pressione sociale interiorizzata che si trasmette anche tra generazioni di donne, secondo un graduale processo di normalizzazione.
A questo si aggiungono motivazioni religiose che, seppur spesso basate su interpretazioni distorte, consolidano la percezione che la mutilazione sia una pratica necessaria. Pur consapevoli dei rischi, molte donne sentono di non avere scelta da un punto di vista socio-culturale. Le MGF vengono praticate spesso durante l’infanzia, senza anestesia e con strumenti non sterilizzati, con conseguenze fisiche (come emorragie, infezioni, infertilità, complicanze durante il parto) e psicologiche permanenti per chi le subisce.
Dove è consentita, la medicalizzazione della MGF – affidata a professionisti sanitari – legittima la mutilazione come più “sicura”, ma non meno traumatica. Invece, dove la legge proibisce la pratica, la mutilazione spesso continua in clandestinità.
Sebbene il Protocollo di Maputo, adottato dall’Unione Africana nel 2003 e ratificato da 42 Stati, condanni formalmente le pratiche tradizionali lesive dell’integrità delle donne, tuttavia, la sua applicazione resta debole, sotto il peso delle pressioni sociali ed in assenza di enforcement autentico e sensibilizzazione comunitaria. Su quest’ultimo punto i numeri, negli ultimi anni, sembrano mostrare un leggero calo in alcune zone, anche grazie a campagne di sensibilizzazione e all’azione di ONG internazionali.
Nonostante la complessità del fenomeno, infatti, esistono realtà che lavorano da anni per contrastarlo. ONG come ActionAid, Amref, Plan International, ma anche agenzie delle Nazioni Unite, come l’UNFPA e l’UNICEF, collaborano con governi e comunità locali per promuovere un cambiamento che sia soprattutto culturale, e non solo giuridico. In Kenya, soprattutto, si è effettivamente assistito a un calo significativo di queste pratiche, e la percentuale tra le giovani è scesa significativamente (da circa il 41% negli anni ‘80 all’11–15% oggi). Tuttavia, il declino non è omogeneo, con uno squilibrio evidente tra i diversi paesi africani. Risulta infatti impossibile parlare di “Africa” come blocco unico, e le differenze tra paesi, regioni, contesti urbani e rurali sono profonde.
Se in Africa le donne affrontano MGF spesso in condizioni di fragilità istituzionale, in Occidente le sopravvissute migranti faticano a trovare tutele adeguate, consapevolezza professionale e assistenza specifica nei sistemi sanitari dei paesi ospitanti. In Italia si stima che tra 61.000 e 80.000 donne presenti nel Paese siano sopravvissute a MGF. Il progetto europeo “AFTER” (coordinato anche da ActionAid) mira a sensibilizzare comunità migranti, formare operatori sanitari ed educare le seconde generazioni sui diritti riproduttivi.
Nonostante la loro storicizzazione, le mutilazioni genitali femminili non sono considerabili come una “pratica tradizionale”, ma piuttosto come una violazione dei diritti umani. Sono la manifestazione più estrema di un sistema che pretende di gestire il corpo delle donne, trasformandolo in simbolo, merce e, infine, tabù. Non si tratta di un problema geograficamente localizzato, ma pratiche di controllo sociale e sessuale. Interrogarci sull’esistenza di queste pratiche significa domandarci – ovunque – in che misura la libertà femminile viene ancora condizionata, giudicata e limitata. La lotta contro la mutilazione non è pertanto solo un problema relegato a una particolare area, ma un nodo universale che riguarda il corpo, l’autodeterminazione e la possibilità di crescere senza violenza.