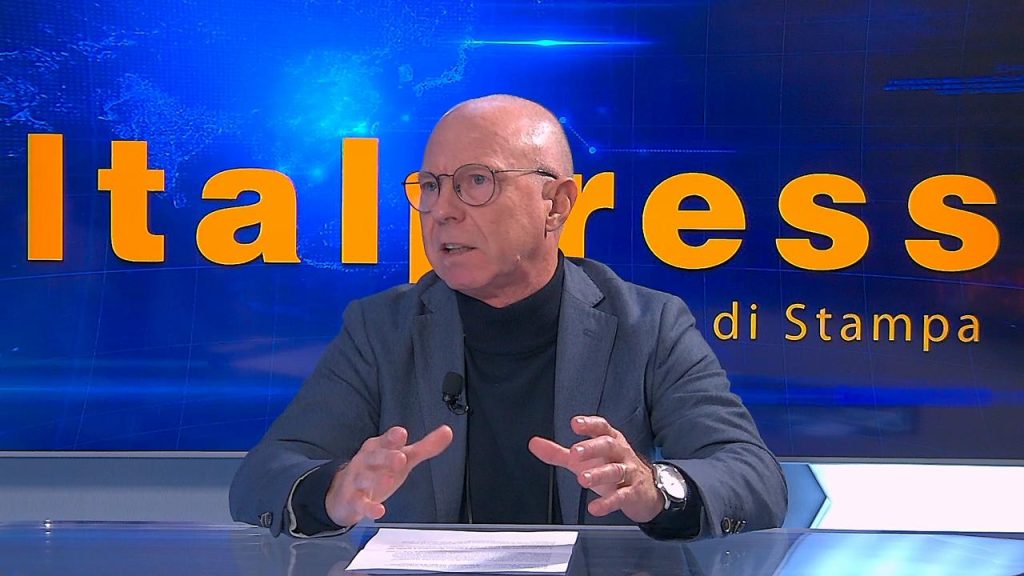Lo storico Franco Cardini parla di Macron e della sua decisione di riconoscere lo Stato di Palestina, scelta che porta sotto i riflettori gli eccessi d’Israele a Gaza
Nel cuore di un’Europa smarrita, tra crisi geopolitiche e identità in cerca di senso, la decisione del presidente Emmanuel Macron di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina riaccende un dibattito antico, mai sopito. È un gesto di politica estera o un atto morale? Una sfida all’asse atlantico o il riaffiorare di una vocazione mediterranea?
Per comprendere le radici storiche e le implicazioni simboliche di questa scelta, abbiamo chiesto a Franco Cardini — storico delle crociate, acuto lettore del Medio Oriente e della storia d’Europa — di farci da guida tra memoria, realpolitik e destino.
Professor Cardini, la decisione del presidente Macron di riconoscere lo Stato di Palestina arriva in un momento di profonda tensione mediorientale e di crescente isolamento diplomatico d’Israele in certi ambienti europei. Da storico delle crociate e delle relazioni tra Islam e Cristianità, ritiene che questo gesto della Francia sia una svolta reale o un atto simbolico nel solco della sua tradizione diplomatica?
«Devo fare una premessa: non ho una particolare simpatia e stima nei confronti di Macron e non approvo la sua politica. Detto questo, devo dire che a differenza di altri paesi europei, compreso il nostro e mi riferisco alle scelte presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che pure stimo, mi sembra che il presidente francese abbia fatto un gesto importante. Nonostante la mattanza di Gaza e le proteste, Netanyahu è andato avanti sostenuto dalla popolazione ebrea dello Stato di Israele. Gli inviti che gli sono stati rivolti da tutto il mondo non lo hanno fermato. Per molti quello di Macron può apparire come un gesto avventato, se si pensa alle conseguenze. Ma “avventato” non vuol dire che non sia stato giusto, anzi. Vuol dire che sul piano tattico e della copertura diplomatica non è stato adeguatamente preparato».
Qualcuno sostiene che prima di riconoscere la Palestina, Macron doveva dichiarare criminale ciò che fa Israele, perché «è più facile riconoscere uno Stato che non esiste che fermare un genocidio».
«Tutto questo linguaggio è stato usato. Chi parla di crimine e di genocidio sa che sta usando una parola grossa. Non so se si possa configurare come tale ma certamente stiamo parlando di una strage continuata, di una popolazione progressivamente eliminata per risolvere in questo modo il problema dei due popoli e due Stati. Persino il governo italiano, sempre molto timido, ha alzato la voce. Macron ha pensato che fosse necessario un gesto di rottura per far sì che la violenza contro uno Stato legittimamente riconosciuto mobiliti la comunità mondiale».
Nel secolo lungo della questione palestinese, la narrativa occidentale ha oscillato tra colpa e solidarietà. In che modo, a suo avviso, la storia coloniale della Francia e il suo passato pesano oggi su scelte come questa?
«Certamente può aver pesato. Ma bisogna vedere in che direzione. La Francia ha qualcosa da farsi perdonare dal mondo arabo ma non è stata l’unica nazione ad esercitare in modo criminale la sua politica coloniale. La comunità internazionale non può più permettere quello che sta accadendo in Palestina. Sono state decise sanzioni per molto meno. Pensi alla Russia, per non parlare dell’Iran che è stato bombardato ma ancora non riusciamo a capire se può fare o no la bomba nucleare. Il primo ministro israeliano si basa su due elementi. Il primo: sa che se vorrà proseguire la sua politica criminale avrà sempre gli Stati Uniti dalla sua parte. Il secondo è l’abuso che all’interno del mondo etico e culturale si sta facendo del rispetto più che giustificato che tutto il mondo deve a Israele come erede primigenia delle vittime della Shoah. Un uso, mi faccia dire, di una bassezza inaudita. Se altri Stati faranno come Macron, la violenza contro il gruppo etnico culturale palestinese diventerà un crimine contro uno stato formalmente riconosciuto: Macron non è una bianca verginella, non ha sciolto tutti i suoi nodi di politica estera e di politica sociale, al contrario è seduto su una poltrona di spine. Il suo è un gesto, per così dire di pokeristica diplomatica».
In molti evocano, nel riconoscimento della Palestina, un gesto tardivo di “giustizia storica”. Ma può la storia essere corretta da atti politici, o rischiamo — come direbbe Benedetto Croce — di trasformare la storia in tribunale invece che in comprensione?
«La storia non è un tribunale. È il tentativo di comprendere le meccaniche tra gli esseri umani e il pianeta in cui vivono. Non giudica, non è una lavagna divisa in due, da una parte i buoni dall’altra i cattivi. Niente di tutto questo. C’è un governo che ha scelto la via della strage nei confronti di un gruppo etnico, un gruppo che gli impedisce di raggiungere l’obiettivo del movimento sionista, lo stesso movimento che ha fondato uno Stato e lo ha fatto diventare uno Stato confessionale. Non era esclusivamente ebraico, lo è diventato. La verità è che si sta rimodellando il Medio e il Vicino Oriente per dare spazio al Grande Israele, un disegno già accettato dai Paesi arabi del Golfo».
Macron, che ambisce a un'”autonomia strategica” europea, può secondo lei aver scelto la causa palestinese come strumento per riattivare un protagonismo francese post-gaullista sulla scena internazionale?
«C’è molto protagonismo, certo. Un uso della storia ormai abituale. Ma c’era, fatti i dovuti distinguo, protagonismo anche nell’atteggiamento di Winston Churchill quando si schierò contro i trattati di Monaco. Aveva ragione o no a stigmatizzarli, a sostenere che erano un regalo a Hitler? Quanta vanità c’era in tutto questo? Vogliamo fare il processo etico ieri a Churchill e ora a Macron? Fino a ieri i G7 erano in linea con la forza reale che sta governando il mondo, dalla parte delle decisioni prese in prima istanza dagli Usa e dal suo alleato di ferro Israele».
Professore, c’è una dimensione culturale e simbolica del conflitto israelo-palestinese. Qual è, secondo lei, il ruolo dell’intellettuale europeo oggi, in questo scenario di guerre “mediatizzate”?
«Io credo, ma forse mi illudo, che il ruolo degli studiosi, preferisco definirli così, sia garantire finché è possibile il mantenimento e il ristabilimento della pace. Tutti gli operatori intellettuali devono unirsi per garantire la pace. Tutti devono fare la loro parte. Se io non lo facessi tradirei la mia stessa esistenza».
Ecco, il punto professore è proprio questo: la scelta di Macron favorirà la pace?
«Ci sono dei gesti politici che allontanano la pace ma se il costo di questa pace è la più rapida eliminazione dei palestinesi e il loro azzeramento, allora io dico no. Non è opportuno fare la pace. Ci sono Stati che oggi tacciono non perché approvano l’operato di Netanyahu ma perché non vogliono toccare un problema che è storico ma anche morale. Temono che qualcuno un giorno potrebbe accusarli di anti-sionismo e di anti-semitismo. Se Macron avesse dei seguaci si aprirebbe un dibattito. Senza fare questo passo noi continueremo a renderci complici di quello che succede a Gaza. E io sono stufo come cittadino, come insegnante e come padre di famiglia. E dunque non posso che approvare, con la morte nel cuore, perché come le ho detto non nutro particolare simpatia per lui, la scelta di Macron. Se altri governi lo seguissero avrebbe maggiori possibilità di successo di quanto ne avrà se resterà isolato».