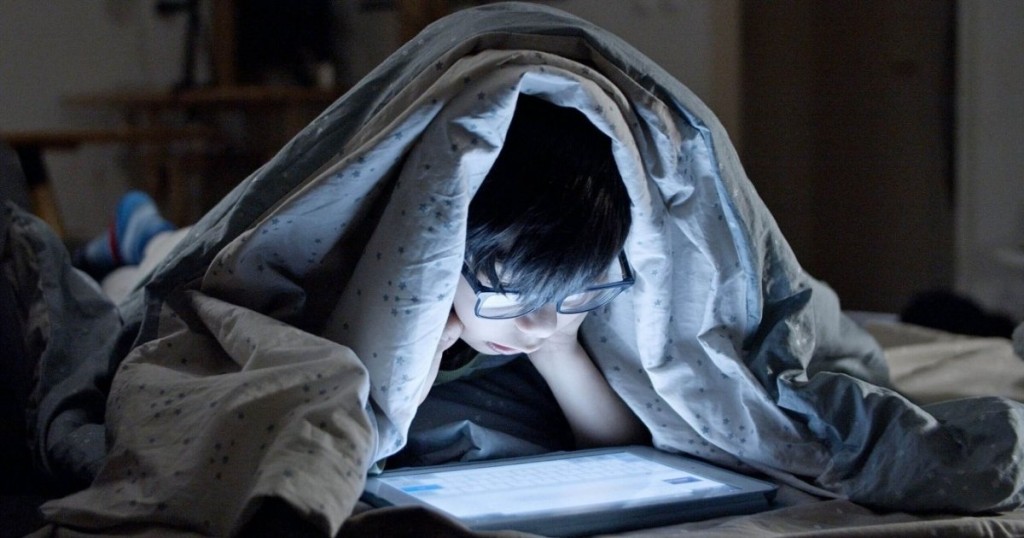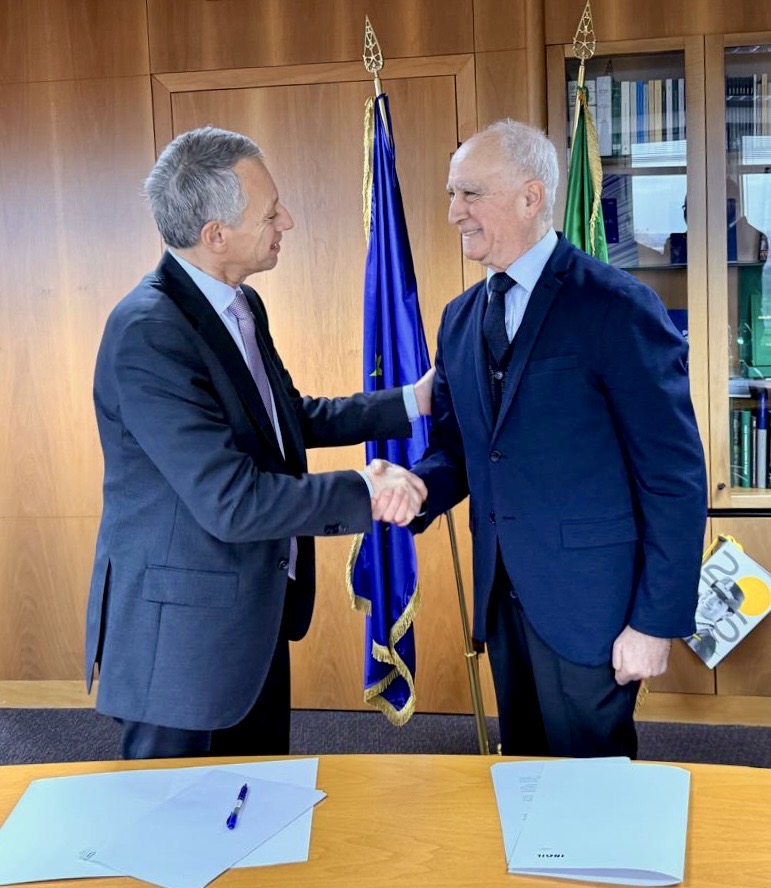Strategicamente potrebbe aspettare un dietrofront americano. Tatticamente, se unita, avrebbe una potenza economica agli Usa. Pro e contro
LA TATTICA: Keep calm o maxidazi
«Preferiamo una soluzione negoziata». Il day after dell’Unione Europea – scandito dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – rispetto alla rinnovata offensiva protezionista americana è di cautela. «Dobbiamo essere pronti a tutti gli esiti, incluse, se necessario, misure ben ponderate e proporzionate per ristabilire l’equilibrio nella nostra relazione transatlantica. Le nostre misure di riequilibrio su acciaio e alluminio sono sospese fino all’inizio di agosto e oggi la Commissione sta condividendo con gli Stati membri la proposta per la seconda lista di beni, che copre circa 72 miliardi di euro di importazioni dagli Usa. Gli Stati membri avranno ora modo di discuterne. Questo non esaurisce la nostra cassetta degli attrezzi: tutti gli strumenti restano sul tavolo», ha dichiarato infatti il Commissario europeo al commercio Maroš Šefcovic.
L’Unione Europa prosegue su un «doppio binario»
L’ex ministra tedesca ha precisato che «possiamo rispondere con contromisure se necessario», ma in segno di buona volontà ha annunciato l’estensione fino all’inizio di agosto della sospensione della prima lista di contromisure europee ai dazi Usa su acciaio e alluminio. Una mossa scelta per evitare, per il momento, l’escalation temuta da molti osservatori e offrire lo spazio a un dialogo che scongiuri le tariffe trumpiane. L’Unione Europa prosegue su un «doppio binario»: da un lato insister sulla trattativa per appianare le divergenze tra i due lati dell’Atlantico; dall’altro continua la preparazione delle proprie contromisure in caso di fallimento dell’opzione negoziale.

Il secondo elenco, in risposta alle tariffe «reciproche» introdotte da Washington il 2 aprile, è «già stato concordato», ha spiegato la presidente. Secondo fonti diplomatiche, la Commissione avrebbe messo sul tavolo l’ipotesi di introdurre restrizioni su alcune esportazioni europee verso gli Stati Uniti, tra cui quelle di rottami di alluminio. Una reazione soprattutto alle pressioni francesi, con Parigi che – assieme a Spagna e Belgio – guida la fronda delle nazioni più critiche contro le politiche protezioniste americane. Più possibiliste Italia, Polonia e Germania, anche se in quest’ultima il dibattito resta aperto.
Germania, cresce ala per contromisure stile Cina
Il governo tedesco guidato da Friedrich Merz resta sensibile alle esigenze dell’industria teutonica, dipendente dall’accesso al mercato americano, ma cresce l’ala più “reattiva” alle minacce trumpiste, conscia che proprio l’economia germanica – costruita proprio in stretta relazione con quell’impianto normativo europeo che Trump ora vorrebbe smantellare (a cominciare dal Mercato unico) – sta uno dei primi bersagli del tycoon. Il ministro delle Finanze tedesco (nonché leader del Partito socialdemocratico, junior partner del governo di larghe intese al potere del Bundestag), Lars Klingbeil, ha detto che «se non si riuscirà a negoziare una soluzione equa dovremo prendere decise contromisure».

Per il momento comunque i Paesi europei rimangono divisi su come agire. Parigi preme in particolare per l’attivazione dello strumento anti-coercizione, il cosiddetto “bazooka”, un meccanismo automatico pensato per infliggere una pesante risposta reciproca contro un soggetto che cerchi di utilizzare la politica commerciale per costringere l’Unione Europea a modificare le proprie politiche (ironicamente, uno strumento pensato in primo luogo per poter essere applicato in caso di guerra commerciale con la Cina). Nel pacchetto dovrebbe essere inclusa, per esempio, un’azione contro le Big Tech, le grandi compagnie ad alta tecnologia americane che operano nel Vecchio Continente.
Von der Leyen, tuttavia, ha spiegato che lo strumento anti-coercizione «è stato creato per situazioni straordinarie» e «non siamo ancora arrivati a quel punto». Un’altra soluzione allo studio potrebbe essere una serie di restrizioni mirate contro le importazioni provenienti da “Red states”, cioè gli stati americani repubblicani, e da settori dominati da imprese guidate dai sostenitori di Trump, una strategia per “far pagare” la guerra commerciale alla base del tycoon e così esercitare una pressione indiretta sulla Casa Bianca. Questo approccio era già stato adottato dalla Cina, con buoni risultati, anche se restano ovviamente delle abissali differenze tra l’economia europea e quella cinese.
Oltre le tariffe, il rapporto Ue-Usa?
Fondamentalmente la questione resta tuttavia la posizione che l’Unione dovrebbe tenere nei confronti del processo di riorientamento della (tradizionalmente alleata) potenza americana. L’impero americano non è solo passato dall’essere alfiere della globalizzazione a esserne il suo primo detrattore, ma sta anche mutando pelle passando dall’essere una attore capace di canalizzare grandi flussi di capitale dalla propria economia verso l’esterno a una potenza “estrattiva”, volta cioè a esigere dalle regioni da lei controllate le risorse per mantenersi.
Insomma, invece che costruire un ordine internazionale fondato sul multilateralismo e l’internazionalismo politico-economico, il fine diventa imporre i “costi di gestione” dell’impero agli altri partner per poter mantenere il proprio primato. Una prospettiva radicale, che getta ombre fosche sulle stime di crescita dell’economia mondiale. La Commissione europea ha già ridotto di mezzo punto le previsioni per l’anno corrente, anche se, come ha ricordato il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, l’effetto negativo dei dazi sarà più forte per gli Stati Uniti che per il resto del mondo.
«Aspettare, gli Usa scenderanno a patti»
La strategia cautelativa europea sembra dunque ispirata allo stesso avviso che da Robert Habeck, ministro degli Affari economici nel vecchio governo tedesco guidato da Olaf Scholz, che all’annuncio dei primi dazi trumpiani, alcuni mesi fa, invitò l’Europa a stringere i denti e tenere duro: sul lungo periodo l’America, era il suo ragionamento, avrebbe sofferto la guerra doganale più del Vecchio Continente, costringendo infine Washington a scendere a patti pur di chiudere il dossier che lei stessa aveva sollevato. Una strategia forse rischiosa, ma finora coronata dal successo in alcuni casi (tra cui la citata Cina, ma anche il Canada).
A patto, naturalmente, che l’Europa ne segua l’esempio varando contromisure reciproche contro l’economia americana, di modo da far pagare a Trump la sua aggressione tariffaria e allo stesso tempo sottraendogli l’iniziativa. Esattamente il contrario di quanto per ora stabilito dall’Unione, che ha preferito un approccio più attendista anche alla luce delle inevitabili divisioni tra gli Stati membri. Solo il tempo dirà se questo approccio sia stato corretto oppure un inutile e vacuo tatticismo.

LA STRATEGIA: Nuova governance, resistere agli Usa
Paolo Mieli e Paolo Gentiloni sostengono che l’ostilità di Donald Trump nei confronti dell’Europa, sia sui dazi che sulla sicurezza, potrebbe trasformarsi in una opportunità per l’Ue. «È possibile, ma bisogna realizzare un complesso di condizioni non facili. Se fosse in grado di agire come un soggetto politico unitario, l’Europa avrebbe una potenza economica rilevante paragonabile a quella degli Usa. Ma bisogna chiedersi perché l’Ue ha condotto il confronto sui dazi con Trump da posizioni così deboli», avverte Enrico Morando, ex viceministro dell’Economia nei governi Renzi e Gentiloni.
L’ostacolo dell’unanimità
«È evidente – continua – che queste decisioni complesse non si possono assumere con la regola dell’unanimità. Oggi si può fare un salto di qualità su difesa e deterrenza soltanto con il concorso dei paesi che si sentiranno pronti per un processo di integrazione più intenso, ovvero i “volenterosi”. La capacità di decisione del consiglio europeo, basata sull’unanimità, può riguardare il minimo comune denominatore, ma non è all’altezza dei problemi che abbiamo di fronte».
Secondo Federico Fabbrini, docente di diritto europeo all’Università di Dublino, sul fronte dazi «sarebbe indispensabile una forte leadership dell’Unione europea che usi in modo pieno le prerogative che le danno i trattati. L’Ue dovrebbe reagire molto duramente sull’import di beni e servizi. Sarebbe un effetto positivo sul bilancio comunitario: i dazi porterebbero denari nelle casse comunitarie.
L’America in un mese ha raccolto 100 miliardi di dazi: pensiamo a quanto potrebbe raccogliere l’Ue. E i dazi si potrebbero usare per compensare i settori economici colpiti». Emerge ancora una volta un problema di governance. «I trattati darebbero alla Commissione europea il potere di gestire in modo ampio la questione dazi, ma la commissione si comporta come un segretariato di un soggetto intergovernativo cercando il consenso delle cancellerie», aggiunge Fabbrini.
VIDEOCOMMENTO – Dazi, dalla crisi un’occasione per l’Europa di Alessandro Barbano
In più, per la politica fiscale e la politica estera serve l’unanimità. «Cambiare questi meccanismi è impossibile: per modificare il trattato europeo serve l’unanimità. Certo, i trattati prevedono meccanismi per aggirare l’unanimità: l’astensione costruttiva – uno stato membro non vota per facilitare la scelta degli altri – è stata usata spesso per il sostegno all’Ucraina nel caso dell’Ungheria.
Si possono anche creare coalizioni tra stati volenterosi ma in questi meccanismi di cooperazione rafforzata ci sono dei limiti. La soluzione migliore per la difesa comune sarebbe creare una comunità parallela con un altro trattato come si tentò con la Ced negli anni 50 e come si è fatto per il Mes o per l’Unione bancaria».
La necessità del debito comune
Eppure le emergenze drammatiche potrebbero dare una spinta per produrre decisioni da troppo tempo rimandate. Ricorda Morando: «Per anni, dopo aver fatto la moneta comune abbiamo insistito sul fatto che non può esserci moneta comune e politica monetaria comune – a fronte della Bce unico organismo federale – senza un’autorità di politica fiscale.
Serve definire quali politiche sono affidate alla dimensione europea e avere la possibilità di finanziarle facendo debito comune. Ma la risposta dei paesi frugali agli eurobond è sempre stata: “No”. Poi però esplode la pandemia, una tragedia che colpisce tutti i paesi dell’Ue, e nel giro di due mesi facciamo quello che non abbiamo fatto in dieci anni: il Next Generation EU. I frugali dicono: solo questa volta e mai più. Ma questo precedente dimostra che si può fare debito comune di fronte a una minaccia comune. Ebbene, l’ultimo vertice della Nato ha detto che la Russia è una minaccia di lungo periodo per l’Europa: se prendiamo sul serio quella minaccia dobbiamo chiedere un maggior impegno nella costruzione di una deterrenza europea e dobbiamo pensare a come si finanzia. Bene i bilanci nazionali su progetti comuni, ma serve il debito comune».
Un bilancio Ue più ricco
Proprio domani, 16 luglio, la Commissione Ue presenterà il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea, che fissa l’ammontare del bilancio 2028-34, le risorse disponibili e gli strumenti per le varie politiche e le modalità di finanziamento. In quella sede, dice Fabbrini, «Ursula von der Leyen avrebbe l’occasione per triplicare il bilancio e investire massicciamente sull’economia interna, compensando la perdita del mercato americano con lo sviluppo del mercato interno, anche sul piano tecnologico e militare.
VIDEOCOMMENTO – Dazi, dalla crisi un’occasione per l’Europa
Se questo avvenisse ci sarebbe un grande salto in avanti e la commissione si rafforzerebbe sul piano federale». Continua Fabbrini: «Se la commissione fosse ambiziosa dovrebbe sparare alto. Purtroppo, ci sono tuttora paesi europei contrari ad aumentare il bilancio comune. Viceversa servirebbe molto di più rispetto agli 1,8 trilioni di euro del 2020 pari appena all’1,5% del Pil dell’Europa. Basti pensare che il bilancio federale degli Usa è pari al 40% del Pil e che l’America spende 800 miliardi di dollari all’anno solo per la difesa. Nel suo rapporto sulla competitività Draghi propone di alzare la spesa comune a 800 miliardi all’anno, ma per tutte le voci di spesa».

Verso il mercato finanziario europeo
Alla fine, sia Federico Fabbrini che Enrico Morando ritengono che la road map strategica per l’Europa sia già indicata nei rapporti stilati ormai un anno fa da Mario Draghi e da Enrico Letta. Trump accusa lo squilibrio della bilancia commerciale per via delle politiche protezionistiche dell’Ue, ma c’è un fiume di miliardi di euro che va proprio a ingrassare il mercato americano.
Proprio per questo, spiega Morando, «la costruzione di un mercato finanziario davvero europeo è necessaria: per farlo è indispensabile un volume più elevato di emissione di debito pubblico europeo: senza non c’è un architrave del mercato europeo più avanzato. Di fronte ai problemi che Trump causa al dollaro, i risparmiatori potrebbero essere disposti a privilegiare il mercato europeo perché redditizio e sicuro. Ma per farlo, come spiegano Letta e Draghi, serve un mercato più grande e maggiori titoli di debito pubblico europeo».