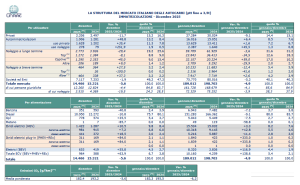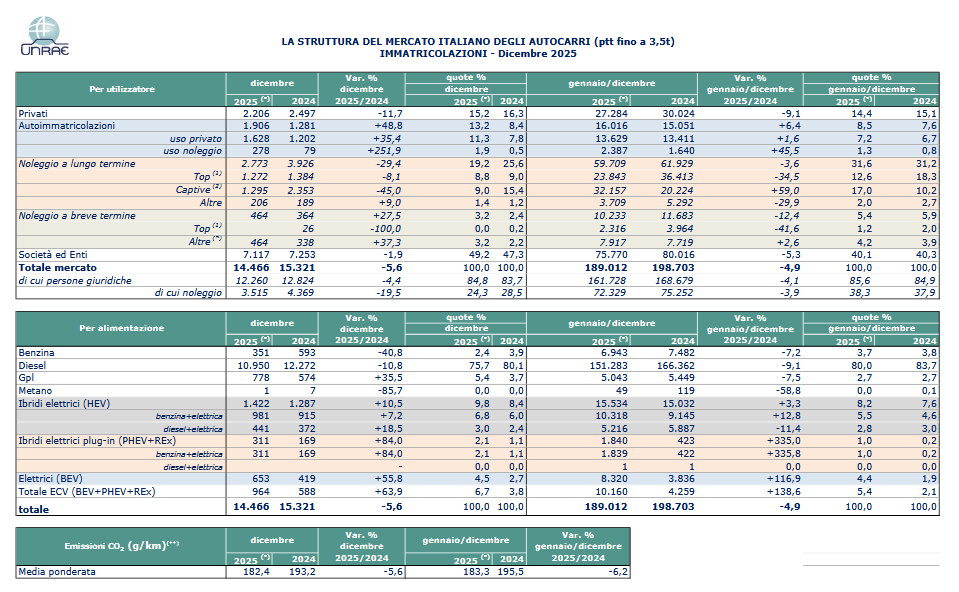Strade da non percorrere, orari, comportamenti. Il 57% delle giovani tra 18-24 anni evita alcune zone. La sicurezza resta questione di genere
Sembra che esistano quasi sempre due versioni di una stessa città. Una è quella disegnata sulle mappe, l’altra è quella che le donne imparano a evitare. Strade da non percorrere, orari da rispettare, comportamenti sociali da ponderare. La prima città è teoricamente accessibile a tutti. La seconda, invece, si accompagna allo sguardo costante alla sicurezza personale, che modella comportamenti e ridisegna confini invisibili.
Secondo i dati ISTAT del 2024, la percezione dell’insicurezza urbana è infatti fortemente influenzata dal genere. Se negli ultimi anni è cresciuta complessivamente la quota di cittadini che si sentono sicuri in Italia, con il 76% della popolazione che si dichiara “molto o abbastanza sicura” quando esce a piedi nella propria zona di residenza anche di notte, tuttavia, le donne continuano a percepire un maggiore senso di insicurezza. Il 40% dichiara infatti che il timore per la propria incolumità ne condiziona la vita quotidiana, con picchi ancora più alti tra le giovani (57% nella fascia 18-24 anni), le disoccupate (49%) e le residenti nei grandi centri urbani (46%).

Negli uomini, questo dato aumenta invece con l’età, raggiungendo il picco negli anziani. Nel 35,8% dei casi, le persone temono per sé o per i propri familiari il rischio di subire un abuso sessuale, ma ad essere più preoccupate sono le donne, con il 38,9% contro il 32,3% degli uomini. Il divario di percezione si allarga ulteriormente se si guarda a come cambia il modo di vivere la mobilità. Le donne sono infatti il doppio più inclini a sentirsi insicure quando escono da sole la sera (16,4% contro il 7,4% degli uomini) e la paura della criminalità le condiziona maggiormente, colpendo il 28,8% delle donne, contro il 19% degli uomini.
Dai dati, sembra abbastanza evidente che le donne vivono e si muovono nello spazio pubblico in modo profondamente diverso dagli uomini. Come spesso accade, non si tratta solo di timore, ma di una forma di controllo che si interiorizza, con la consapevolezza che certi luoghi, in certi orari, non sono sicuri, in modo prevalente, per un determinato genere. Le donne sono infatti quasi quattro volte più numerose nel dichiarare di rinunciare del tutto a uscire per paura (19,5% rispetto al 5,3%).
Nonostante questi numeri, complessivamente, quasi otto cittadini su dieci ritengono che le forze dell’ordine siano efficaci nel controllo della criminalità, e questa fiducia si traduce spesso in una gestione dell’insicurezza basata su risposte emergenziali (più pattuglie, più telecamere, più controlli). Misure che possono rassicurare nell’immediato, ma che raramente si accompagnano a politiche strutturali capaci di affrontare le radici sociali e culturali della violenza.
Politiche strutturali che sarebbero invece necessarie su più livelli. In primo luogo, perché oggi i punti di riferimento più riconosciuti e accessibili per molte donne sono realtà dal basso. Negli ultimi anni stanno nascendo diverse app o servizi comunitari per colmare i vuoti delle politiche pubbliche. Un esempio è Wher, un’app nata a Torino, una sorta di navigatore pensato per le donne e basato su segnalazioni della community; le utenti possono indicare i percorsi più sicuri in città in base all’illuminazione, alla presenza di passanti, alla vivibilità delle strade. O anche Viola Walkhome, che offre un servizio di videoaccompagnamento con volontari che “camminano” virtualmente con persone sole, scoraggiando potenziali aggressori.
Si tratta di strumenti utili, ma che, da soli, spesso restano palliativi che fanno emergere quanto la società stia facendo affidamento su strategie fai-da-te, in mancanza di interventi sistemici che garantiscano spazi pubblici sicuri e accessibili per chiunque, indipendentemente dal genere.
Del resto, centri antiviolenza, associazioni, consultori, sono ancora oggi spazi spesso precari e sottofinanziati, che andrebbero probabilmente rafforzati, valorizzati e messi in rete in modo stabile e capillare, trattandosi di luoghi fondamentali nel fornire ascolto, protezione e percorsi di uscita dalla violenza.
E questo si lega al secondo punto, ossia che la paura della violenza è spesso accompagnata – e amplificata – dalla paura di essere giudicate se la si subisce. Ancora oggi, a partire dai racconti dei media che testimoniano casi di violenza, il focus è spesso spostato sulla condotta femminile: dove si trovava la vittima, come era vestita, perché era lì, da sola, a quell’ora. Questa narrazione distorta scoraggia molte donne dal denunciare, specialmente nelle fasi iniziali, temendo di non essere credute o di vedere la propria esperienza minimizzata.
Questo tipo di rappresentazione non solo è inefficace dal punto di vista comunicativo, ma contribuisce ad alimentare una cultura che normalizza gli abusi e deresponsabilizza chi li compie. Questa tendenza rivela una resistenza profonda ad ammettere l’esistenza di un problema culturale, e una radicata incapacità di riconoscere quanto anche il linguaggio con cui si raccontano gli episodi di violenza contribuisca a normalizzarli. La narrazione dominante finisce così per rafforzare stereotipi e colpevolizzazioni, offrendo – anche involontariamente – una giustificazione implicita alla violenza, celata dietro l’idea di una condotta imprudente da parte della vittima. Così, invece di proteggerla, la si isola.
In questo modo, le donne non si sentono al sicuro né nello spazio urbano, né in una società pronta a giudicarle, nel caso in cui diventassero vittime.
Per tutte queste ragioni, oggi occorrerebbero risposte strutturali. Servirebbero città pensate anche a misura di chi, troppo spesso, ne viene escluso. Ripensare la sicurezza dal punto di vista delle donne non significa infatti solo aumentare il controllo, ma costruire spazi vivibili, garantire presenza e cura del territorio, promuovere educazione affettiva e di genere, redistribuire potere e accesso. Significa mettere al centro il diritto alla libertà e alla partecipazione, e riconoscere che una città è davvero pubblica solo se può essere vissuta anche da chi oggi l’attraversa con timore.