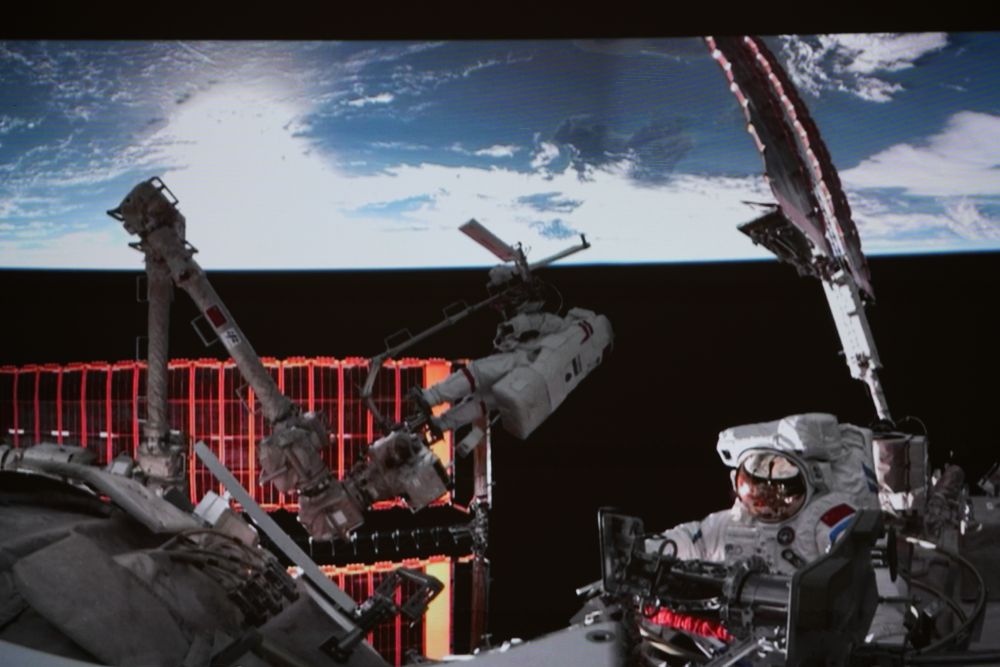Ottant’anni dopo il processo di Norimberga, lo storico Marcello Flores ricorda l’eredità giuridica di un evento spartiacque del Novecento
Ottant’anni fa iniziava il processo di Norimberga. Finirono alla sbarra – alcuni poi condannati a morte, altri che la morte se la diedero ingerendo cianuro, altri assolti – i principali responsabili dei crimini nazisti.
Ma Norimberga fu anche il tentativo di confermare la sconfitta del Male e di ristabilire quel minimo di principi di umanità che la Germania nazista aveva negato. Oltre a storici di professione, l’immagine del Male sul banco degli imputati ha affascinato scrittori e registi, compreso James Vanderbilt, il cui nuovo film Nuremberg sarà presentato al Torino film festival che inizierà domani.
Ma che cosa rende il processo di Norimberga un evento spartiacque nella storia del Novecento? Lo chiediamo a Marcello Flores, storico e studioso dei totalitarismi del Secolo Breve.

«Quel processo rappresenta una pietra miliare nel rinnovamento del diritto internazionale che avviene alla fine della seconda guerra mondiale. Ha poi degli aspetti che erano controversi all’epoca e che lo sono ancora oggi»
Ad esempio?
«Pensi alla retroattività di certi crimini che non esistevano nella legislazione di nessun Paese, come i crimini contro l’umanità, forse il punto più innovativo del processo di Norimberga. Ma come ricordò uno degli accusatori del processo, si trattava di crimini che fin dal tempo di Caino erano presenti nei codici penali».
Il dato storico è che quello fu il processo dei vincitori contro i vinti. Questo cosa implicava?
«Implicava anzitutto che le accuse rispetto a certi crimini non potessero tener conto di crimini analoghi compiuti dai vincitori».
Anche in questo caso le chiedo un esempio.
«Il motivo per cui l’ammiraglio Dönitz venne assolto dall’accusa di avere infranto le leggi di guerra sottomarina è che le stesse leggi erano state infrante dagli Alleati. Poi c’è un caso ancor più emblematico: l’Unione Sovietica tentò di far rientrare nei crimini nazisti anche l’eccidio di Katyn, dove furono invece i russi a uccidere migliaia di ufficiali polacchi. Gli inglesi capirono che questo avrebbe minato tutto l’impianto accusatorio».
Qual è il principale elemento di novità di quel processo?

«Da quel momento in poi, le decisioni prese a Norimberga divennero regole fondamentali del diritto internazionale valevoli per tutti. Si avanzò quindi l’ipotesi di creare un tribunale permanente, che è stato messo in cantiere solo alla fine del secolo con lo Statuto di Roma e, successivamente, con la creazione della Corte Penale Internazionale»
A Norimberga si parlò anche di genocidio?
«Se ne parlò, ma non venne usato come capo d’accusa perché solo nel dicembre del ’48 il genocidio fu oggetto di una convenzione delle Nazioni Unite. Ma se mettiamo insieme quella convenzione, il processo di Norimberga, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e le quattro convenzioni di Ginevra del ’49, vediamo che si costituisce in quegli anni un nuovo blocco di diritto internazionale che si basava su una novità rivoluzionaria: gli Stati non sono liberi di comportarsi al loro interno come vogliono. I giuristi del Reich sostenevano di non poter rimproverare nulla a Hitler perché era suo diritto fare quello che faceva in Germania. Dopo Norimberga questo non fu più possibile. Era una nuova visione universalistica del diritto, resa possibile dal fatto che gli Stati delle Nazioni Unite cedevano parte della propria sovranità».
Il diritto internazionale oggi è messo sempre più in discussione. Si tratta di una degenerazione fisiologica?
«Non direi fisiologica. Direi che è una degenerazione attuale, di questa fase storica. Il diritto internazionale nasce con l’idea che i singoli Stati delle Nazioni Unite dovessero continuare a legittimare gli organismi internazionali. In questi ultimi anni assistiamo invece, soprattutto da parte dei grandi Stati, alla delegittimazione di quelle istituzioni di cui loro stessi erano stati i fautori».
A Norimberga non venivano processati solo i gerarchi responsabili del genocidio nazista, ma il male nazista in sé.
«Norimberga è all’inizio di una giustizia di tipo universalistico, ma fu anche giustizia dei vincitori contro i vinti e per questo tante critiche sono state mosse a quel tribunale nei decenni. Quell’evento mantiene però un enorme valore di rottura morale, politica e giuridica».