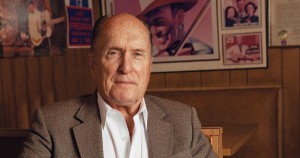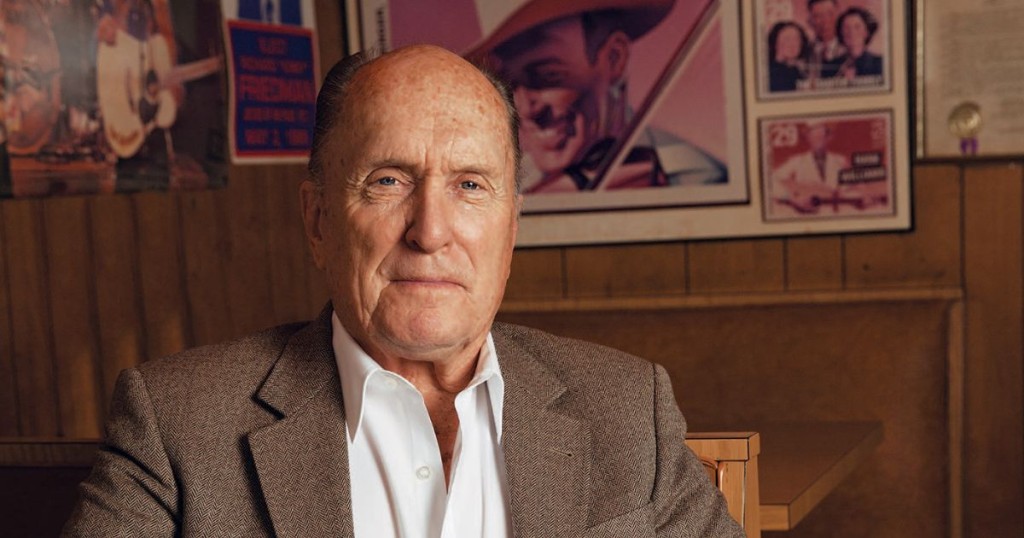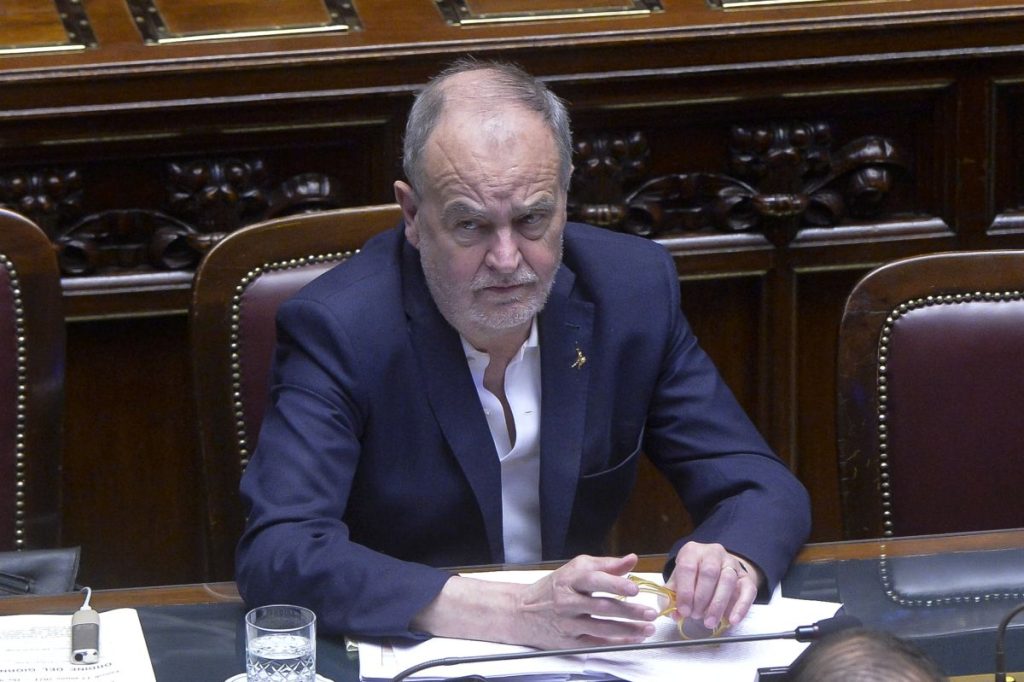Oltre il 50% dei medici e il 45% degli infermieri soffrono di burnout. Tra le donne, l’incidenza è più che doppia, segno di come le difficoltà di conciliare la vita familiare con un lavoro sempre più gravoso abbiano un impatto diretto sulla salute. È quanto emerge dal Rapporto sulla Salute e sul Sistema Sanitario, realizzato da Eurispes e Fondazione Enpam nell’ambito dell’Osservatorio Permanente su Salute, Legalità e Previdenza.
Non si parla più di rischio, ma di un fenomeno ormai strutturale e di una delle sfide più urgenti che il Servizio Sanitario Nazionale si trova ad affrontare. Il burnout è la manifestazione di un esaurimento emotivo, mentale e fisico generato da condizioni di stress cronico e prolungato. Le sue ripercussioni sono pesantissime, non solo sulla salute degli operatori, ma anche sulle cure offerte ai pazienti.
Questa situazione è il frutto di un processo lungo e complesso, iniziato a fine anni Duemila, quando le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno ridotto drasticamente le nuove assunzioni, in particolare tra i medici specialisti.
I numeri parlano chiaro: tra il 2014 e il 2017, il rapporto tra ingressi e uscite per pensionamento è diminuito del 18,4%, riducendo così il numero complessivo degli operatori in servizio. Parallelamente, l’età media del personale sanitario è aumentata, con un conseguente aggravio dei carichi di lavoro. Dal 2019 al 2022, inoltre, il ricorso a contratti a tempo determinato è cresciuto del 44,6%, segnando una progressiva instabilità che ha alimentato precarietà e ulteriore stress. Secondo Anaao Assomed, il principale sindacato degli ospedalieri, la prospettiva è allarmante: entro il 2027 mancheranno all’appello tra i 20 e i 25 mila specialisti.
La pandemia ha rappresentato un detonatore di queste fragilità, aggravando un quadro già compromesso. L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, in un rapporto dedicato agli effetti del Covid-19, rileva che il 33% degli operatori sanitari ha manifestato sintomi depressivi, il 37% ha sperimentato ansia e il 38% ha sviluppato burnout. Alla pressione psicologica si è aggiunto il drammatico aumento della violenza da parte dell’utenza. Sono circa 18.000 gli operatori vittime di aggressioni, con le donne che riportano due terzi degli episodi. La categoria più colpita resta quella infermieristica, seguita da medici e operatori socio-sanitari.
A peggiorare il quadro si aggiunge il nodo retributivo. Il reddito annuale dei medici specialisti e del personale infermieristico in Italia è più basso del 22% rispetto a quello dei colleghi di Paesi come Svizzera, Olanda, Germania e Irlanda. Una disparità che contribuisce ad alimentare la disaffezione verso il sistema sanitario nazionale e spinge molti professionisti a cercare opportunità all’estero o nel privato.
Non meno grave è la situazione della medicina generale. Secondo un rapporto della Fondazione Gimbe, al primo gennaio 2025 mancano all’appello oltre 5.500 medici di famiglia in tutta Italia, con la previsione di ulteriori 7.300 pensionamenti entro il 2027. La crisi è aggravata dal calo costante dei giovani che scelgono questa strada, un fenomeno che si riflette anche nelle borse di studio non assegnate. Nel 2024 il 15% delle borse per la medicina generale è rimasto scoperto, con picchi che superano il 40% in regioni cruciali come Lombardia, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.
Il fenomeno ha assunto contorni drammatici in alcune aree del Paese: dal 2019 al 2023 la Sardegna ha visto un calo del 39% dei medici di base, la Puglia del 25,8%, la Calabria del 20,9% e l’Abruzzo del 16,7%. Solo la Provincia Autonoma di Bolzano registra un lieve aumento, pari all’1%. A ciò si aggiunge il problema del sovraccarico di assistiti. Più della metà dei medici di famiglia italiani segue oltre 1.500 pazienti ciascuno, con punte di 1.546 in Veneto e 1.529 in Lombardia. In regioni meno popolose, come il Molise, la media scende a circa 1.100, ma resta comunque significativa e tale da compromettere la qualità della presa in carico, soprattutto per anziani e persone fragili.
Il burnout ha, infatti, conseguenze tangibili: genera distacco, riduzione dell’efficacia lavorativa, insonnia, depressione e, nei casi più gravi, aumento del rischio suicidario. Non si tratta di un problema circoscritto al benessere dei singoli operatori, ma di una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità delle cure. Si stima che il burnout sia associato ad almeno 20.000 errori gravi all’anno tra i medici, mentre oltre il 50% degli errori infermieristici è riconducibile al sovraccarico psichico.
Il tema riguarda anche le nuove generazioni. Millennials e Generazione Z non solo chiedono maggiore equilibrio tra vita e lavoro e condizioni più flessibili, ma dimostrano sempre meno interesse per un sistema che percepiscono come poco attrattivo. Molti scelgono il settore privato o decidono di trasferirsi all’estero, lasciando il pubblico in una condizione di ulteriore fragilità.
Eppure, prevenire il burnout è possibile. Alcune pratiche individuali, come la mindfulness, l’attività fisica o lo sviluppo di competenze comunicative empatiche, hanno dimostrato di ridurre i rischi e sostenere il benessere psicologico. A livello organizzativo, però, è necessario un cambio di passo. Servono turni di lavoro rispettosi dei ritmi fisiologici, ambienti professionali sicuri e stimolanti, servizi di supporto psicologico accessibili e privi di stigma, oltre a politiche di welfare e retribuzioni adeguate. La possibilità di segnalare episodi negativi senza timore di ritorsioni e l’introduzione di strumenti di prevenzione culturale rappresentano ulteriori tasselli indispensabili.
Il burnout deve essere riconosciuto come un problema sistemico e non come fragilità individuale. Risolvere la crisi che affligge medici, infermieri e operatori socio-sanitari non è solo un’urgenza professionale, ma una priorità politica e sociale. In gioco ci sono la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, la sicurezza dei pazienti e la valorizzazione del capitale umano che tiene in piedi il sistema. Servono scelte coraggiose, investimenti strutturali e una nuova attenzione alle esigenze delle generazioni più giovani per garantire un servizio sanitario capace di rimanere efficiente, sicuro e profondamente umano.
29 Set, 2025
Sanità ed effetto burnout, la crisi che logora medici e pazienti

Una voce delle notizie: da oggi sempre con te!
Accedi a contenuti esclusivi
Potrebbe interessarti
Le rubriche
Mimì
Sport
Primo piano
Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.