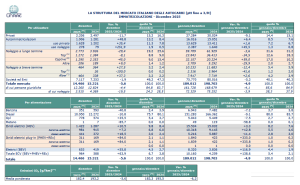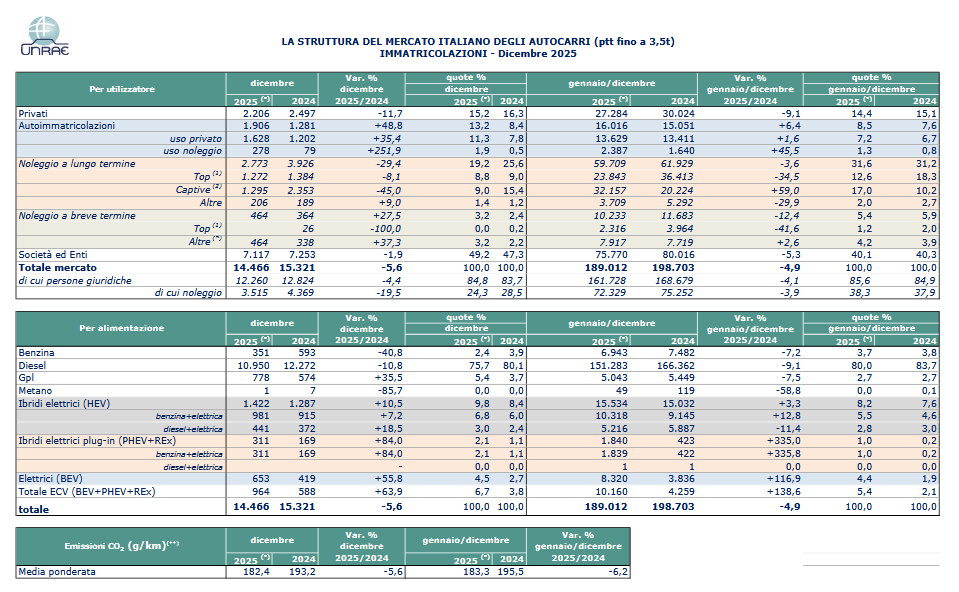Probabilmente è capitato a più d’uno, ad un certo punto della vita, di pensare al desiderio di sparire del tutto. Attraversare momenti difficili delle nostre vite può, in concomitanza con alcune situazioni particolari, portare magari a pensare al desiderio di sparire come soluzione migliore in quel momento. Esiste anche una certa casistica in occidente, tanto che questo fenomeno viene solitamente indicato con il termine anglosassone “ghosting”, che rievoca la figura dei fantasmi.
Nella cultura giapponese, così particolare e unica nella sua complessità – dove peraltro nasce anche il fenomeno degli hikikomori (giovani che si ritirano completamente dalla società) – questo fenomeno appare comunque molto peculiare e radicato, tanto da avere un ruolo specifico nella cultura del paese nipponico.
I giapponesi lo chiamano Johatsu (letteralmente “scomparsa”) e se ne parla riferendosi ad una persona che scompare volontariamente dalla propria vita quotidiana, tagliando ogni legame con familiari, amici, lavoro e società, senza però necessariamente morire. In Occidente, come ricordato, questo fenomeno è talvolta paragonabile al concetto di ghosting estremo o alla fuga sociale, ma in Giappone ha radici culturali e sociali molto specifiche. Nel paese del Sol levante la pressione sociale, il dovere verso la famiglia e l’azienda, e la paura dello stigma sociale possono spingere alcune persone a cercare una via di fuga radicale. Il Johatsu rappresenta una sorta di “morte sociale” volontaria: la persona non muore fisicamente, ma scompare completamente, assumendo a volte una nuova identità altrove. Anche se a volte può essere confuso con l’hikikomori, ci sono alcune differenze sostanziali: l’hikikomori si isola, ma rimane nella propria famiglia, mantenendo un legame, sia pur minimo, con l’ambiente familiare, mentre lo Johatsu taglia ogni legame, spesso lascia la città, cambia nome, e cerca di ricominciare da zero altrove.
Le motivazioni possono essere diverse, dal burnout lavorativo alle pressioni familiari o sociali, ma anche per fallimenti economici o personali, fuga da debiti o scandali ovvero per un generico desiderio di libertà e rinascita personale. Negli ultimi anni, il fenomeno è stato studiato e discusso sempre più apertamente in Giappone. Esistono persino agenzie specializzate che aiutano le persone a “ricominciare da zero” (servizi di reinserimento sociale o cambio di identità), così come gruppi di supporto per chi desidera tornare alla vita sociale dopo anni di scomparsa. Ci sono anche casi documentati di persone che, dopo anni di Johatsu, hanno deciso di tornare alle loro vite precedenti, spesso con grande difficoltà emotive e legali.
Il fenomeno del Johatsu, nella sua forma specifica e culturalmente radicata, è tipicamente giapponese, ma esistono fenomeni simili in altre parti del mondo, anche se con caratteristiche e motivazioni diverse. Negli Stati Uniti e Europa occidentale, per esempio, ci sono persone che scelgono volontariamente di vivere fuori dal sistema, senza documenti, carte di credito, o presenza digitale (etichettate come “Going off the grid”), oppure con stili di vita nomadi, scelti genericamente per libertà ma anche per fuggire da problemi personali o economici. Esiste anche qualcosa che ha a che fare con la scomparsa volontaria: esiste ma è meno strutturato e meno accettato socialmente.
In Cina, invece, esiste la figura del “Sanzuoliu”, termine che designa persone che vivono una vita estremamente semplice e isolata, spesso in montagna o in luoghi remoti, cercando la pace spirituale. Si tratta in pratica di fenomeni di fuga dai grandi centri urbani per sfuggire alla pressione sociale e lavorativa.
Il fenomeno è presente anche in Russia e nei paesi dell’est, noto con il termine di “Otshelniki”, e si riferisce a persone che si ritirano nella natura, spesso nella taiga, per vivere in totale isolamento con una componente più spirituale/escapistica.
In India, infine, va segnalata la presenza di sadhu e monaci vagabondi: sebbene con motivazioni spirituali, alcuni lasciano completamente la vita sociale precedente mettendo in atto la sannyasa, rinuncia totale alla vita mondana. Sebbene per alcuni aspetti possano sembrare simili, lo Johatsu si distingue da questi altri comportamenti, intanto perché non è principalmente spirituale (a differenza di molti casi orientali), ed è inoltre caratterizzato da una forte componente di fuga sociale e psicologica. È quasi istituzionalizzato nella cultura giapponese moderna, e spesso implica un tentativo di ricostruirsi una vita completamente nuova.
Un aspetto davvero del tutto singolare, diverso da molte altre espressioni di scelte di vita in altri paesi asiatici, a partire dal cosiddetto “Sampo po” (letteralmente “rinunciare a tre cose”: lavoro, amore e figli), fenomeno crescente tra i giovani coreani che decidono di non cercare lavoro stressante, non innamorarsi o sposarsi, non avere figli; così pure dal “Tangping”, l’arrendersi elegantemente rinunciando alle aspettative sociali più una protesta culturale che una scomparsa fisica, presente soprattutto in Cina.
In Occidente, invece, il fenomeno dello Johatsu appare certamente meno diffuso. Le ragioni sono molteplici. Sistemi di welfare e supporto psicologico più sviluppati, maggiore mobilità sociale e possibilità di ricominciare senza scomparire, leggi più rigide sull’identità e la documentazione e infine, non meno importante, meno pressione collettivista e più accettazione dell’individualità. In sintesi, mentre il fenomeno base della scomparsa volontaria esiste ovunque, il Johatsu come costrutto culturale è sostanzialmente unico del Giappone, anche se altri paesi hanno manifestazioni simili con sfumature diverse.
Interessante l’analisi dei profili maggiormente legati al fenomeno, in Giappone, a partire dalla constatazione che si tratta prevalentemente di maschi nella fascia d’età 30-50 anni, spesso impiegati in aziende tradizionali giapponesi e come sottoposti a pressioni estreme di produttività e conformismo. La seconda fascia d’età più colpita, quella dei giovani tra i 20 e i 30 anni, spesso legata al fenomeno degli hikikomori che decide di andare oltre, mostrando crisi di identità e rifiuto delle aspettative sociali. Per quello che riguarda i profili professionali, il gruppo più rappresentato è quello degli impiegati, con stress da lavoro, burnout, pressione gerarchica e anche difficoltà ad ammettere fallimenti o cambiamenti; ma ci sono anche piccoli imprenditori e commercianti alle prese con fallimenti economici che portano a debiti e stigma sociale con conseguente impossibilità di salvare la faccia nella comunità. Da segnalare anche gli ex-yakuza o ex membri di gruppi sociali chiusi, persone che cercano di sfuggire a strutture coercitive e che manifestano necessità di tagliare completamente i legami per la sicurezza. Da non sottovalutare neanche i problemi matrimoniali/familiari, con divorzi traumatici e più in generale una spiccata incapacità di chiedere aiuto nella cultura del “gaman”, una sorta di resistenza stoica.
Il fenomeno del Johatsu è stato oggetto di studio da parte di numerosi sociologi, antropologi e ricercatori giapponesi e internazionali, in particolare negli ultimi 20-30 anni. Le teorie sociologiche più convincenti e seguite dagli studiosi si possono raggruppare in diverse correnti.
Fra le teorie dominanti, quella della disintegrazione sociale (che riprende gli studi di Émile Durkheim), che spiega il Johatsu come risposta all’anomia moderna, collega il fenomeno al crollo dei legami comunitari tradizionali ed è certamente utile per comprendere l’isolamento in una società altamente strutturata. Evidenze di questa teoria sono legate al fatto che il fenomeno è più diffuso nelle aree urbane con minor coesione sociale. Altro approccio teorico, quello denominato del “Face-work” e onore sociale (in pratica, Everett Hughes/Cicourel adattati), che vede impegnati soprattutto antropologi sociali e studiosi della cultura giapponese. Questa modalità teorica spiega perché la scomparsa è preferita ad altre forme di ritiro e collega il fenomeno alla cultura dell’ “haji” (vergogna) e “mentsu” (faccia), incorporando così la dimensione culturale specifica. Punto di forza di questo approccio il fatto che molti Johatsu lasciano lettere di addio che parlano di “non poter salvare la faccia”.
I più giovani sociologi giapponesi, invece, propongono la teoria della fuga dai “vincoli sociali” (Shibuya e colleghi), integrando elementi della sociologia giapponese tradizionale con approcci contemporanei. In questo modo, anche considerando il contesto economico post-bolla giapponese, la teoria spiega perché persone normali prendono decisioni estreme.
Studiosi internazionali della modernità riflessiva propongono invece la teoria dell’identità frammentata (a partire dalle teorie di Giddens), che spiega il Johatsu come crisi dell’identità nel contesto della modernità liquida, collegando il fenomeno alle trasformazioni globali.
Infine, l’approccio forse più recente e anche maggiormente diffuso, che parte da un approccio sistemico legato alla complessità del fenomeno.
Si tratta di un modello bio-psico-sociale-culturale che considera come componenti principali i fattori culturali (conformismo, stigma), quelli sociali (pressioni lavorative, strutture familiari, coesione comunitaria), quelli psicologici (personalità, strategia di fronteggiamento, salute mentale) e infine quelli biologici (eventualmente legati a stress cronico, burnout, depressione). Un approccio che pare convincente, perché spiega la complessità multilivello del fenomeno permettendo così interventi su diversi piani. Con la chiara evidenza, per queste ragioni, di una reale ed efficace integrazione negli attuali programmi di prevenzione.