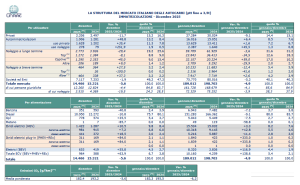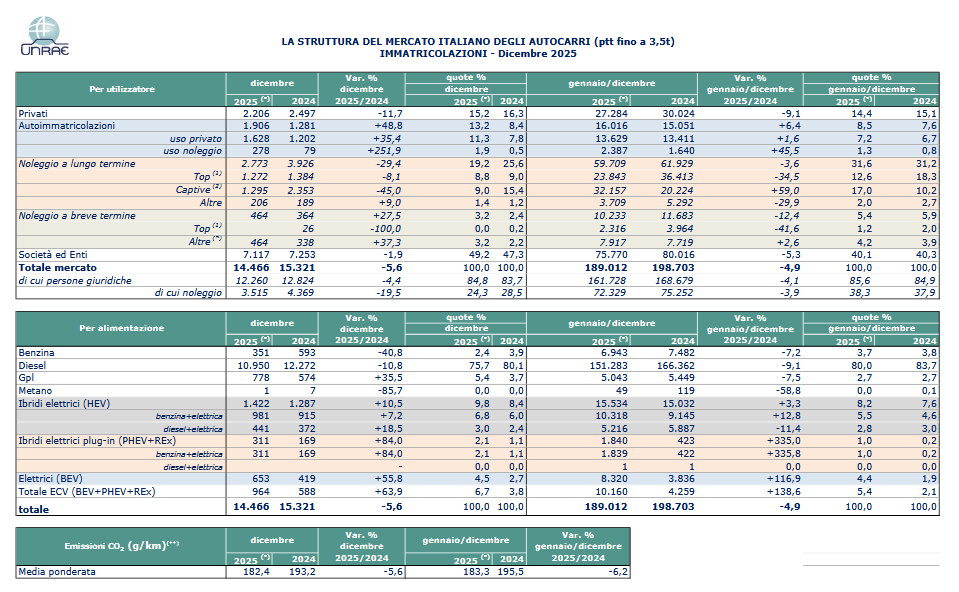Un giudice silenzioso, severo, preciso e incontestabile, infallibile e spietato. Pure se parla solo nelle fiabe per aizzare la feroce gelosia di streghe malvagie, tutti i giorni senza un sibilo emette sentenze che regalano gioie e dolori, certezze e frustrazioni. Da quando facciamo i conti con lo specchio?
Da secoli.
È un gioco serio e millenario quello tra noi e lo spècchio: dal latino speculum derivato da specere «guardare». Un sortilegio che seppur svelato dalla fisica, conserva sempre un alone di magia, mistero e fascino. Lo specchio provoca lo stupore che deriva dal trovarsi faccia a faccia con noi stessi. Ricorda la meraviglia che devono aver provato i primi uomini quando in una suggestione di luci e di ombre si videro per la prima volta nelle pozze d’acqua o nello sguardo dell’Altro. Rievoca l’incanto di Narciso, il figlio di una ninfa e di un dio fluviale, quando punito dagli dèi s’innamora della sua stessa immagine riflessa per poi morire cadendo in quel lago in cui si era specchiato. Allo specchio, però, non solo narcisi e vanitosi. L’iconografia allegorica ha rappresentato anche la Verità e la Prudenza nell’atto di tenere in mano questo oggetto prodigioso e contemplarlo.
Bisogna andare molto indietro nel tempo per trovarne l’antenato. C’è chi lo fa risalire ai reperti ritrovati nell’antica Anatolia, dove pare fosse consuetudine produrre dei pezzi di ossidiana lucidi e riflettenti. Per avere specchi più vicini a quelli che conosciamo oggi il viaggio ci conduce altresì in Egitto, in Mesopotamia e nell’antica Roma. Lastre di vetro unite da metalli erano in uso nel Medioevo.
L’età d’oro degli specchi lussuosi ha due capitali: Venezia e Versailles. Nella Serenissima la prima produzione di specchi di Murano risale al 1369. Siamo intorno al 1540 quando il veneziano Vincenzo Redor sempre a Murano mette a punto la tecnica dello spianamento delle lastre di vetro, creandone un tipo limpidissimo: il cristallo. È l’inizio della produzione di specchi di alto pregio che sarebbero diventati celebri in tutto il mondo. In Francia, invece, la narrazione passa per la Galleria degli Specchi. In stile barocco è una delle stanze più emblematiche e suggestive della Reggia di Versailles.
Passata alla Storia (anche) per aver ospitato eventi storici tra cui la proclamazione dell’Impero tedesco e la firma dell’omonimo trattato, la Galleria degli Specchi rappresenta uno degli esempi più affascinanti dell’architettura dell’epoca. A dispetto della superstizione conta 17 finestre aperte in direzione del parco; di fronte ad esse, sulla parete opposta, si trovano 17 specchi delle medesime dimensioni, composte ciascuna da altri 350 più piccoli.
Bisognerà attendere la seconda metà dell’Ottocento per avere, invece, la diffusione “democratica” degli specchi. La ragione è economica. Il costo di quello che fino a quel momento era un oggetto di lusso accessibile a pochi, cala grazie all’argentatura messa a punto da Justus von Liebig. Si tratta di una soluzione di nitrato di argento, ammoniaca e acido tartarico. Fa si che al vetro si fissano minutissime particelle di argento, poi ricoperto da gommalacca. Da quel momento quell’oggetto stupefacente arriva man mano nelle case di tutti e ci rimane per sempre portandosi dietro pure il suo carico di magia e superstizioni dure a morire. Lo specchio viene visto, ad esempio, come una porta d’accesso per il più misterioso dei mondi: l’Aldilà. Nella narrazione popolare gli specchi duplicano la realtà al punto da imprigionare l’anima nell’immagine riflessa. Da qui, l’usanza di coprirli alla morte di qualcuno per consentire al defunto di raggiungere l’oltretomba. La connessione specchio/anima poi sarebbe all’origine di caratteristiche tipiche delle creature demoniache. Le versioni sono diverse. Leggenda vuole che i vampiri non riflettono la propria immagine poiché priva di anima; altre creature mitologiche muoiono all’istante nel vedersi in uno specchio o in una qualunque superficie riflettente. Tra queste c’è il basilisco, il re dei serpenti descritto da Plinio il Vecchio e Solino, in grado di uccidere con il solo sguardo che pietrifica o incenerisce. Brividi e consigli dettati dalle convinzioni come quella di non mettere i bambini troppo piccoli davanti agli specchi o quella secondo cui romperli porterebbe sette anni di disgrazia.
Leggende fiorite intorno a un oggetto che ha sedotto anche il mondo dell’arte.
Ne sono la prova alcuni capolavori della pittura, tra cui il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck, Las Meninas di Diego Velázquez, Donna allo specchio di Tiziano o Lo specchio di Venere di Edward Burne-Jones. A proposito della dea dell’Amore e dello specchio c’è chi parla di “effetto Venere”(espediente conosciuto e usato anche nel Cinema e nella Fotografia). Un inganno del riflesso, chiamato così per via dei vari dipinti in cui la dea viene ritratta nell’atto di specchiarsi. Chi guarda il dipinto ha l’impressione che Venere stia ammirando se stessa allo specchio; invece, dal momento che l’osservatore vede il volto di Venere riflesso, la dea sta scrutando non se stessa ma chi la guarda o il pittore che la ritrae. Alcuni esempi si ritrovano nei dipinti Venere allo specchio di Rubens, Venere e cupido di Velàzquez (noto anche come Venere Rokeby) o nella Venere allo specchio di Tiziano. Non solo divinità. Donne, uomini e animali sono ritratti utilizzando lo stesso espediente artistico. Un esempio è l’arazzo La dama e l’unicorno, dove a specchiarsi è l’unicorno.
Insomma lo specchio quando vuole inganna e porta e scompiglio.
Avviene anche in letteratura. Lo specchio è finito tra le pagine di racconti come Il naso di Gogol dove l’assessore collegiale Kovalëv si sveglia una mattina e scopre di non avere più il naso guardandosi in uno specchietto. E c’è uno specchio rivelatore di una doppia identità nel racconto gotico di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. C’è sempre uno specchio malandrino nel romanzo Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, nel quale il protagonista Vitangelo Moscarda constata che il suo naso pende verso destra guardandosi allo specchio. Inizia così: “Che fai? — mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio.
— Niente, — le risposi, — mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino…”. Da quel momento si scatena in Vitangelo Moscarda una crisi di identità. Si spalanca un abisso nel quale egli non sa più riconoscere se stesso. Nel catalogo non manca lo specchio magico di Alice, la creatura più celebre di Lewis Carroll. Il racconto si chiama Attraverso lo specchio e nasce come semplice seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie. La storia prende il via il 4 novembre, sei mesi dopo il viaggio della bambina nel Paese delle Meraviglie. Alice, sonnecchiando su una poltrona del suo salotto, si chiede cosa mai potrà esserci dall’altra parte dello specchio: riesce ad oltrepassarlo…
Tra gli specchi entrati nell’immaginario collettivo, c’è quello della Biancaneve dei fratelli Grimm. Qui lo specchio è parlante ed è servo delle brame della cattivissima regina Grimilde a cui svela l’esistenza di quella giovinetta più bella di lei con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l’ebano. Favole che da sempre accompagnano la narrazione intorno agli specchi.
Le suggestioni però arrivano anche da Madre Natura. Lo chiamano lo specchio del mondo. È il lago di sale che si trova in Bolivia e si chiama Salar de Uyuni. Ha una superficie piatta di 10.582 km² e si è formato a seguito della progressiva evaporazione di un lago salato. Quando piove, l’enorme distesa di sale si trasforma nello “specchio più grande del mondo”.
Chi l’ha visto racconta che di notte lo specchio naturale riflette il cielo stellato e di giorno – grazie ai riflessi della luce del sole – si ha come l’impressione di camminare nel cielo. Il sortilegio che tiene incatenati gli uomini agli specchi piani, curvi, convessi, naturali o artificiali è servito! Insieme alle illusioni.