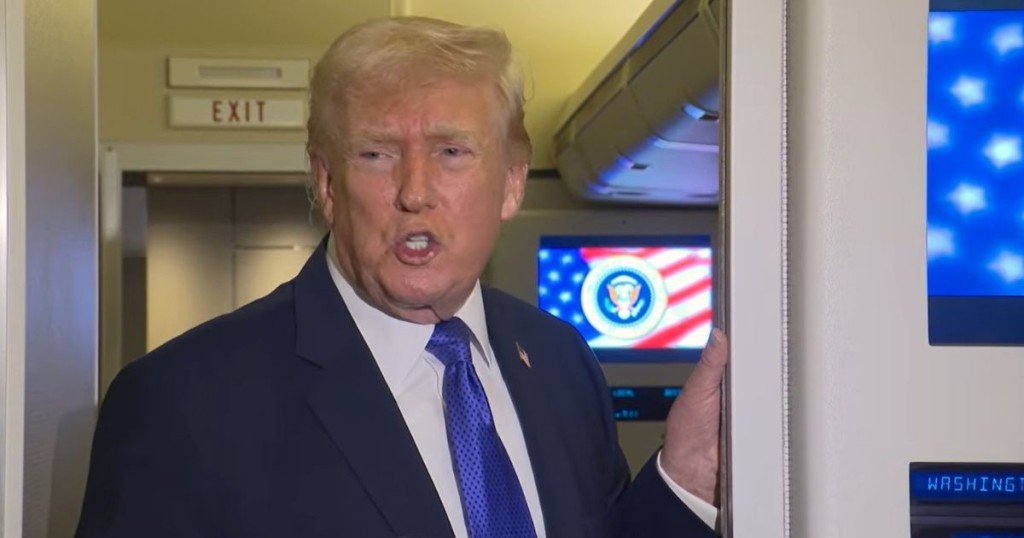Sono trascorsi 75 anni da quando, sulle pagine del quotidiano “l’Unità”, l’attore e commediografo Raffaele Viviani raccontò la sua prima Piedigrotta. Era bambino e scoppiò in lacrime svegliato all’improvviso dal chiasso della strada. Dal pianto passò allo stupore: “Che accadeva intorno a me? Niente: tutto quel clamore indicava che era una notte di festa, la più incredibile delle feste…Via Foria era come incendiata dai bagliori delle più avvampanti luminarie… Com’erano belli e festosi i carri di Piedigrotta. Anche le cavalcate, che imponenza! Quella di Carlo d’Angiò con tutto il seguito: cavalli bianchi, con gualdrappe reali e centinaia di valletti. La cavalcata coloniale era anch’essa di una fantasia incredibile” … La giuria era a piazza Sannazzaro, su un palco costellato da lampadine tricolori, pronta a giudicare, mentre dal mare i fuochi pirotecnici illuminavano centinaia di barche, ciascuna con una sua orchestrina a bordo e la sua comitiva. Non si sapeva più dove volgere lo sguardo, si era attoniti ad ammirare ogni cosa e si respirava la gioia di vivere, quella sera. Il mio popolo era come me, felice”.
A quei ricordi Viviani aveva dedicato nel 1919 “Festa di Piedigrotta”: che cosa poteva curare un po’ le ferite e il disorientamento della gente che aveva appena vissuto la prima guerra mondiale se non quella festa che sembrava gridare il bisogno di vivere? L’origine della festa settembrina è incerta. Probabilmente nacque da un rito pagano che si svolgeva fra il 7 e l’8 settembre, nel tunnel che la tradizione voleva scavato da Virgilio fra Mergellina e Fuorigrotta. Fu il viceré spagnolo Toledo a trasformare quel rito in una festa cristiana e a far costruire nel 1207, vicino all’ingresso del tunnel, un tempio alla Madonna (S. Maria dell’Itria) poi dedicato alla Natività della Vergine (oggi Chiesa della Madonna di Piedigrotta). Fu danneggiato nel 1343 da un maremoto e fu ricostruito nel 1353. Lì, popolo, sovrani angioini e aragonesi (e persino Garibaldi) si recarono ogni anno in processione l’8 settembre per celebrare la Natività della Vergine. Era bello vedere che il culto del popolo era onorato anche dai sovrani. Quando nel 1678, come si legge in una delle cronache di Innocenzio Fuidoro, il viceré spagnolo entrò solennemente nella Chiesa, fu salutato dai colpi a salve della fanteria e della cavalleria, schierate lungo la Riviera di Chiaia. La Piedigrotta fu organizzata ufficialmente soprattutto con il regno di Carlo III di Borbone, quando Napoli divenne capitale, e la ricorrenza acquisì lo status di festa nazionale e cominciò ad inserire nuove abitudini. Si affermò allora la pratica dei “maritaggi”: venti ragazze di umili origini erano sorteggiate per sfilare sui carri allegorici fino al Palazzo Reale per ricevere una dote dal sovrano. I carri erano realizzati grazie alle Corporazioni di Arti e Mestieri e proponevano sia personaggi della storia sia della tradizione napoletana. La festa aveva inizio con l’accensione delle luminarie per le strade. Anche i balconi erano addobbati e illuminati a festa. Per le strade di Napoli sfilavano i carri, fino al palco dei reali, in piazza del Plebiscito. La festa terminava con il “saccheggio” del carro da parte dei cittadini e la sua distruzione, sotto gli occhi divertiti dei sovrani.
Con il decennio francese, le parate furono interrotte. Con l’intento di comprendere l’origine di certe manifestazioni folcloristiche Napoleone diede inizio anche allo studio delle usanze popolari.
La festa fu ripristinata dai Borbone e cancellata con l’Unità d’Italia, per il forte legame con le tradizioni reali. L’8 settembre 1859 si era svolta l’ultima parata con 47 battaglioni, 33 squadre d’assalto e 64 pezzi d’artiglieria. Re Francesco II di Borbone fu salutato con varie cannonate dai cinque castelli della città.Nel 1867, quando Napoli fu colpita da un’epidemia di colera, ci fu qualche blando festeggiamento. Francesco Mastriani direttore della “Domenica” denunciò l’abbandonarsi del popolo “ai più deplorabili stravizi”. Dura a morire la tradizionale festa rinacque per iniziativa dei cittadini nel 1876. Con una raccolta di fondi, promossa dai rivenditori di giornali, furono organizzati il lungo il percorso dell’abituale pellegrinaggio fino alla Chiesa di Piedigrotta, le bancarelle di prodotti gastronomici e una banda musicale. Alla fine dell’Ottocento, cambiò volto: la nota più marcata delle celebrazioni settembrine non fu il popolo, la processione devozionistica ma la produzione musicale. Piedigrotta diveniva sempre più il festival della canzone. Bastò il successo nel 1880 di “Funiculì funicolà”, dedicata alla funivia del Vesuvio che aveva creato nei potenziali utenti molta diffidenza. Quel motivetto sciolse il ghiaccio: da una parte i cittadini cominciarono a usare la funivia dall’altra l’esercito di poeti e musicisti si arruolò per una nuova causa, creare la migliore canzone per la Piedigrotta. La festa divenne un affare commerciale che coinvolse anche editori come Sonzogno, Ricordi, Bideri e discografici. Pubblicarono numeri speciali e album con testi e spartiti delle “canzoni di Piedigrotta”, alcune delle quali divennero successi internazionali. All’alba del Novecento Piedigrotta era diventata sinonimo di festa della canzone napoletana. Tuttavia il legame forte con il territorio, che aveva attraversato dominazioni straniere, epidemie ed eruzioni del Vesuvio, resisteva. Persino durante l’eruzione del 1906 la città volle onorare la Madonna di Piedigrotta, con le celebrazioni liturgiche e la consueta processione popolare. Nelle altre città del mondo cominciò a giungere l’eco della Piedigrotta, Arrivò anche al periodico inglese “The graphic” che il 13 settembre 1902 pubblicò un’illustrazione all’evento. Mentre erano fiorite le riviste musicali che pubblicavano spartiti e testi, “La Tribuna illustrata”, rivista romana che aveva già dedicato una copertina alla Piedigrotta nel 1893, tornò a occuparsi di questa festa nel 1902 e nel 1907: “Chi non ha assistito mai a questo singolarissimo avvenimento non può avere nemmeno una pallida idea del pandemonio oltremodo simpatico che regna a Piedigrotta e che si diffonde entro e fuori della grotta detta di Pozzuoli e lungo tutta l’aristocratica immensa Riviera di Chiaia”, si legge nel n. del 14 settembre 1902, anno in cui “uno degli spettacoli dei più belli che possa dare l’anima napoletana” vide accendersi le prime luminarie a elettricità. È stata ed è una festa dai mille volti.
L’essenza è tuttavia nell’aspetto aggregativo dell’evento. Un aspetto ereditato dal periodo in cui sovrani e popolo si ritrovavano in piazza insieme. Ma è anche vero che riflette i tempi, i suoi gusti. Unico fil rouge la religiosità tipicamente popolare: la sfilata di bambini con i vestitini di carta ad aprire la processione solenne. Il culto per la Madonna di Piedigrotta, come quello per S. Gennaro e S. Maria Francesca, occupa da secoli il cuore dei semplici. Un legame indissolubile. Anche quando le cerimonie ufficiali furono abolite, dal 1983 al 2006, il tempio di Piedigrotta si riempiva comunque di fedeli. “Questa festa è una notte e basta. Diciamo dalle otto di sera alle quattro del mattino, il volerla trascinare per 3-4 giorni, come la intendono spesso certe autorità e certe organizzazioni, è una sciocchezza che non passerebbe mai per la testa di un acuto conoscitore del popolo partenopeo – scrisse agli inizi degli anni Sessanta, sulla “Nazione” di Firenze il giornalista napoletano Salvatore Rea – Piedigrotta si fa con la gente, la fa la gente. E questa gente si accende una sola volta, come un fuoco di artificio. Brucia in cielo da miniatura, con la luna che scodinzola raggi sopra il Golfo, sino all’esaurimento, sprizza ombrelli di gioia tra Mergellina e Santa Lucia, pianta bengala multicolori sopra gli scogli di Posillipo, poi si affloscia nell’ultima esplosione, quella che fa tremare i vetri delle case fino a Portici e oltre, e ricade in cenere per le strade … Eccolo il miracolo di Piedigrotta, chiudi e riapri gli occhi e la scena è mutata”.